
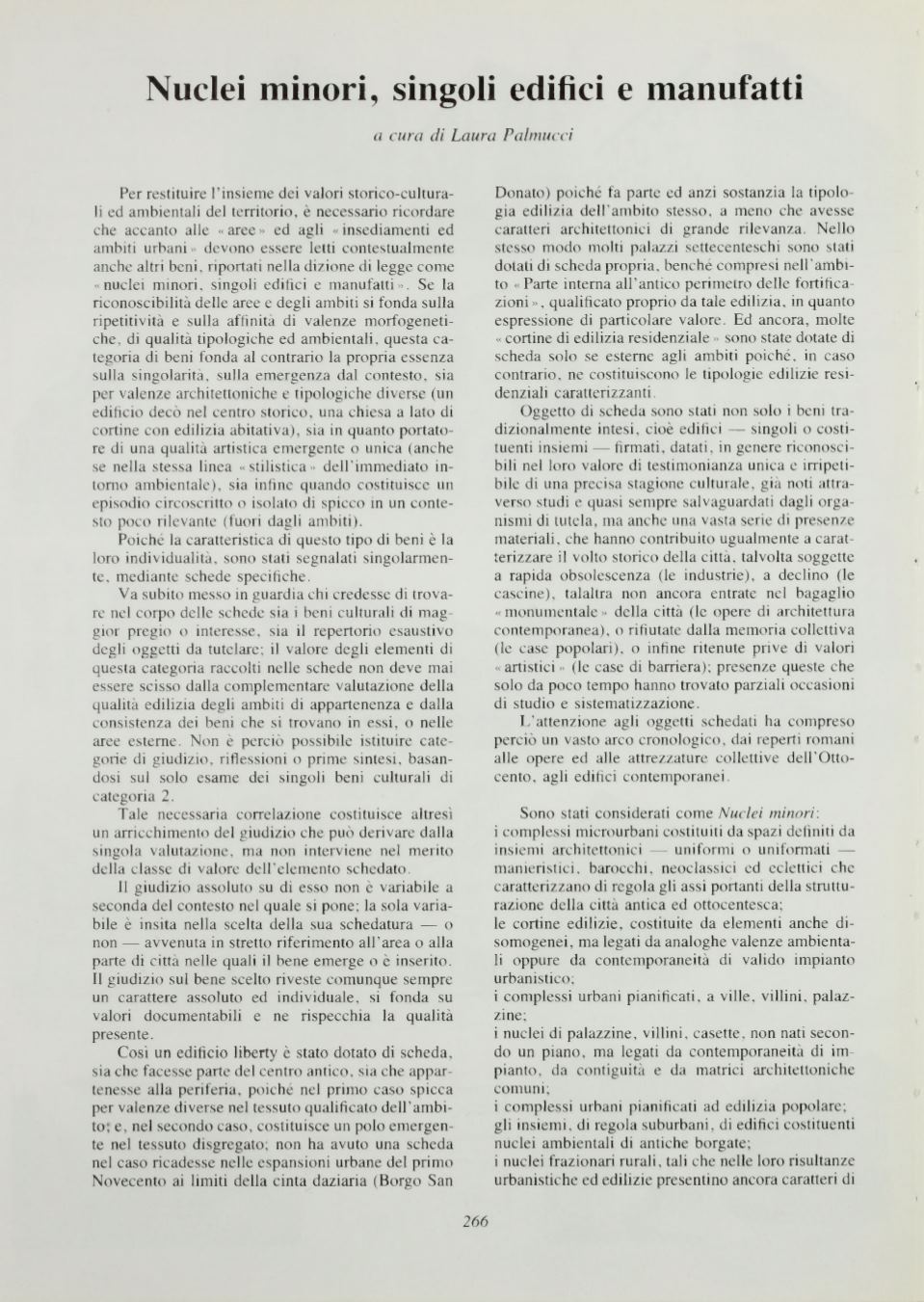
Nuclei minori, singoli edifici e manufatti
a
cura
di Laura Palmucci
Per restituire l'insieme dei valori storico-cultura-
li ed ambientali del territorio, è necessario ricordare
che accanto alle « aree » ed agli « insediamenti ed
ambiti urbani » devono essere letti contestualmente
anche altri beni, riportati nella dizione di legge come
« nuclei minori, singoli edifici e manufatti » . Se la
riconoscibilità delle aree e degli ambiti si fonda sulla
ripetitività e sulla affinità di valenze morfogeneti-
che, di qualità tipologiche ed ambientali, questa ca-
tegoria di beni fonda al contrario la propria essenza
sulla singolarità, sulla emergenza dal contesto, sia
per valenze architettoniche e tipologiche diverse (un
edificio decò nel centro storico, una chiesa a lato di
cortine con edilizia abitativa), sia in quanto portato-
re di una qualità artistica emergente o unica (anche
se nella stessa linea « stilistica » dell'immediato in-
torno ambientale), sia infine quando costituisce un
episodio circoscritto o isolato di spicco in un conte-
sto poco rilevante (fuori dagli ambiti).
Poiché la caratteristica di questo tipo di beni è la
loro individualità, sono stati segnalati singolarmen-
te, mediante schede specifiche.
Va subito messo in guardia chi credesse di trova-
re nel corpo delle schede sia i beni culturali di mag-
gior pregio o interesse, sia il repertorio esaustivo
degli oggetti da tutelare; il valore degli elementi di
questa categoria raccolti nelle schede non deve mai
essere scisso dalla complementare valutazione della
qualità edilizia degli ambiti di appartenenza e dalla
consistenza dei beni che si trovano in essi, o nelle
aree esterne. Non è perciò possibile istituire cate-
gorie di giudizio, riflessioni o prime sintesi, basan-
dosi sul solo esame dei singoli beni culturali di
categoria 2.
Tale necessaria correlazione costituisce altresì
un arricchimento del giudizio che può derivare dalla
singola valutazione, ma non interviene nel merito
della classe di valore dell'elemento schedato.
II giudizio assoluto su di esso non è variabile a
seconda del contesto nel quale si pone; la sola varia-
bile è insita nella scelta della sua schedatura o
non avvenuta in stretto riferimento all'area o alla
parte di città nelle quali il bene emerge o è inserito.
Il giudizio sul bene scelto riveste comunque sempre
un carattere assoluto ed individuale, si fonda su
valori documentabili e ne rispecchia la qualità
presente.
Così un edificio libe
rt
y è stato dotato di scheda,
sia che facesse parte del centro antico, sia che appar-
tenesse alla periferia, poiché nel primo caso spicca
per valenze diverse nel tessuto qualificato dell'ambi-
to;
e,
nel secondo caso, costituisce un polo emergen-
te nel tessuto disgregato; non ha avuto una scheda
nel caso ricadesse nelle espansioni urbane del primo
Novecento ai limiti della cinta daziaria (Borgo San
Donato) poiché fa parte ed anzi sostanzia la tipolo-
gia edilizia dell'ambito stesso, a meno che avesse
caratteri architettonici di grande rilevanza. Nello
stesso modo molti palazzi settecenteschi sono stati
dotati di scheda propria, benché compresi nell'ambi-
to «Parte interna all'antico perimetro delle fortifica-
zioni», qualificato proprio da tale edilizia, in quanto
espressione di particolare valore. Ed ancora, molte
« cortine di edilizia residenziale » sono state dotate di
scheda solo se esterne agli ambiti poiché, in caso
contrario, ne costituiscono le tipologie edilizie resi-
denziali caratterizzanti.
Oggetto di scheda sono stati non solo i beni tra-
dizionalmente intesi, cioè edifici — singoli o costi-
tuenti insiemi firmati, datati, in genere riconosci-
bili nel loro valore di testimonianza unica e irripeti-
bile di una precisa stagione culturale, già noti attra-
verso studi e quasi sempre salvaguardati dagli orga-
nismi di tutela, ma anche una vasta serie di presenze
materiali, che hanno contribuito ugualmente a carat-
terizzare
il
volto storico della città, talvolta soggette
a rapida obsolescenza (le industrie), a declino (le
cascine), talaltra non ancora entrate nel bagaglio
« monumentale » della città (le opere di architettura
contemporanea), o rifiutate dalla memoria collettiva
(le case popolari), o infine ritenute prive di valori
«artistici » (le case di barriera); presenze queste che
solo da poco tempo hanno trovato parziali occasioni
di studio e sistematizzazione.
L'attenzione agli oggetti schedati ha compreso
perciò un vasto arco cronologico, dai reperti romani
alle opere ed alle attrezzature collettive dell'Otto-
cento, agli edifici contemporanei.
Sono stati considerati come
Nuclei minori:
i complessi microurbani costituiti da spazi definiti da
insiemi architettonici
uniformi o uniformati
manieristici, barocchi, neoclassici ed eclettici che
caratterizzano di regola gli assi portanti della struttu-
razione della città antica ed ottocentesca;
le cortine edilizie, costituite da elementi anche di-
somogenei, ma legati da analoghe valenze ambienta-
li oppure da contemporaneità di valido impianto
urbanistico;
i complessi urbani pianificati, a ville, villini, palaz-
zine;
i nuclei di palazzine, villini, casette, non nati secon-
do un piano, ma legati da contemporaneità di im-
pianto, da contiguità e da matrici architettoniche
comuni;
i complessi urbani pianificati ad edilizia popolare;
gli insiemi, di regola suburbani, di edifici costituenti
nuclei ambientali di antiche borgate;
i nuclei frazionari rurali, tali che nelle loro risultanze
urbanistiche ed edilizie presentino ancora caratteri di
266


















