
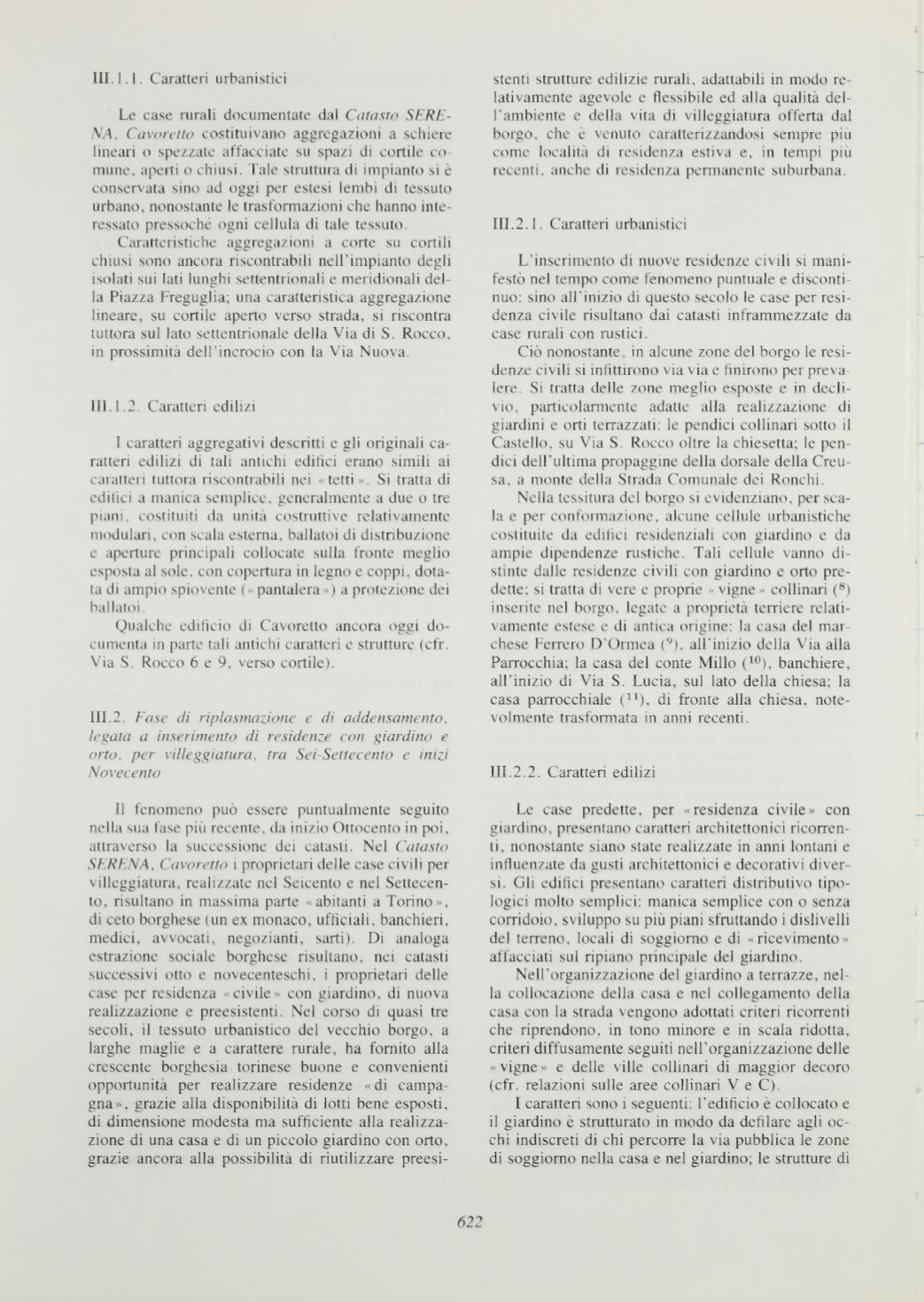
III. 1.1.
Caratteri urbanistici
Le case rurali documentate dal
Catasto SERE-
NA, Cavoretto
costituivano aggregazioni a schiere
lineari o spezzate affacciate su spazi di cortile co-
mune, aperti o chiusi. Tale struttura di impianto si
è
conservata sino ad oggi per estesi lembi di tessuto
urbano, nonostante le trasformazioni che hanno inte-
ressato pressoché ogni cellula di tale tessuto.
Caratteristiche aggregazioni a corte su cortili
chiusi sono ancora riscontrabili nell'impianto degli
isolati sui lati lunghi settentrionali e meridionali del-
la Piazza Freguglia; una caratteristica aggregazione
lineare, su cortile aperto verso strada, si riscontra
tuttora sul lato settentrionale della Via di S. Rocco,
in prossimità dell'incrocio con la Via Nuova.
111.1 .2. Caratteri edilizi
I caratteri aggregativi descritti e gli originali ca-
ratteri edilizi di tali antichi edifici erano simili ai
caratteri tuttora riscontrabili nei « tetti ». Si tratta di
edifici a manica semplice, generalmente a due o tre
piani, costituiti da unità costruttive relativamente
modulari, con scala esterna, ballatoi di distribuzione
e aperture principali collocate sulla fronte meglio
esposta al sole, con copertura in legno e coppi, dota-
ta di ampio spiovente («pantalera») a protezione dei
ballatoi.
Qualche edificio di Cavoretto ancora oggi do-
cumenta in parte tali antichi caratteri e strutture (cfr.
Via S. Rocco 6 e 9, verso cortile).
1II.2.
Fase di riptasmazione e di addensamento,
tegata a inserimento di residenze con giardino e
orto, per vilteggiatura, tra Sei-Settecento
e
inizi
Novecento
Il fenomeno può essere puntualmente seguito
nella sua fase più recente, da inizio Ottocento in poi,
attraverso la successione dei catasti. Nel
Catasto
SERENA, Cavoretto
i proprietari delle case civili per
villeggiatura, realizzate nel Seicento e nel Settecen-
to, risultano in massima parte « abitanti a
Torino»,
di ceto borghese (un ex monaco, ufficiali, banchieri,
medici, avvocati, negozianti, sarti). Di analoga
estrazione sociale borghese risultano, nei catasti
successivi otto
e
novecenteschi, i proprietari delle
case per residenza «civile» con giardino, di nuova
realizzazione e preesistenti. Nel corso di quasi tre
secoli, il tessuto urbanistico del vecchio borgo, a
larghe maglie e a carattere rurale, ha fornito alla
crescente borghesia torinese buone e convenienti
opportunità per realizzare residenze « di campa-
gna», grazie alla disponibilità di lotti bene esposti,
di dimensione modesta ma sufficiente alla realizza-
zione di una casa e di un piccolo giardino con orto,
grazie ancora alla possibilità di riutilizzare preesi-
stenti strutture edilizie rurali, adattabili in modo re-
lativamente agevole e flessibile ed alla qualità del-
l'ambiente e della vita di villeggiatura offerta dal
borgo, che è venuto caratterizzandosi sempre più
come località di residenza estiva e, in tempi più
recenti, anche di residenza permanente suburbana.
III.2.1.
Caratteri urbanistici
L'inserimento di nuove residenze civili si mani-
festò nel tempo come fenomeno puntuale e disconti-
nuo: sino all'inizio di questo secolo le case per resi-
denza civile risultano dai catasti inframmezzate da
case rurali con rustici.
Ciò nonostante, in alcune zone del borgo le resi-
denze civili si infittirono via via e finirono per preva-
lere. Si tratta delle zone meglio esposte e in decli-
vio, particolarmente adatte alla realizzazione di
giardini e orti terrazzati: le pendici collinari sotto il
Castello, su Via S. Rocco oltre la chiesetta; le pen-
dici dell'ultima propaggine della dorsale della Creu-
sa, a monte della Strada Comunale dei Ronchi.
Nella tessitura del borgo si evidenziano, per sca-
la e per conformazione, alcune cellule urbanistiche
costituite da edifici residenziali con giardino e da
ampie dipendenze rustiche. Tali cellule vanno di-
stinte dalle residenze civili con giardino e orto pre-
dette; si tratta di vere e proprie « vigne » collinari (
8
)
inserite nel borgo, legate a proprietà terriere relati-
vamente estese e di antica origine: la casa del mar-
chese Ferrero D'Ormea (
9
), all'inizio della Via alla
Parrocchia; la casa del conte Millo (
1
o), banchiere,
all'inizio di Via S. Lucia, sul lato della chiesa; la
casa parrocchiale (il), di fronte alla chiesa, note-
volmente trasformata in anni recenti.
III.2.2. Caratteri edilizi
Le case predette, per «residenza civile» con
giardino, presentano caratteri architettonici ricorren-
ti, nonostante siano state realizzate in anni lontani e
influenzate da gusti architettonici e decorativi diver-
si. Gli edifici presentano caratteri distributivo tipo-
logici molto semplici: manica semplice con o senza
corridoio, sviluppo su più piani sfruttando i dislivelli
del terreno, locali di soggiorno e di «ricevimento»
affacciati sul ripiano principale del giardino.
Nell'organizzazione del giardino a terrazze, nel-
la collocazione della casa e nel collegamento della
casa con la strada vengono adottati criteri ricorrenti
che riprendono, in tono minore e in scala ridotta,
criteri diffusamente seguiti nell'organizzazione delle
« vigne » e delle ville collinari di maggior decoro
(cfr. relazioni sulle aree collinari V e C).
I caratteri sono i seguenti: l'edificio è collocato e
il giardino è strutturato in modo da defilare agli oc-
chi indiscreti di chi percorre la via pubblica le zone
di soggiorno nella casa e nel giardino; le strutture di
622


















