
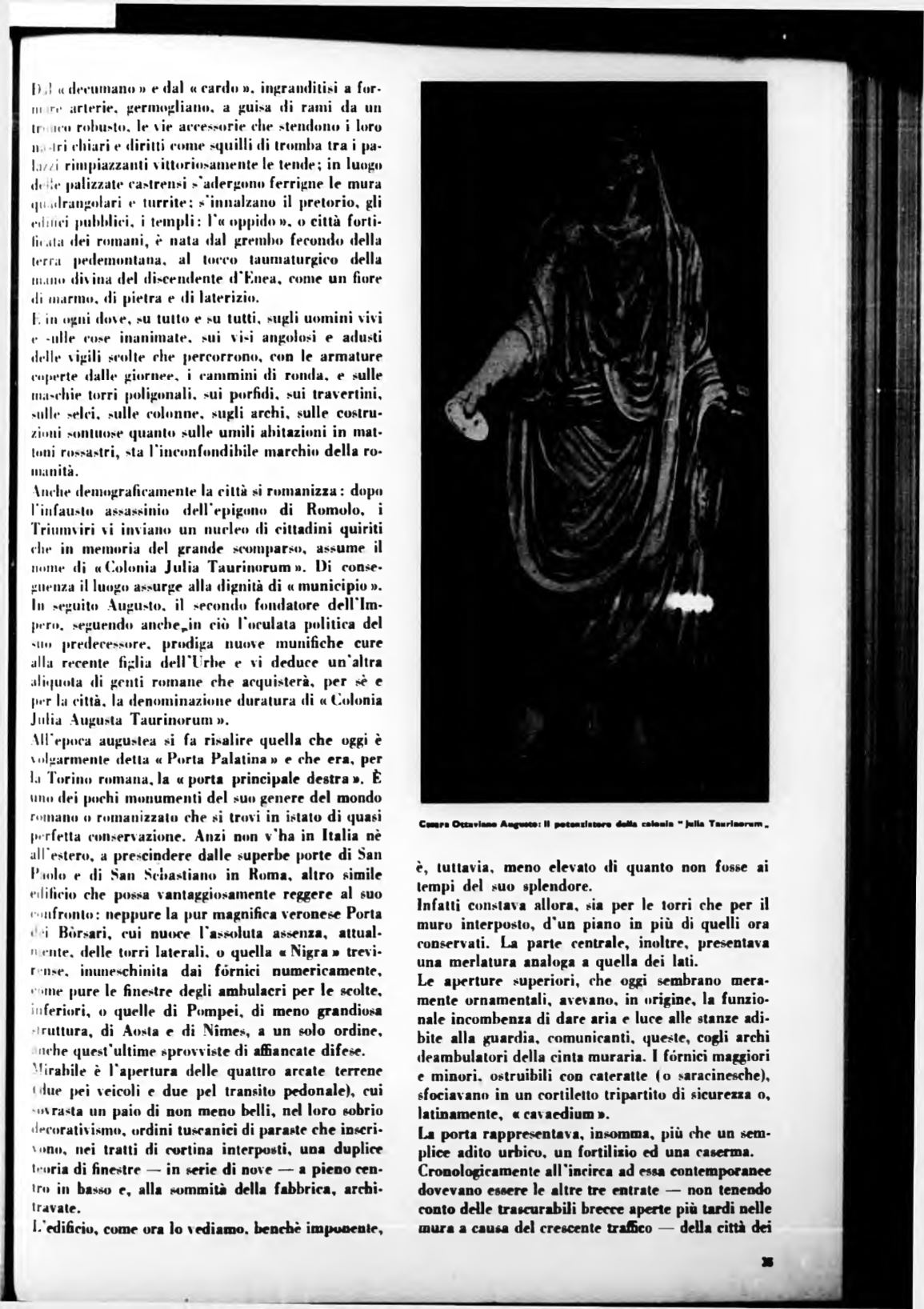
I) ,1 (t decumano » e dal » cardo ». ingranditisi a for
ni
rr
arterie, germogliano, a guisa ili rami da un
Ir no robusto. Ir vie accessorie die stendono i loro
n iri ciliari e diritti come squilli di tromba tra i pa
la//i rimpiazzanti vittoriosamente le tende; in luogo
ili
ir
palizzate castrensi s'adergono ferrigne le mura
ipuilrangolari r turrite; s'innalzano il pretorio, gli
rifilici
pubblici, i templi: l*« oppido », o città forti-
lir.ita
dei romani,
è
nata dal grembo fecondo della
Irrra
pedemontana, al tocco taumaturgico della
mano
divina del discendente d'Knea, come un fiore
ili
marmo, di pietra e di laterizio.
Il in o<:ui dove, su tutto e su tutti, sugli uomini vivi
r -ulle cose inanimate, sui visi angolosi e adusti
tirile \igili scolte cbe percorrono, con le armature
coperte dalle giornee, i cammini di ronda, e sulle
ma'cliie torri poligonali, sui porfidi, sui travertini,
Millr >elci, .«ulle colonne, sugli archi, sulle costru
zioni sontuose quanto sulle umili abitazioni in mat
toni rossastri, sta l'inconfondibile marchio della ro
manità.
Anrbe demograficamente la città si romanizza: dopo
l'infausto assassiniti dell'epigono di Romolo, i
Triumviri vi inviami un nucleo di cittadini quiriti
rlir in memoria del grande scomparso, assume il
nome di «Colonia Ju lia Taurinorum». Di conse
guenza il luogo assurge alla dignità di « municipio ».
In seguito Augusto, il secondo fondatore dell'im
pero. seguendo anebe^in ciò l'oculata politica del
'ilo predecessore, prodiga nuove munifiche cure
alla recente figlia deU'Urbe e vi deduce un'altra
aliquota tli genti romane che acquisterà, per sè e
prr la città, la denominazione duratura di « Colonia
Julia Augusta Taurinorum».
All'epoca augustea si fa risalire quella che oggi è
volgarmente detta « Porta Palatina» e che era, per
la Torino romana, la « porta principale destra ». È
mio dei pochi monumenti del suo genere del mondo
romano o romanizzato che si trovi in istato di quasi
perfetta conservazione. Anzi non v'ha in Italia nè
all'estero, a prescindere dalle superbe porte di San
Piolo e di San Sebastiano in Roma, altro simile
edificio che possa vantaggiosamente reggere al suo
confronto: neppure la pur magnifica veronese Porta
i Borsari, cui nuiwe l'assoluta assenza, attual-
n rute, delle torri laterali, o quella a Migra » trevi-
r
'lise,
inuneschinita dai fornici numericamente,
r «me pure le finestre degli ambulacri per le scolte,
inferiori, o quelle di Pompei, di meno grandiosa
bruttura, di Aosta e di Nimes, a un solo ordine,
urbe quest'ultime sprovviste di affiancate difese.
Mirabile è l'apertura delle quattro arcate terrene
•lue pei veicoli e due pel transito pedonale), cui
'o\rasta un paio di non meno belli, nel loro sobrio
decorativismo, ordini tuscanici di paraste che inseri
amo, nei tratti di cortina interposti, una duplice
teoria di finestre — in serie di nove — a pieno cen
tro
in basso e, alla sommità della fabbrica, archi
travate.
I- edificio, come ora lo vediamo. benché imponente,
C— r» O ttaviano A f U l II pot oo«lat r o 4olla colonia - folla Taurinorum M
è, tuttavia, meno elevato di quanto non fosse ai
tempi del suo splendore.
Infatti constava allora, sia per le torri che per il
muro interposto, d'un piano in più di quelli ora
conservati. La parte centrale, inoltre, presentava
una merlatura analoga a quella dei lati.
Le aperture superiori, che oggi sembrano mera
mente ornamentali, avevano, in origine, la funzio
nale incombenza di dare aria e luce alle stanze adi
bite alla guardia, comunicanti, queste, cogli archi
deambulatori della cinta muraria. I fòrnici maggiori
e minori, ostruibili con cateratte (o saracinesche),
sfociavano in un cortiletto tripartito di sicurezza o,
latinamente, « cavaedium ».
La porta rappresentava, insomma, più che un sem
plice adito urbico, un fortilizio ed una caserma.
Cronologicamente all'incirca ad essa contemporanee
dovevano essere le altre tre entrate — non tenendo
conto delle trascurabili brecce aperte più tardi nelle
mura a causa del crescente traffico — della città dei
SI


















