
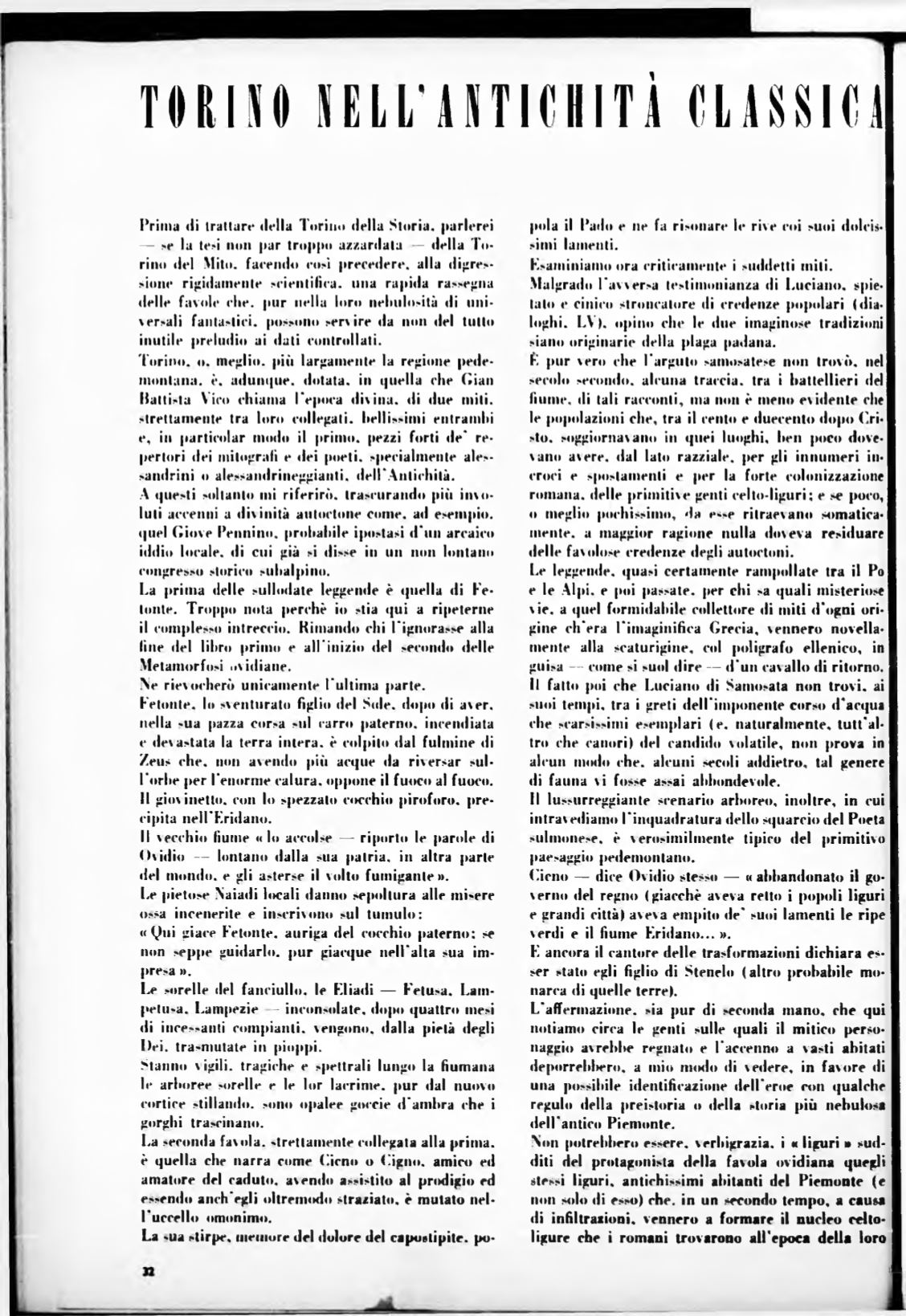
TOItlIO NELL'ANTICHITÀ CLASSICI
Prima di trattar»* «lolla Torino della Storia, parlerei
— se la tesi non par troppo azzardata — della Fo
rino del Mito, facendo cosi precedere, alla digres
sione ripidamente scientifica, una rapida rassegna
delle favole che. pur nella loro nebulosità di uni
versali fantastici, possono servire da non del tutto
inutile preludio ai dati controllati.
Torino, o. meglio, più largamente la regione pede
montana.
è .
adunque, dotata, in quella che Gian
battista Vico chiama l'epoca divina, di due miti,
strettamente tra loro collegati,
bellissimi
entrambi
e, in {«articolar modo il primo, pezzi forti de* re
pertori dei mitogralì e dei poeti, specialmente ales
sandrini o alessandrineggianti, dcU'Autichità.
A questi soltanto mi riferirò, trascurando più invo
luti accenni a div inità autoctone come, ad esempio,
quel Giove Pennino, probabile ipostasi d'un arcaico
iddio locale, di cui già si disse iu un non lontani»
congresso storico subalpino.
La prima delle sullodate leggende è quella di Fe
tonte. Troppo nota perchè io stia <|ui a ripeterne
il complesso intreccio. Rimando chi l'ignorasse alla
fine del libro primo e all'inizio del secondo delle
Metamorfosi ovidiane.
IVe rievocherò unicamente l'ultima parte.
Fetonte, lo sventurato figlio del Side, dopo di aver,
nella «ua pazza corsa
sul
carro paterno, incendiata
e devastata la terra intera, è colpito dal fulmine di
Zeus che, non avendo più acque da riversar sul
l'orbe per l'enorme calura, oppone il fuoco al fuoco.
Il giovinetto, con lo spezzato cocchio piroforo, pre
cipita neH'Eridano.
Il vecchio fiume « lo accolse — riporto le parole di
Ovidio — lontano dalla sua patria, in altra parte
del mondo, e gli asterse il volto fumigante».
Le pietose Naiadi locali danno sepoltura alle misere
ossa incenerite e inscrivono sul tumulo:
«Qui giace Fetonte, auriga del cocchio paterno; se
non seppe guidarlo, pur giacque neH'alta sua im
presa ».
Le sorelle del fanciullo, le Kliadi — Fetusa. Lam-
petu-a. Lampezie — inconsolate, dopo quattro mesi
di incessanti compianti, vengono, dalla pietà degli
Dei. trasmutate in pioppi.
Stanno vigili, tragiche e spettrali lungo la fiumana
le arboree sorelle e le lor lacrime, pur dal nuovo
corticc stillando, sono opalee goccie d'ambra che i
gorghi trascinano.
La seconda favola, •trettamente collegata alla prima,
è quella che narra come Cimo o Cigno, amico ed
amatore del caduto, avendo assistito al prodigio ed
essendo anch'egli oltremodo straziato, è mutato nel
l'uccello omonimi».
La «uà stirpe, memore del dolore del capostipite, po
pola il Pado e ne fa risonare le rive coi suoi dolcis
simi lamenti.
Esaminiamo ora criticamente i suddetti miti.
Malgrado l'avversa testimonianza di Luciano, spie
tato e cinico stroncatore di credenze popolari (dia
loghi. LY ), opino che le due imaginose tradizioni
siano originarie della plaga padana.
E pur vero che l'arguto samosatese non trovò, nel
secolo secondo, alcuna traccia, tra i battellieri del
fiume, ili tali racconti, ma non è meno evidente che
le popolazioni che, tra il cento e duecento dopo ('ri
sto.
soggiornavano iu quei luoghi, ben poco dove
vano avere, dal lato razziale, per gli innumeri in
croci e spostamenti e per la forte colonizzazione
romana, delle primitive genti celto-liguri; e se poco,
o meglio pochissimo, da e«se ritraevano somatica
mente. a maggior ragione nulla doveva residuare
delle favolose credenze degli autoctoni.
Le leggende, quasi certamente rampollate tra il Po
e le Alpi, e poi passate, per chi sa quali misteriose
v ie. a quel formidabile collettore di miti d'ogni ori
gine ch'era l'imaginifica Grecia, vennero novella-
mente alla scaturigine, col poligrafo ellenico, in
guisa — come si suol dire — d’un cavallo di ritorno.
Il fatto poi che Luciano di Samosata non trovi, ai
suoi tempi, tra i greti dell'imponente corso d'acqua
che scarsissimi esemplari (e. naturalmente, tutt'al-
tro che canori) del candido volatile, non prova in
alcun modo che. alcuni secoli addietro, tal genere
di fauna vi fosse assai abbondevole.
Il lussiirreggiante scenario arboreo, inoltre, in cui
intravediamo l'inquadratura dello squarcio del Poeta
sulmonese, è verosimilmente tipico del primitivo
paesaggio pedemontano.
Cicno — dice Ovidio stesso — « abbandonato il go
verno del regno (giacché aveva retto i popoli liguri
e grandi città) aveva empito de' suoi lamenti le ripe
verdi e il fiume Eridano... ».
E ancora il cantore delle trasformazioni dichiara es
ser stato egli figlio di Stenelo (altro probabile mo
narca di quelle terre).
L'affermazione, sia pur di seconda mano, che qui
notiamo circa le genti sulle quali il mitico perso
naggio avrebbe regnato e l'accenno a vasti abitati
deporrebbero, a mio modo di vedere, in favore di
una possibile identificazione dell'eroe con qualche
regulo della preistoria o della storia più nebulosa
dell'antico Piemonte.
!Non potrebbero essere, \erbigrazia. i « liguri » sud
diti del protagonista della favola ovidiana quegli
stessi liguri, antichissimi abitanti del Piemonte (e
non solo di esso) che. in un secondo tempo, a causa
di infiltrazioni, vennero a formare il nucleo cello-
ligure che i romani trovarono all'epoca della loro


















