
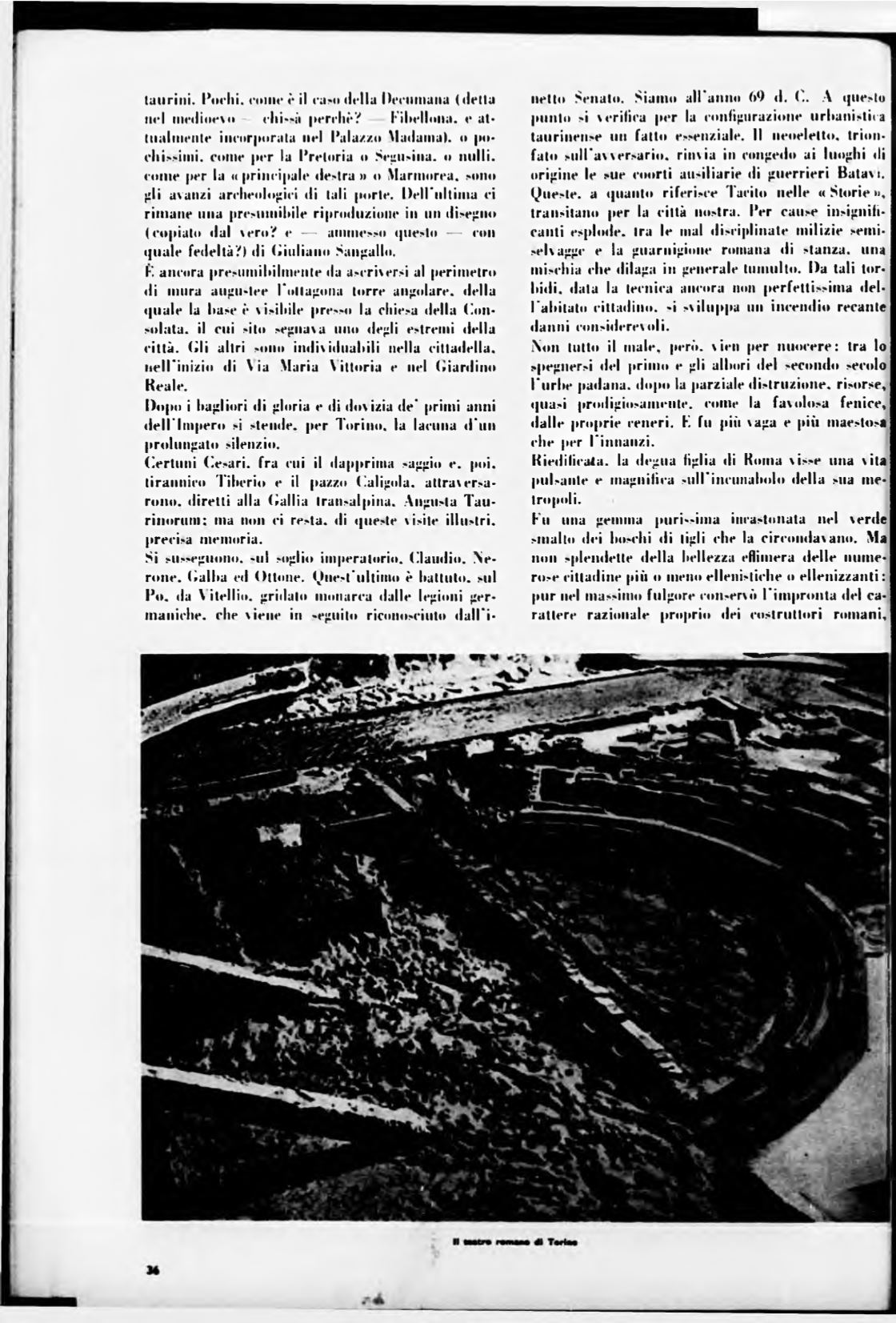
taurini. Pochi, mine è il caso drlla Decumana (detta
nel medioevo — chissà perchè ?
Fihellona. e at-
tiialmente incorporata nel Palazzo Madama), o po
chissimi. come per ia Pretoria o Sepusina. o nulli,
come per la « principale destra » o Marmorea, sono
jzli avanzi archeologici di tali porte. Deirultima ci
rimane una prcsuiuihile riproduzione in un disegno
(copiato dal vero? e — ammesso questo — con
quale fedeltà?) di Giuliano Sandali»».
K ancora presumibilmente da ascriversi al perimetro
di mura aupustee l'ottapona torre angolare, della
quale la base è visibile presso la chiesa della Con
solata. il cui
sito
segnava uno depli estremi della
città. Gli altri
s o n o
individuabili nella cittadella,
nell*inizi<» di \ ia Maria \ ittoria e nel (riardimi
Reale.
Dopo i bagliori di gloria e di dovizia de' primi anni
dell'impero si stende, per Torino, la lacuna d‘un
prolungato silenzio.
Certuni Cesari, fra cui il dapprima sappio e. poi,
tirannico Tiberio e il pazzo Calinola, attraversa
rono. diretti alla Callia transalpina. Analista Tau-
rinom ili; ma non ci resta, di queste visite illustri,
precisa memoria.
Si susseguono, «ul sopìio imperatorio. Claudio. Ne
rone. Calba ed Ottone. (Quest'ultimo è battuto, sul
Po. da \ itellio. prillato monarca dalle lepioni per-
maniche, che viene iu «epuito riconosciuto dall *i
netto Senato. Siamo alTanno 60 d. C. A questo
punto si verifica per la eonfipurazione urbanistica
taurinense mi fatto essenziale. Il neoeletto, trion
fato suH'avversario, rinvia in conpedo ai luophi di
oripine le sue coorti ausiliarie di puerrieri Baiavi.
(Queste, a quanto riferisce Tacito nelle « Storie »,
transitano per la città nostra. Per cause insipidii-
cauti esplode. Ira le mal disciplinate milizie semi-
selvappc e la puarnipione romana di stanza, una
mischia che dilapa ili penerale tumulto. Da tali tor
bidi. data la tecnica ancora non perfettissima del
l'abitato cittadino, «i sviluppa un incendio recante
danni considerevoli.
Non tutto il male, però, vien per nuocere: tra lo
spepnersi del primo e pii albori del secondo secolo
l'urbe padana, dopo la parziale distruzione, risorse,
quasi prodipiosameute. come la favolosa fenice,
dalle proprie ceneri. K fu più vapa e più maestosa
che per l'innanzi.
Riedificala, la depua fiplia ili Roma visse una vita
pulsante e inapnifica stdl'incunabolo della sua me
tropoli.
hu una peuima purissima incastonata nel verde
smalto dei boschi di lipli che la circondavano. Ma
non splendette della bellezza effimera delle nume
rose cittadine più o metto ellenistiche o ellenizzanti:
pur nel massimo fulpore conservò l'impronta del ca
rattere razionale proprio dei costruttori romani.


















