
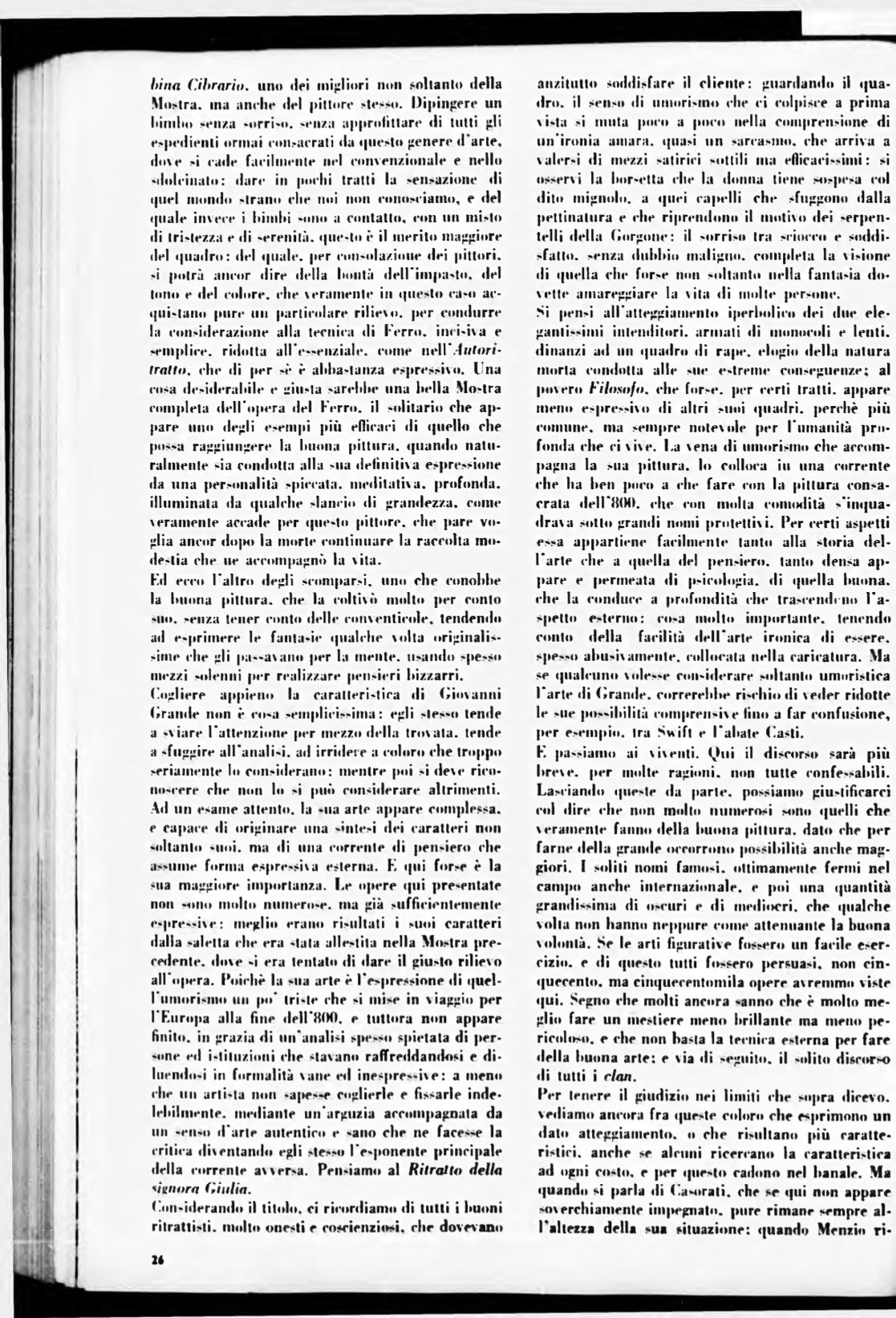
Itinn C.ihrarùt. uno dei migliori non soltanto della
Mostra, ina anche del pittore stesso. Dipingere un
hiiuho senza sorriso, senza approfittare di tutti gli
espedienti ormai consacrati da questo genere d arte,
do\e si cade facilmente nel convenzionale e nello
sdolcinato: dare in pochi tratti la sensazione di
quel inondo strano che noi non conosciamo, e del
«piale invece i hinihi sono a contatto, con un misto
di tristezza e di serenità, questo è il merito maggiore
tlel quadro: del quale, per consola/.ioue dei pittori,
si potrà ancor dire della houtà dell'impasto, del
tono e del colore, che veramente in questo caso ac
quistano pure un particolare rilievo, per condurre
la considerazione alla tecnica «li Ferri», imi-iva e
semplice, ridotta all'essenziale, come nell'/liifori-
tratto. che di per si* è abbastanza espressivo. Una
cosa desiderabile e giusta sarchiti* una bella Mo«tra
completa dell'opera del Ferro, il solitario che ap
pare uno degli esempi più efficaci di quello che
possa raggiungere la buona pittura, quando natu
ralmente sia condotta alla sua definitiva espressione
da una personalità spiccata, meditativa, profonda,
illuminata da qualche slancio di grandezza, coinè
veramente accade per questo pittore, che pare vo
glia ancor iIo|m» la morte continuare la raccolta mo
destia che ue accompagnò la vita.
Ed ecco l’altro degli scomparsi, uno che conobbe
la buona pittura, che la coltivò molto per conto
silo, senza tener conto delle conventicole, tendendo
ad esprimere le fantasie qualche volta originalis
sime che fili passavano per la mente, usando spesso
mezzi solenni per realizzare pensieri bizzarri.
Cogliere appieno la caratteristica di Giovanni
Grande non è cosa semplicissima: egli stesso tende
a sviare l’attenzione per mezzo della trovata, tende
a sfuggire all’analisi, ad irridete a coloro che troppi»
seriamente lo considerano: mentre poi si deve rico
noscere che non lo si può considerare altrimenti.
Ad un esame attento, la -uà arte appare complessa,
e capace di originare una sintesi dei caratteri non
soltanto suoi, ma di una corrente di pensiero che
assume forma espressiva esterna. E qui forse è la
sua maggiore importanza. Le opere qui presentate
non sono molto numerose, ma già sufficientemente
espre*sive: meglio erano risultati i suoi caratteri
dalla «aletta che era -tata allestita nella Mostra pre
cedente. dove si era tentato di dare il giusto rilievo
all’opera. Poiché la sua arte è l'espressione di quel
l'umorismo mi po’ triste che si mise in viaggio per
l'Europa alla fine dell'KOO. e tuttora non appare
finito, in grazia di un’analisi spesso spietata di per
sone ed istituzioni che stavano raffreddandosi e di
luendoci in formalità vane ed inespressive: a meno
che ii ii art i'ta non »apes»e coglierle e fissarle inde
lebilmente. mediante un’arguzia accompagnata da
un -en-o d’arte autentico e sano che ne facesse la
critica di\entando egli stesso l’esponente principale
della corrente avversa. Pensiamo al Ritratto della
signora Giulia.
Considerando il titolo, ci ricordiamo di tutti i buoni
ritrattisti, molto onesti e coscienziosi, che dovevano
anzitutto soddisfare il cliente: guardando il qua
dro. il senso di umorismo che ci colpisce a prima
vista si muta poco a poco nella comprensione di
un’ironia amara, quasi un sarcasmo, che arriva a
valersi di mezzi satirici sottili ma efficacissimi: si
osservi la borsetta che la donna tiene sospesa col
dito mignolo, a quei capelli che sfuggono dalla
pettinatura e che riprendono il motivo dei serpen
telli della Gorgone: il sorriso tra sciocco e soddi
sfatti». senza dubbio maligno, completa la visione
di quella che forse non soltanto nella fantasia do
vette amareggiare la \ita di molte persone.
Si pensi aU’atteggiamenlo iperbolico dei due ele
gantissimi intenditori, armati di monocoli e lenti,
dinanzi ad un quadro di rape, elogio della natura
morta condotta alle sue estreme conseguenze; al
povero Filosofo, che forse, per certi tratti, appare
meno espressivo di altri suoi quadri, perchè più
comune, ma sempre notevole per l'umanità pro
fonda che ci vive. La vena di umorismo che accom
pagna la sua pittura, lo colloca iu una corrente
che ha ben poco a che fare con la pittura consa
crata dell'IMM). che con molla conu»dità s'inqua
drava sotto grandi nomi protettivi. Per certi aspetti
essa appartiene facilmente tanto alla storia del
l'arte che a quella del pensiero, tanto deusa ap
pare e permeata di psicologia, di quella buona,
che la conduce a profondità che trasceudeiio l'a
spetto esterno: cosa molto importante, tenendo
conto della facilità dell'arte ironica di essere,
spesso abusivamente, collocata nella caricatura. Ma
se qualcuno volesse considerare soltanto umoristica
l'arte di Grande, correrebbe rischiudi veder ridotte
le sue possibilità comprensive fino a far confusione,
per esempio. Ira Swift e l'abate Casti.
F passiamo ai viventi. (Jui il discorso sarà più
breve, per molte ragioni, non tutte confessabili.
Lasciando queste da parte, possiamo giustificarci
col dire che non molto numerosi sono quelli che
veramente fanno della buona pittura, dato che per
farne della grande occorrono possibilità anche mag
giori. I soliti nomi famosi, ottimamente fermi nel
campo anche internazionale, e poi una quantità
grandissima di oscuri e di mediocri, che qualche
volta non hanno neppure come attenuante la buona
volontà. Se le arti figurative fossero un facile eser
cizio. e di questo tutti fossero persuasi, non cin
quecento. ma cinquecentomila opere avremmo viste
qui. Segno che molti ancora sanno che è molto me
glio fare un mestiere meno brillante ma meno pe
ricoloso. e che non basta la tecnica esterna per fare
della buona arte: e via di seguilo, il solito discorso
di tutti i clan.
Per tenere il giudizio nei limiti che sopra dicevo,
vediamo ancora fra queste coloro che esprimono un
dato atteggiamento, o che risultano più caratte
ristici. anche se alcuni ricercano la caratteristica
ad ogni costo, e per questo cadono nel banale. Ma
quando si parla di Casorati, che se qui non appare
soverchiamente impegnato, pure rimane sempre al-
I altezza della sua situazione: quando Menzio ri-
24


















