
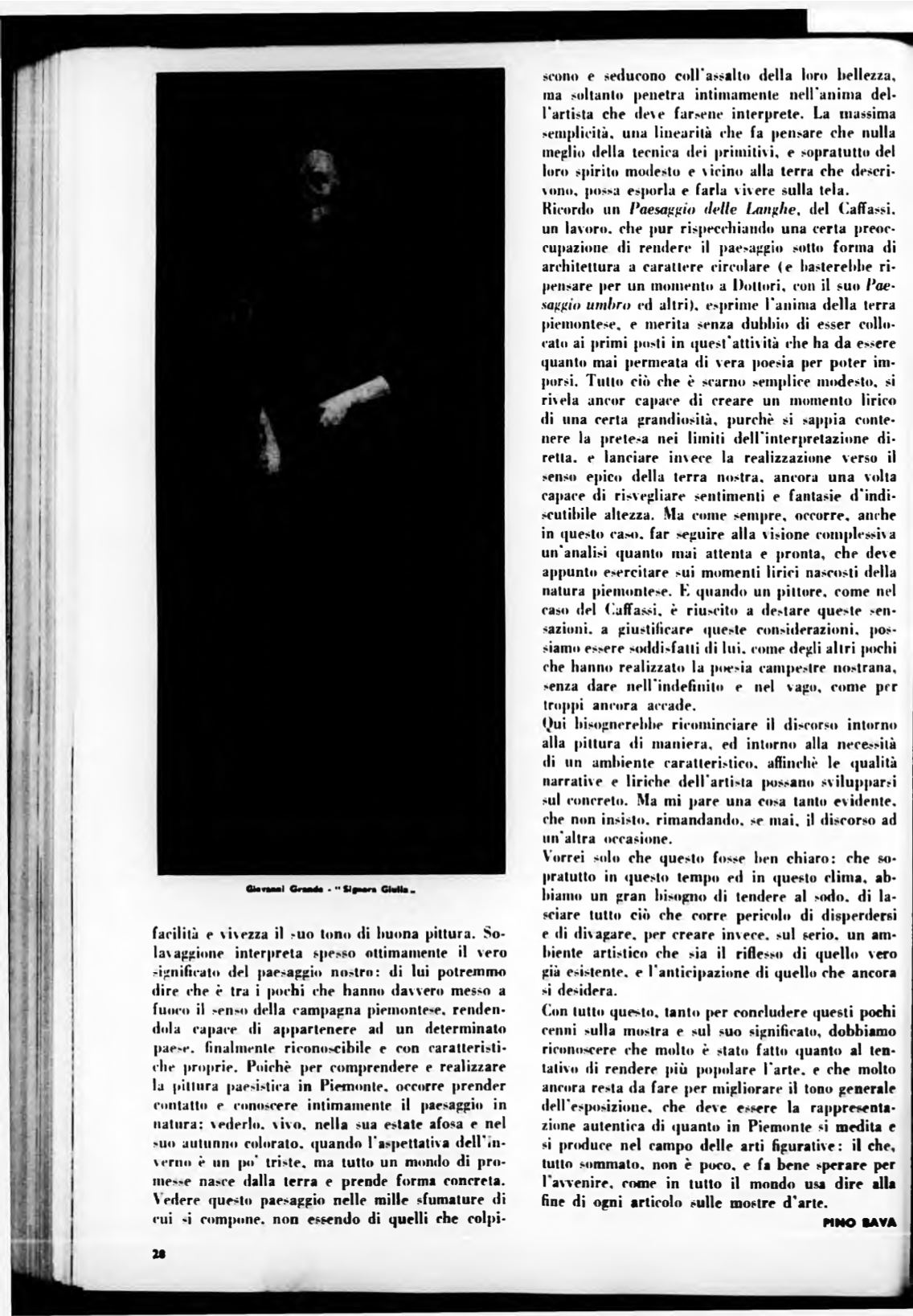
Cloasmi! Gfindc •**Sifnoci
H
facilità e vivezza il ?uo tono di buona pittura. So-
lavaggione interpreta spesso ottimamente il vero
significato del paesaggio nostro: di lui potremmo
dire che è tra i pochi che hanno davvero messo a
fuoco il senso della campagna piemontese, renden
dola capace di appartenere ad un determinato
paese, finalmente riconoscibile e con caratteristi
che proprie. Poiché per comprendere e realizzare
la pittura paesistica in Piemonte, occorre prender
contatto e conoscere intimamente il paesaggio in
natura: vederlo, vivo, nella sua estate afosa e nel
suo autunno colorato, quando l'aspettativa dell’iii-
verno è un po' triste, ma tutto un mondo di pro
messe nasce dalla terra e prende forma concreta.
\ edere questo paesaggio nelle mille sfumature di
cui si compone, non essendo di quelli rhe colpi-
U
scono e seducono coll'assalto della loro bellezza,
ina soltanto penetra intimamente neH'anima del
l'artista che deve farsene interprete. La massima
semplicità, una linearità che fa pensare che nulla
meglio della tecnica dei primitivi, e sopratutto del
loro spirito modesto e vicino alla terra che descri
vono, possa esporla e farla vivere sulla tela.
Ricordo un Paesaggio delle Lanche, del Cattassi,
un lavoro, che pur rispecchiando una certa preoc
cupazione di rendere il paesaggio sotto forma di
architettura a carattere circolare (e basterebbe ri
pensare per un momento a Dottori, con il suo Pae
saggi» umbro ed altri), esprime l'anima della terra
piemontese, e merita senza dubbio di esser collo
cato ai primi posti in quest'attività che ha da essere
quanto mai permeata di vera poesia per poter im
porsi. Tutto ciò che è scarno semplice modesto, si
rivela ancor capace di creare un momento lirico
di una certa grandiosità, purché si sappia conte
nere la pretesa nei limiti dell'interpretazione di
retta. e lanciare invece la realizzazione verso il
senso epico della terra nostra, ancora una volta
capace di risvegliare sentimenti e fantasie d'indi
scutibile altezza. Ma come sempre, occorre, anche
in questo caso, far seguire alla visione complessiva
un'analisi quanto mai attenta e pronta, che deve
appunto esercitare sui momenti lirici nascosti della
natura piemontese. K quando un pittore, come nel
caso del CafTassi. è riuscito a destare queste sen
sazioni. a giustificare queste considerazioni, pos
siamo essere soddisfatti di lui. come degli altri pochi
che hanno realizzato la p<»esia campestre nostrana,
senza dare nell'indefinito e nel vago, come per
troppi ancora accade.
Oui bisognerebbe ricominciare il discorso intorno
alla pittura di maniera, ed intorno alla necessità
di un ambiente caratteristico, affinchè le qualità
narrative e liriche dell'artista |H>ssano svilupparsi
sul concreto. Ma mi pare una cosa tanto evidente,
che non insisto, rimandando, se mai. il discorso ad
un'altra occasione.
Vorrei solo che questo fosse ben chiaro: che so
pratutto in questo tempo ed in questo clima, ab
biamo un gran bisogno di tendere al sodo, di la
sciare tutto ciò che corre pericolo di disperdersi
e di divagare, per creare invece, sul serio, un am
biente artistico che sia il riflesso di quello vero
già esistente, e l’anticipazione di quello che ancora
si desidera.
Con tutto questo, tanto per concludere questi pochi
cenni sulla mostra e sul suo significato, dobbiamo
riconoscere che molto è stato fatto quanto al ten
tativo di rendere più popolare l’arte, e che molto
ancora resta da fare per migliorare il tono generale
deH'esposizione, che deve essere la rappresenta
zione autentica di quanto in Piemonte si medita e
si produce nel campo delle arti figurative: il che,
tutto sommato, non è poco, e fa bene sperare per
I avvenire, come in tutto il mondo usa dire alla
fine di ogni articolo sulle mostre d'arte.
PINO BAVA


















