
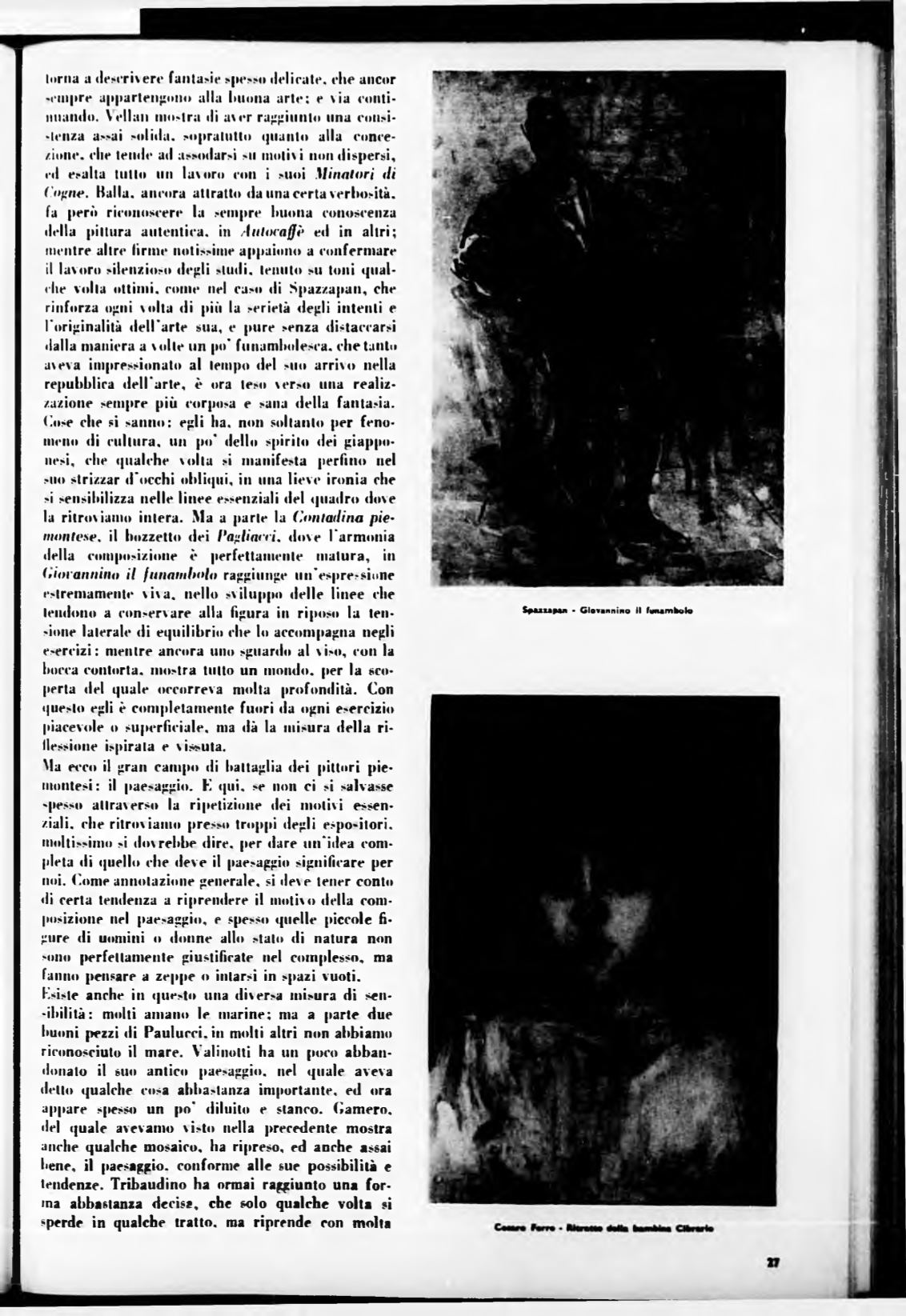
torna a descrivere falliate spesso delicate, che ancor
•empre appartengono alla buona arte: e via conti
nuando. \ «>llaii mostra di a\er raggiunto una cousi-
•lenza assai solida. sopratutto quanto alla conce
zione. die tende ad assodarsi
m i
motiv i non dispersi,
ed esalta tutto un lavoro con i suoi Minatori di
('.ofine. Balla, ancora attratto da una certa verbosità,
fa però riconoscere la sempre buona conoscenza
della pittura autentica, in Autocaffè ed in altri;
mentre altre firme notissime appaiono a confermare
il lavoro silenzioso degli studi, tenuto su toni qual
che volta ottimi, come nel caso di Spazzapan, che
rinforza ogni volta di più la serietà degli intenti e
l'originalità dell'arte sua, e pure senza distaccarsi
dalla maniera a volte un po' funambolesca, che tanto
aveva impressionato al tempo del suo arrivo nella
repubblica dell'arte, è ora teso verso una realiz
zazione sempre più corposa e sana della fantasia,
(lose che si sanno: egli ha, non soltanto per feno
meno di cultura, uu po' dello spirilo dei giappo
nesi, che qualche volta si manifesta perfino uel
m io
strizzar d'occhi obliqui, in una lieve ironia che
si sensibilizza nelle linee essenziali del quadro dove
la ritroviamo intera. Ma a parte la
Contadina
pie
montese. il bozzetto dei Pagliacci, dove l'armonia
della composizione è perfettamente matura, in
('incannino il funainltolo raggiunge un'espre.-siune
estremamente vi\a. nello sviluppo delle linee che
tendono a conservare alla figura in riposo la ten
sione laterale di equilibrio che lo accompagna negli
esercizi: mentre ancora uno sguardo al vi.»o, con la
bocca contorta, mostra tutto un mondo, per la sco
perta del quale occorreva molta profondità. Con
questo egli è completamente fuori da ogni esercizio
piacevole o superficiale, ma dà la misura della ri-
flessione ispirata e vissuta.
Ma ecco il grati campo di battaglia dei pittori pie
montesi: il paesaggio. E qui. se non ci si salvasse
spesso attraverso la ripetizione dei motivi essen
ziali. che ritroviamo presso troppi degli espositori,
moltissimo si dovrebbe dire, per dare un'idea com
pleta di quello che deve il paesaggio significare per
noi. Come annotazione generale, si deve tener conto
di certa tendenza a riprendere il motivo della com
posizione nel paesaggio, e spesso quelle piccole fi*
{iure di uomini o donne allo .«tato di natura non
sono perfettamente giustificate nel complesso, ma
fanno pensare a zeppe o intarsi in spazi vuoti.
Ksiste anche in questo una diversa misura di sen-
-ibilità : molti amano le marine; ma a parte due
buoni pezzi di Paulucci. in molti altri non abbiamo
riconosciuto il mare. Valinotti ha un poco abban
donato il suo antico paesaggio, nel quale aveva
detto qualche cosa abbastanza importante, ed ora
appare spesso un po' diluito e stanco, (damerò,
del quale avevamo visto nella precedente mostra
anche qualche mosaico, ha ripreso, ed anche assai
bene, il paesaggio, conforme alle sue possibilità e
tendenze. Tribaudino ha ormai raggiunto una for
ma abbastanza decise, che solo qualche volta si
sperde in qualche tratto, ma riprende con molta
Spaxupan - Giovannino II funambolo


















