
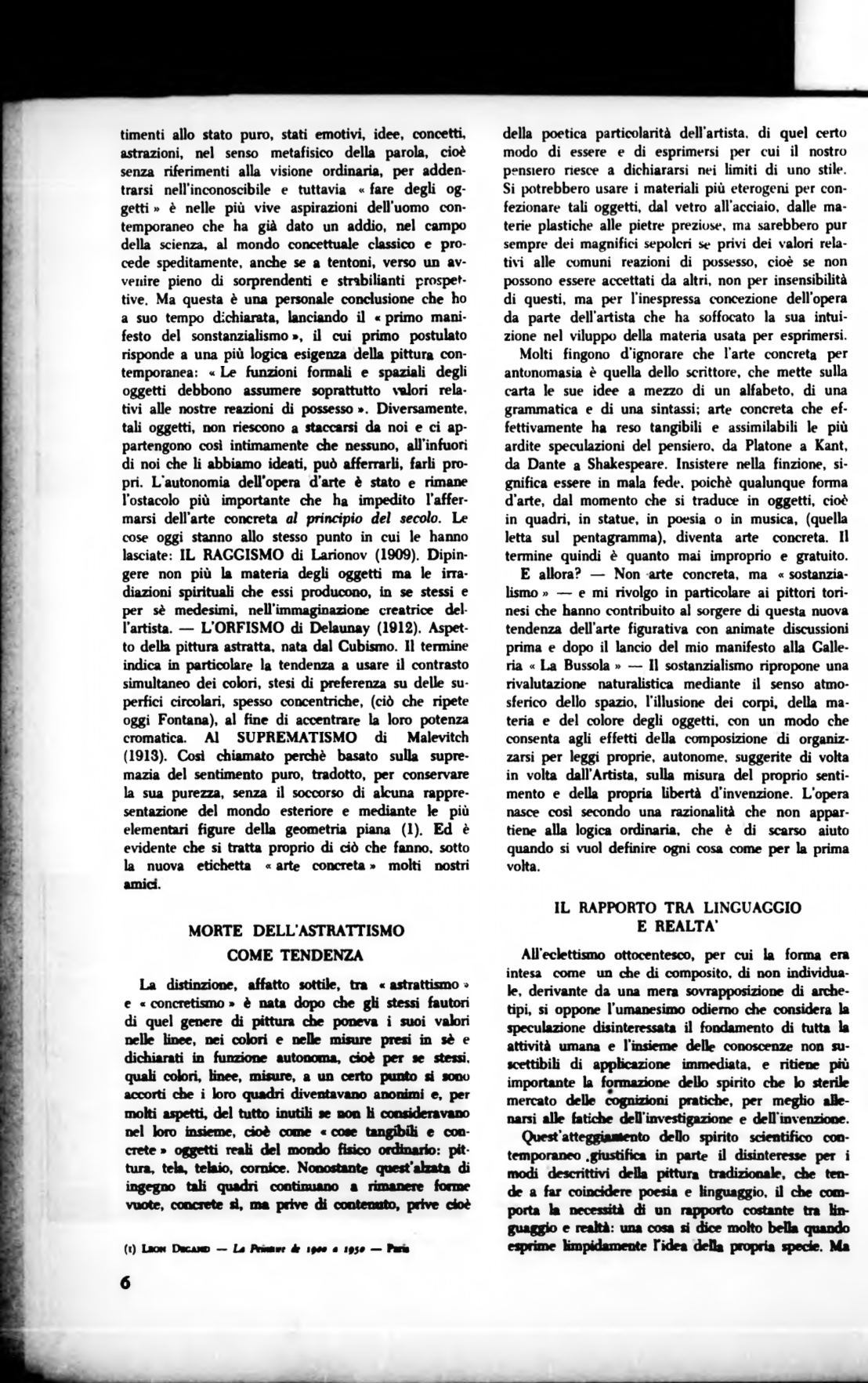
timenti allo stato puro, stati emotivi, idee, concetti
astrazioni, nel senso metafisico della parola, cioè
senza riferimenti alla visione ordinaria, per adden
trarsi neH’inconoscibile e tuttavia « fare degli og
getti » è nelle più vive aspirazioni deU’uomo con
temporaneo che ha già dato un addio, nel campo
della scienza, al mondo concettuale classico e pro
cede speditamente, anche se a tentoni, verso un av
venire pieno di sorprendenti e strabilianti prospet
tive. Ma questa è una personale conclusione che ho
a suo tempo dichiarata, lanciando il « primo mani
festo del sonstanzialismo », il cui primo postulato
risponde a una più logica esigenza della pittura con
temporanea: « Le funzioni formali e spaziali degli
oggetti debbono assumere soprattutto valori rela
tivi alle nostre reazioni di possesso ». Diversamente,
tali oggetti, non riescono a staccarsi da noi e ci ap
partengono così intimamente die nessuno, all’infuori
di noi che li abbiamo ideati, può afferrarli, farli pro
pri. L’autonomia dell’opera d’arte è stato e rimane
l’ostacolo più importante die ha impedito l’affer
marsi dell’arte concreta
al principio del secolo.
Le
cose oggi stanno allo stesso punto in cui le hanno
lasciate: IL RAGGISMO di Larionov (1909). Dipin
gere non più la materia degli oggetti ma le irra
diazioni spirituali die essi producono, in se stessi e
per sè medesimi, nell’immaginazione creatrice del
l’artista. — L’ORFISMO di Delaunay (1912). Aspet
to della pittura astratta, nata dal Cubismo. 11 termine
indica in particolare la tendenza a usare il contrasto
simultaneo dei colori, stesi di preferenza su delle su-
perfici circolari, spesso concentriche, (ciò che ripete
oggi Fontana), al fine di accentrare la loro potenza
cromatica. Al SUPREMATISMO di Malevitch
(1913). Cosi chiamato perchè basato sulla supre
mazia del sentimento puro, tradotto, per conservare
la sua purezza, senza il soccorso di alcuna rappre
sentazione del mondo esteriore e mediante le più
elementari figure della geometria piana (1). Ed è
evidente che si tratta proprio di dò che fanno, sotto
la nuova etichetta « arte concreta » molti nostri
amia.
MORTE DELL’ASTRATTISMO
COME TENDENZA
La distinzione, affatto sottile, tra « astrattismo »
e « concretismo » è nata dopo che gli stessi fautori
di quel genere di pittura che poneva i suoi valori
nelle linee, nei colorì e nelle misure presi in sè e
dichiarati in funzione autonoma, cioè per se stessi,
quali colori, linee, misure, a un certo punto si sono
accorti die i loro quadri diventavano anonimi e, per
moki aspetti, del tutto inutili se non li consideravano
nel loro insieme, doè come « cose tangibili e con
crete» oggetti reali del mondo fisico ordinario: pit
tura, tela, telaio, cornice. Nonostante quest’alzata di
ingegno tali quadri continuano a rimanere forme
vuote, concrete si, ma prive di contenuto, prive doè
(t) L ion D ic an e —
Là Pnm w r ir
19
#»
a t u »
— P a n
della poetica particolarità dell’artista, di quel certo
modo di essere e di esprimersi per cui il nostro
pensiero riesce a dichiararsi nei limiti di uno stile.
Si potrebbero usare i materiali più eterogeni per con
fezionare tali oggetti, dal vetro aH’acciaio, dalle ma
terie plastiche alle pietre preziose, ma sarebbero pur
sempre dei magnifici sepolcri se privi dei valori rela
tivi alle comuni reazioni di possesso, cioè se non
possono essere accettati da altri, non per insensibilità
di questi, ma per l’inespressa concezione dell'opera
da parte dell’artista che ha soffocato la sua intui
zione nel viluppo della materia usata per esprimersi.
Molti fingono d’ignorare che l’arte concreta per
antonomasia è quella dello scrittore, che mette sulla
carta le sue idee a mezzo di un alfabeto, di una
grammatica e di una sintassi; arte concreta che ef
fettivamente ha reso tangibili e assimilabili le più
ardite speculazioni del pensiero, da Platone a Kant,
da Dante a Shakespeare. Insistere nella finzione, si
gnifica essere in mala fede, poiché qualunque forma
d’arte, dal momento che si traduce in oggetti, cioè
in quadri, in statue, in poesia o in musica, (quella
letta sul pentagramma), diventa arte concreta. Il
termine quindi è quanto mai improprio e gratuito.
E allora? — Non arte concreta, ma « sostanzia-
lismo » — e mi rivolgo in particolare ai pittori tori
nesi die hanno contribuito al sorgere di questa nuova
tendenza dell’arte figurativa con animate discussioni
prima e dopo il lancio del mio manifesto alla Galle
ria « La Bussola » — Il sostanziammo ripropone una
rivalutazione naturalistica mediante il senso atmo
sferico dello spazio, l'illusione dei corpi, della ma
teria e del colore degli oggetti, con un modo che
consenta agli effetti della composizione di organiz
zarsi per leggi proprie, autonome, suggerite di volta
in volta dall’Artista, sulla misura del proprio senti
mento e della propria libertà d’invenzione. L'opera
nasce cosi secondo una razionalità che non appar
tiene alla logica ordinaria, che è di scarso aiuto
quando si vuol definire ogni cosa come per la prima
volta.
IL RAPPORTO TRA LINGUAGGIO
E REALTA’
All’eclettismo ottocentesco, per cui la forma era
intesa come un che di composito, di non individua
le, derivante da una mera sovrapposizione di arche
tipi, si oppone l’umanesimo odierno che considera la
speculazione disinteressata il fondamento di tutta la
attività umana e l’insieme delle conoscenze non su
scettibili di applicazione immediata, e ritiene più
importante la formazione dello spirito che lo sterile
mercato delle cognizioni pratiche, per meglio alle
narsi alle fatiche dell'investigazione e dell'invenzione.
Quest’atteggijuaento dello spirito scientifico con
temporaneo .giustifica in parte il disinteresse per i
modi descrittivi della pittura tradizionale, die ten
de a far coincidere poesia e linguaggio, il die com
porta la necessità di un rapporto costante tra lin
guaggio e realtà: una cosa si dice molto bella quando
esprime limpidamente l’idea della propria specie. Ma
6


















