
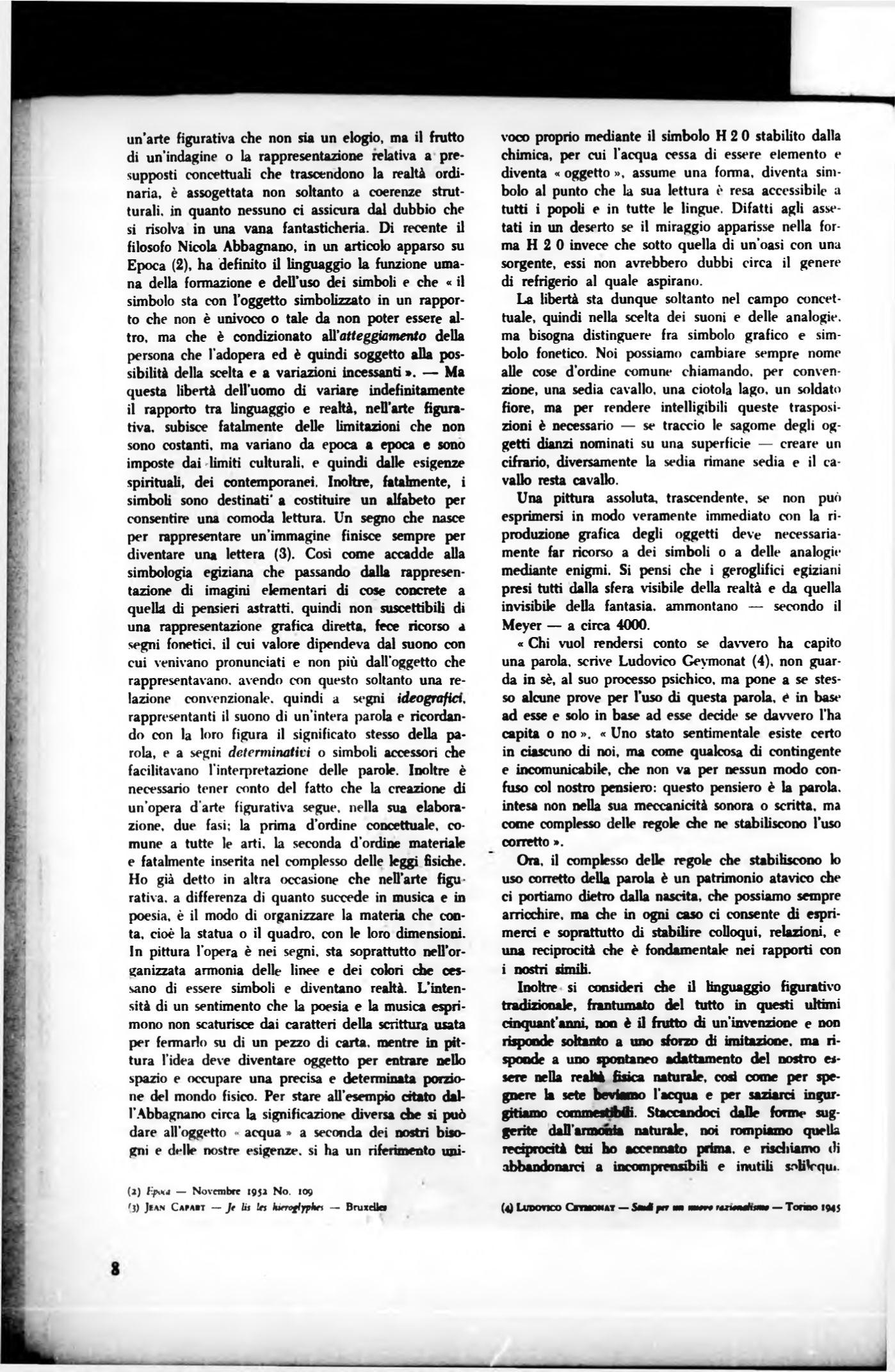
un’arte figurativa che non sia un elogio, ma il frutto
di un’indagine o la rappresentazione relativa a pre
supposti concettuali che trascendono la realtà ordi
naria, è assogettata non soltanto a coerenze strut
turali. in quanto nessuno ci assicura dal dubbio che
si risolva in una vana fantasticheria. Di recente il
filosofo Nicola Abbagnano, in un articolo apparso su
Epoca (2), ha definito il linguaggio la funzione uma
na della formazione e dell’uso dei simboli e che « il
simbolo sta con l’oggetto simbolizzato in un rappor
to che non è univoco o tale da non poter essere al
tro, ma che è condizionato
a\ì’atteggiamento
della
persona che l'adopera ed è quindi soggetto alla pos
sibilità della scelta e a variazioni incessanti ». — Ma
questa libertà dell’uomo di variare indefinitamente
il rapporto tra linguaggio e realtà, nell’arte figura
tiva. subisce fatalmente delle limitazioni che non
sono costanti, ma variano da epoca a epoca e sono
imposte dai limiti culturali, e quindi dalle esigenze
spirituali, dei contemporanei. Inoltre, fatalmente, i
simboli sono destinati* a costituire un alfabeto per
consentire una comoda lettura. Un segno che nasce
per rappresentare un’immagine finisce sempre per
diventare una lettera (3). Cosi come accadde alla
simbologia egiziana che passando dalla rappresen
tazione di imagini elementari di cose concrete a
quella di pensieri astratti, quindi non suscettibili di
una rappresentazione grafica diretta, fece ricorso a
segni fonetici, il cui valore dipendeva dal suono con
cui venivano pronunciati e non più dall'oggetto che
rappresentavano, avendo con questo soltanto una re
lazione convenzionale, quindi a segni
ideografia,
rappresentanti il suono di un’intera parola e ricordan
do con la loro figura il significato stesso della pa
rola, e a segni
determinativi
o simboli accessori che
facilitavano l’interpretazione delle parole. Inoltre è
necessario tener conto del fatto che la creazione di
un'opera d’arte figurativa segue, nella sua elabora
zione, due fasi; la prima d’ordine concettuale, co
mune a tutte le arti, la seconda d’ordine materiale
e fatalmente inserita nel complesso delle leggi fìsiche.
Ho già detto in altra occasione che nell’arte figu
rativa. a differenza di quanto succede in musica e in
poesia,
è
il modo di organizzare la materia che con
ta, cioè la statua o il quadro, con le loro dimensioni.
In pittura l’opera
è
nei segni, sta soprattutto nell’or-
ganizzata armonia delle linee e dei colori che ces
sano di essere simboli e diventano realtà. L’inten
sità di un sentimento che la poesia e la musica espri
mono non scaturisce dai caratteri della scrittura usata
per fermarlo su di un pezzo di carta, mentre in pit
tura l’idea deve diventare oggetto per entrare nello
spazio e occupare una precisa e determinata porzio
ne del mondo fisico. Per stare all’esempio citato dal-
l’Abbagnano circa la significazione diversa die si può
dare all’oggetto <• acqua » a seconda dei nostri biso
gni e delle nostre esigenze, si ha un riferimento uni
voco proprio mediante il simbolo H 2 0 stabilito dalla
chimica, per cui l’acqua cessa di essere elemento e
diventa « oggetto », assume una forma, diventa sim
bolo al punto che la sua lettura è resa accessibile a
tutti i popoli e in tutte le lingue. Difatti agli asse
tati in un deserto se il miraggio apparisse nella for
ma H 2 0 invece che sotto quella di un’oasi con una
sorgente, essi non avrebbero dubbi circa il genere
di refrigerio al quale aspirano.
La libertà sta dunque soltanto nel campo concet
tuale, quindi nella scelta dei suoni e delle analogie,
ma bisogna distinguere fra simbolo grafico e sim
bolo fonetico. Noi possiamo cambiare sempre nome
alle cose d’ordine comune chiamando, per conven
zione, una sedia cavallo, una ciotola lago, un soldato
fiore, ma per rendere intelligibili queste trasposi
zioni è necessario — se traccio le sagome degli og
getti dianzi nominati su una superficie — creare un
cifrario, diversamente la sedia rimane sedia e il ca
vallo resta cavallo.
Una pittura assoluta, trascendente, se non può
esprimersi in modo veramente immediato con la ri-
produzione grafica degli oggetti deve necessaria
mente far ricorso a dei simboli o a delle analogie
mediante enigmi. Si pensi che i geroglifici egiziani
presi tutti dalla sfera visibile della realtà e da quella
invisibile della fantasia, ammontano — secondo il
Meyer — a circa 4000.
« Chi vuol rendersi conto se davvero ha capito
una parola, scrive Ludovico Geymonat (4), non guar
da in sè, al suo processo psichico, ma pone a se stes
so alcune prove per l’uso di questa parola, é in base
ad esse e solo in base ad esse decide se davvero l’ha
capita o no ». « Uno stato sentimentale esiste certo
in ciascuno di noi, ma come qualcosa di contingente
e incomunicabile, che non va per nessun modo con
fuso col nostro pensiero: questo pensiero è la parola,
intesa non nella sua meccanicità sonora o scritta, ma
come complesso delle regole die ne stabiliscono l’uso
corretto ».
Ora, il complesso delle regole che stabiliscono lo
uso corretto della parola è un patrimonio atavico che
ci portiamo dietro dalla nascita, che possiamo sempre
arricchire, ma che in ogni caso ci consente di espri
merci e soprattutto di stabilire colloqui, relazioni, e
una reciprocità che è fondamentale nei rapporti con
i nostri simili.
Inoltre si consideri die il linguaggio figurativo
tradizionale, frantumato del tutto in questi ultimi
cinquantanni, non è il frutto di un’invenzione e non
risponde soltanto a uno sforzo di imitazione, ma ri
sponde a uno spontaneo adattamento del nostro es
sere nella realtà fisica naturale, cosi come per spe
gnere la sete beviamo l’acqua e per saziarci ingur
gitiamo commestibili. Staccandoci dalle forme sug
gerite daQ’armcmia naturale, noi rompiamo quella
reciprocità
6
ui ho accennato prima, e risdiiamo di
abbandonarci a incomprensibili e inutili soliVqu»
(a)
Epocà
— Novembre ig jj No. 109
'})
Jéa.n CAfA»T —
Jr lis In hùroglyphes
— BruxeUa
(
4
)
Ludovico C ttm o n a t —
Sm à prr tm
« u ro
taxumdismo
—Torino
1945


















