
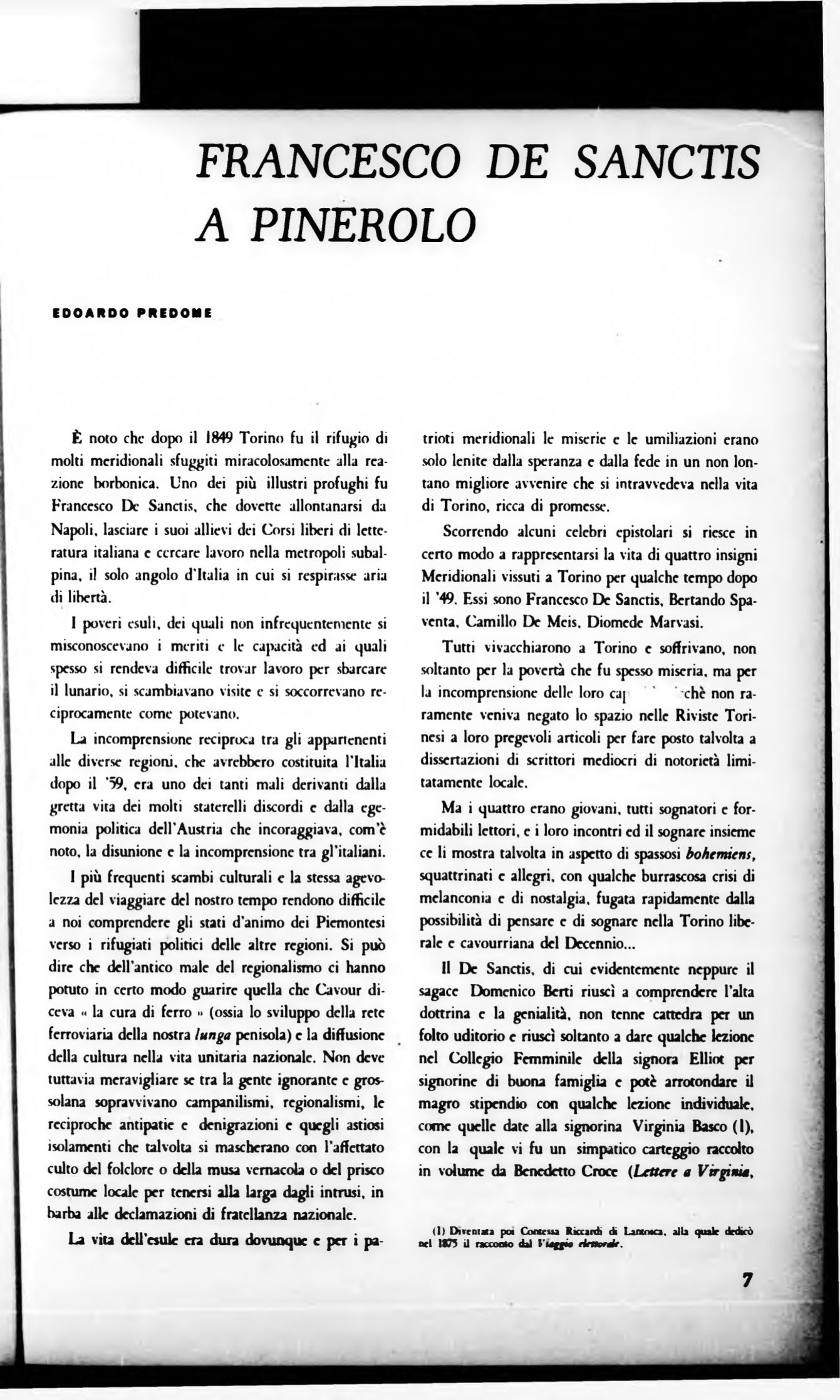
FRANCESCO DE SANCTIS
A PINEROLO
E D O A R D O P R E D O M E
È noto che dopo il 1849 Torino fu il rifugio di
molti meridionali sfuggiti miracolosamente alla rea
zione borbonica. Uno dei più illustri profughi fu
Francesco De Sanctis, che dovette allontanarsi da
Napoli, lasciare i suoi allievi dei Corsi liberi di lette
ratura italiana e cercare lavoro nella metropoli subal
pina, il solo angolo d'Italia in cui si respirasse aria
di libertà.
I
poveri esuli, dei quali non infrequentemente si
misconoscevano i meriti e le capacità ed ai quali
spesso si rendeva diffìcile trovar lavoro per sbarcare
il lunario, si scambiavano visite e si soccorrevano re
ciprocamente come potevano.
La incomprensione reciproca tra gli appartenenti
alle diverse regioni, che avrebbero costituita l'Italia
dopo il '59, era uno dei tanti mali derivanti dalla
gretta vita dei molti staterelli discordi e dalla ege
monia politica dell'Austria che incoraggiava, com e
noto, la disunione e la incomprensione tra gl’italiani.
I
più frequenti scambi culturali e la stessa agevo
lezza del viaggiare del nostro tempo rendono diffìcile
a noi comprendere gli stati d'animo dei Piemontesi
verso i rifugiati politici delle altre regioni. Si può
dire che dell'antico male del regionalismo ci hanno
potuto in certo modo guarire quella che Cavour di
ceva « la cura di ferro » (ossia lo sviluppo della rete
ferroviaria della nostra
lunga
penisola) e la diffusione
della cultura nella vita unitaria nazionale. Non deve
tuttavia meravigliare se tra la gente ignorante e gros
solana sopravvivano campanilismi, regionalismi, le
reciproche antipatie e denigrazioni e quegli astiosi
isolamenti che talvolta si mascherano con l’affettato
culto del folclore o della musa vernacola o del prisco
costume locale per tenersi alla larga dagli intrusi, in
barba alle declamazioni di fratellanza nazionale.
La vita dell’esule era dura dovunque e per i pa
trioti meridionali le miserie e le umiliazioni erano
solo lenite dalla speranza e dalla fede in un non lon
tano migliore avvenire che si intravvedeva nella vita
di Torino, ricca di promesse.
Scorrendo alcuni celebri epistolari si riesce in
certo modo a rappresentarsi la vita di quattro insigni
Meridionali vissuti a Torino per qualche tempo dopo
il '49. Essi sono Francesco De Sanctis, Bertando Spa
venta, Camillo De Meis. Diomede Marvasi.
Tutti vivacchiarono a Torino e soffrivano, non
soltanto per la povertà che fu spesso miseria, ma per
la incomprensione delle loro caj
che non ra
ramente veniva negato lo spazio nelle Riviste Tori
nesi a loro pregevoli articoli per fare posto talvolta a
dissertazioni di scrittori mediocri di notorietà limi
tatamente locale.
Ma i quattro erano giovani, tutti sognatori e for
midabili lettori, e i loro incontri ed il sognare insieme
ce li mostra talvolta in aspetto di spassosi
bohemiens,
squattrinati e allegri, con qualche burrascosa crisi di
melanconia e di nostalgia, fugata rapidamente dalla
possibilità di pensare e di sognare nella Torino libe
rale e cavourriana del Decennio...
11 De Sanctis, di cui evidentemente neppure il
sagace Domenico Berti riuscì a comprendere l’alta
dottrina e la genialità, non tenne cattedra per un
folto uditorio e riuscì soltanto a dare qualche lezione
nel Collegio Femminile della signora Elliot per
signorine di buona famiglia e potè arrotondare il
magro stipendio con qualche lezione individuale,
come quelle date alla signorina Virginia Basco (I),
con la quale vi fu un simpatico carteggio raccolto
in volume da Benedetto Croce
(Lettere
a Virginia
,
(1) Diventala pot Contessa Riccardi di Laramca. alla quale dedicò
nel 1875 il racconto dal
Vuggio tirttorje.
7


















