
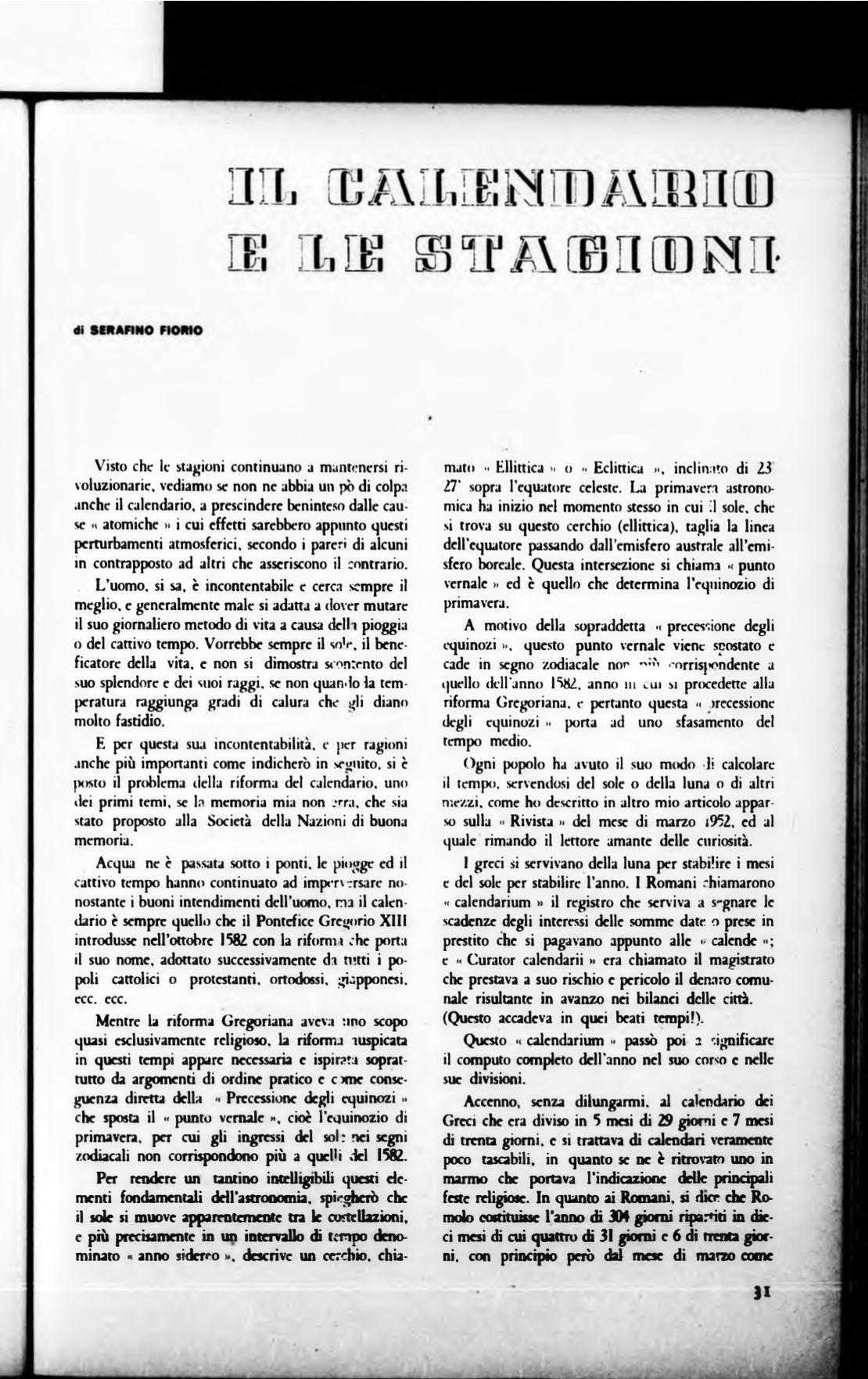
Visto che le stagioni continuano a mantenersi ri
voluzionarie, vediamo se non ne abbia un pò di colpa
anche il calendario, a prescindere beninteso dalle cau
se « atomiche » i cui effetti sarebbero appunto questi
perturbamenti atmosferici, secondo i pareri di alcuni
in contrapposto ad altri che asseriscono il contrario.
L’uomo, si sa, è incontentabile e cerca sempre il
meglio, e generalmente male si adatta a dover mutare
il suo giornaliero metodo di vita a causa dell *pioggia
o del cattivo tempo. Vorrebbe sempre il soV. il bene-
ficatore della vita, e non si dimostra scontento del
suo splendore e dei suoi raggi, se non quando la tem
peratura raggiunga gradi di calura che j^li diano
molto fastidio.
E per questa sua incontentabilità, e per ragioni
anche più importanti come indicherò in seyuito. si è
posto il problema della riforma del calendario, uno
dei primi temi, se la memoria mia non ,‘rra, che sia
stato proposto alla Società della Nazioni di buona
memoria.
Acqua ne è passata sotto i ponti, le piogge ed il
cattivo tempo hanno continuato ad imperversare no
nostante i buoni intendimenti dell’uomo, ma il calen
dario è sempre quello che il Pontefice Gregorio XIII
introdusse nell’ottobre 1582 con la riform i che porta
il suo nome, adottato successivamente da tv.tti i po
poli cattolici o protestanti, ortodossi, giapponesi,
ecc. ecc.
Mentre la riforma Gregoriana aveva uno scopo
quasi esclusivamente religioso, la riformj auspicata
in questi tempi appare necessaria e ispirerà soprat
tutto da argomenti di ordine pratico e c ime conse
guenza diretta della « Precessione degli equinozi »
che sposta il •• punto vernale », cioè l'equinozio di
primavera, per cui gli ingressi del sol: nei segni
zodiacali non corrispondono più a quelli del 1% .
Per rendere un tantino intelligibili questi d e
menti fondamentali deH’astronomia, spiegherò che
il sole si muove apparentemente tra le costellazioni,
e più precisamente in un intervallo di tempo deno
minato « anno sidereo », descrive un cerchio, chia
mato ■<Ellittica » o « Eclittica ». inclinato di 23
27’ sopra l’equatore celeste. La primavera astrono
mica ha inizio nel momento stesso in cui il sole, che
si trova su questo cerchio (ellittica), taglia la linea
dell’equatore passando dall’emisfero australe all’emi
sfero boreale. Questa intersezione si chiama ><punto
vernale » ed è quello che determina l’equinozio di
primavera.
A motivo della sopraddetta ><precessione degli
equinozi ». questo punto vernale viene spostato e
cade in segno zodiacale nor «nN rorris}indente a
tjuello dell'anno
1^82,
anno
in
v.uisi
procedette alla
riforma Gregoriana, e pertanto questa « recessione
degli equinozi » porta ad uno sfasamento del
tempo medio.
Ogni popolo ha avuto il suo modo li calcolare
il tempi, servendosi del sole o della luna o di altri
mezzi, come ho descritto in altro mio articolo appar
so sulla « Rivista » del mese di marzo i952, ed al
quale rimando il lettore amante delle curiosità.
I
greci si servivano della luna per stabilire i mesi
e del sole per stabilire l’anno. I Romani rhiamarono
« calendarium » il registro che serviva a s-gnare le
scadenze degli interessi delle somme date o prese in
prestito che si pagavano appunto alle <• calende »•;
e • Curator calendarii » era chiamato il magistrato
che prestava a suo rischio e pericolo il denaro comu
nale risultante in avanzo nei bilanci delle città.
(Questo accadeva in quei beati tempi!).
Questo « calendarium • passò poi
2
significare
il computo completo dell’anno nel suo corso e nelle
sue divisioni.
Accenno, senza dilungarmi, al calendario dei
Greci che era diviso in 5 mesi di 29 giorni e 7 mesi
di trenta giorni, e si trattava di calendari veramente
poco tascabili, in quanto se ne è ritrovato uno in
marmo che portava l’indicazione delle principali
feste religiose. In quanto ai Romani, si dtcr che Ro
molo costituisse l’anno di 304 giorni ripairriti in die
ci mesi di cui quattro di 31 giorni e
6
di trenta gior
ni, con principio però dal mese di marzo come
31


















