
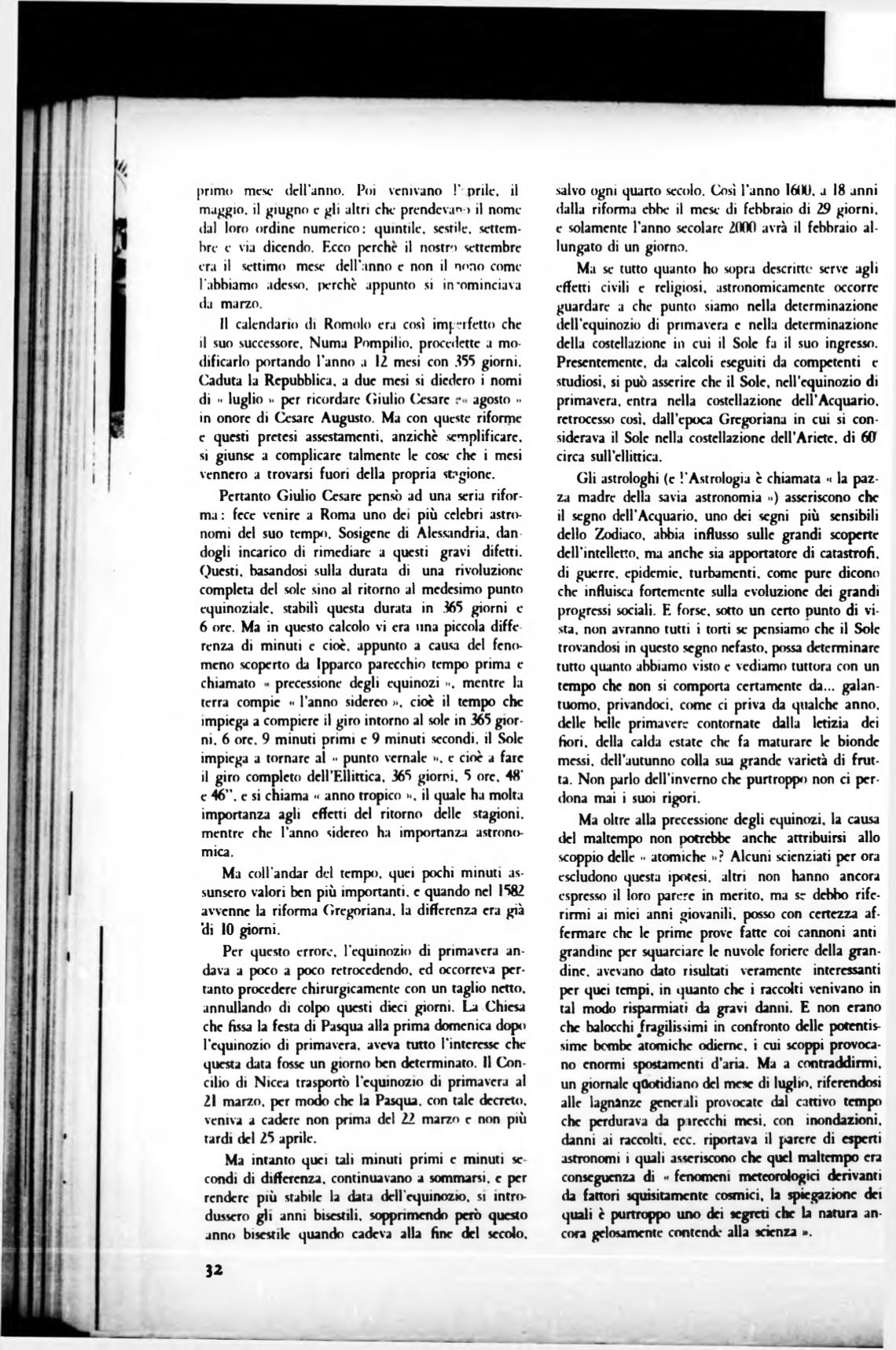
primo mese dell'anno. Poi venivano !’ prile. il
maggio. il giugno e gli altri che prendevano il nome
dal loro ordine numerico: quintile, sestile, settem
bre e via dicendo. Ecco perche il nostro settembre
era il settimo mese dell'anno e non il nono come
l'abbiamo adesso, perchè appunto si in*ominciava
da marzo.
Il calendario di Romolo era così imperfetto che
il suo successore. Numa Pompilio, procedette a mo
dificarlo portando Tanno a 12 mesi con 355 giorni.
Caduta la Repubblica, a due mesi si diedero i nomi
di ■ luglio » per ricordare Giulio Osare
agosto •
in onore di Cesare Augusto. Ma con queste riforme
e questi pretesi assestamenti, anziché semplificare,
si giunse a complicare talmente le cose che i mesi
vennero a trovarsi fuori della propria stagione.
Pertanto Giulio Cesare pensi) ad una seria rifor
ma : fece venire a Roma uno dei più celebri astro
nomi del suo tempo. Sosigene di Alessandria, dan
dogli incarico di rimediare a questi gravi difetti.
Questi, basandosi sulla durata di una rivoluzione
completa del sole sino al ritorno al medesimo punto
equinoziale, stabilì questa durata in .365 giorni e
6 ore. Ma in questo calcolo vi era una piccola diffe
renza di minuti e cioè, appunto a causa del feno
meno scoperto da Ipparco parecchio tempo prima e
chiamato <precessione degli equinozi ». mentre la
terra compie « Panno sidereo >», cioè il tempo che
impiega a compiere il giro intorno al sole in 365 gior
ni. 6 ore. 9 minuti primi e 9 minuti secondi, il Sole
impiega a tornare al • punto vernale ». e cioè a fare
il giro completo dell’Ellittica. 365 giorni. 5 ore. 48’
e 46” . e si chiama « anno tropico ». il quale ha molta
importanza agli effetti del ritorno delle stagioni,
mentre che Tanno sidereo ha importanza astrono
mica.
Ma coll'andar del tempo, quei pochi minuti as
sunsero valori ben più importanti, e quando nel 1582
avvenne la riforma Gregoriana, la differenza era già
’di 10 giorni.
Per questo errore, l’equinozio di primavera an
dava a poco a poco retrocedendo, ed occorreva per
tanto procedere chirurgicamente con un taglio netto,
annullando di colpo questi dieci giorni. La Chiesa
che fissa la festa di Pasqua alla prima domenica dopo
l’equinozio di primavera, aveva tutto l’interesse che
questa data fosse un giorno ben determinato. 11Con
cilio di Nicea trasportò l’equinozio di primavera al
21 marzo, per modo che la Pasqua, con tale decreto,
veniva a cadere non prima del 22 marzo c non più
tardi del 25 aprile.
Ma intanto quei tali minuti primi e minuti se
condi di differenza, continuavano a sommarsi, c per
rendere più stabile la data delTcquinozio. si intro
dussero gli anni bisestili, sopprimendo però questo
anno bisestile quando cadeva alla fine del secolo.
salvo ogni quarto secolo. Così Tanno 16(10. a 18 anni
dalla riforma ebbe il mese di febbraio di 29 giorni,
e solamente Tanno secolare 2(100 avrà il febbraio al
lungato di un giorno.
Ma se tutto quanto ho sopra descritte serve agli
effetti civili e religiosi, astronomicamente occorre
guardare a che punto siamo nella determinazione
dell’equinozio di primavera e nella determinazione
della costellazione in cui il Sole fa il suo ingresso.
Presentemente, da calcoli eseguiti da competenti e
studiosi, si può asserire che il Sole, nell’equinozio di
primavera, entra nella costellazione dell’Acquario,
retrocesso così, dall’epoca Gregoriana in cui si con
siderava il Sole nella costellazione dcH’Ariete. di 60
circa sull’ellittica.
Gli astrologhi (e '.'Astrologia è chiamata « la paz
za madre della savia astronomia ») asseriscono che
il segno dell’Acquario, uno dei segni più sensibili
dello Zodiaco, abbia influsso sulle grandi scoperte
dell'intelletto, ma anche sia apportatore di catastrofi,
di guerre, epidemie, turbamenti, come pure dicono
che influisca fortemente sulla evoluzione dei grandi
progressi sociali. E forse, sotto un certo punto di vi
sta. non avranno tutti i torti se pensiamo chc il Sole
trovandosi in questo segno nefasto, possa determinare
tutto quanto abbiamo visto e vediamo tuttora con un
tempo chc non si comporta certamente da... galan
tuomo. privandoci, come ci priva da qualche anno,
delle belle primavere contornate dalla letizia dei
fiori, della calda estate che fa maturare le bionde
messi, dell’autunno colla sua grande varietà di frut
ta. Non parlo dell’inverno chc purtroppo non ci per
dona mai i suoi rigori.
Ma oltre alla precessione degli equinozi, la causa
ilei maltempo non potrebbe anche attribuirsi allo
scoppio delle • atomiche »? Alcuni scienziati per ora
escludono questa ipotesi, altri non hanno ancora
espresso il loro parere in merito, ma se debbo rife
rirmi ai mici anni giovanili, posso con certezza af
fermare chc le prime prove fatte coi cannoni anti
grandine per squarciare le nuvole foriere della gran
dine. avevano dato risultati veramente interessanti
per quei tempi, in quanto che i raccolti venivano in
tal modo risparmiati da gravi danni. E non erano
chc balocchi fragilissimi in confronto delle potentis
sime bombe atomiche odierne, i cui scoppi provoca
no enormi spostamenti d’aria. Ma a contraddirmi,
un giornale qOotidiano del mese di luglio, riferendosi
alle lagnanze generali provocate dal cattivo tempo
che perdurava da parecchi mesi, con inondazioni,
danni ai raccolti, ecc. riportava il farcre di esperti
astronomi i quali asseriscono chc quel maltempo era
conseguenza di « fenomeni meteorologici derivanti
da fattori squisitamente cosmici, la spiegazione dei
quali è purtroppo uno dei segreti che la natura an
cora gelosamente contende alla scienza ».
32


















