
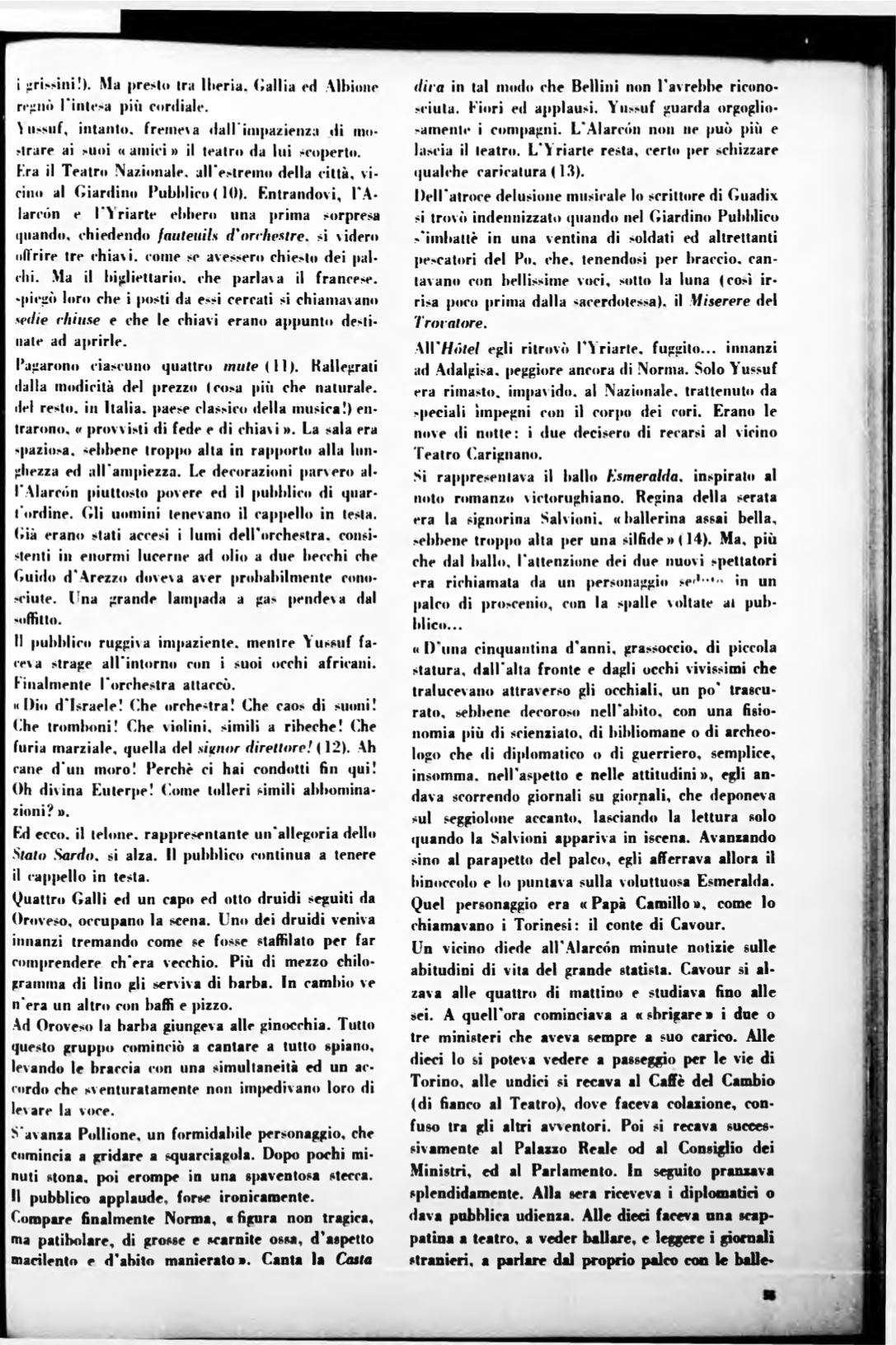
i grissini!). Ma presto tra lheria. (Pallia ed Albione
remilo l'intera più cordiale.
Yussuf, intanto, fremeva dall'impazienza «li mo
strare ai suoi « amici » il teatro da lui scoperto.
Fra il Teatro Nazionale, all'estremo della città, v i
rino al Giardino Pubblico ( 10). Entrandovi,
l'A-
larcón e I Y riarte ebbero una prima sorpresa
quando, chiedendo
fauteuils d'orchestre,
si videro
offrire tre chiavi, come se avessero chiesto dei pal
chi. Ma il l»i*rliettari». che parlava il francese,
spiegò loro che i posti da essi cercati si chiamavano
se<lie chiuse
e che le chiavi erano appunto desti
nate ad aprirle.
Pacarono ciascuno quattri»
mute
(11). Rallegrati
dalla modicità del prezzo (cosa più che naturale,
del resto, in Italia, paese classico della musica!) en
trarono.
v
provvisti di fede e di chiavi ». La sala era
spaziosa, sebbene troppo alta in rapporto alla lun
ghezza ed all'ampiezza. Le decorazioni parvero al-
I*Alarcón piuttosto povere ed il pubblico di quar-
l’ordine. G li uomini tenevano il cappello in testa.
Già erano stati accesi i lumi dell'orchestra, consi
stenti in enormi lucerne ad olio a due becchi che
Guido d* Arezzo doveva aver probabilmente cono
sciute. lin a grande lampada a ga> pendeva dal
soffitto.
Il pubblico ruggiva impaziente, mentre Yussuf fa
ceva strage all'intorno con i suoi occhi africani.
Finalmente l'orchestra attaccò.
«D io d'Israele! Che orchestra! Che caos di suoni!
Che tromboni! Che violini, simili a riheche! Che
furia marziale, quella del
siiinor direttore!
( 12). Ah
cane d'un moro! Perchè ci hai condotti fin qui!
Oh divina Euterpe! Come tolleri simili abbomina-
zioni? ».
Ed ecco, il telone, rappresentante un'allegoria dello
Stato Sardo,
si alza. Il pubblico continua a tenere
il cappello in testa.
Quattro G alli ed un capo ed otto druidi seguiti da
Oroveso, occupano la scena. Uno dei druidi veniva
innanzi tremando come se fosse staffilato per far
comprendere ch'era vecchio. Più di mezzo chilo-
gramma di lino gli serviva di barba. In cambio ve
n'era un altro con baffi e pizzo.
Ad Oroveso la barba giungeva alle ginocchia. Tutto
questo gruppo cominciò a cantare a tutto spiano,
levando le braccia con una simultaneità ed un ac
cordo che sventuratamente non impedivano loro di
levare la voce.
S'avanza Politone, un formidabile personaggio, che
comincia a gridare a squarciagola. Dopo pochi mi
nuti stona, poi erompe in una spaventosa stecca.
Il pubblico applaude, forse ironicamente.
Compare finalmente Norma, « figura non tragica,
nia patibolare, di grosse e scarnite ossa, d'aspetto
macilento
e
d'abito manierato». Canta la
Casta
dira
in tal modo che B e llin i non l'avrebbe ricono
sciuta. Fio ri ed applausi. Yussuf guarda orgoglio
samente i compagni. L'A larcón non ne può più e
lascia il teatro. L 'Y ria rte resta, certo per schizzare
qualche caricatura ( 13).
Dell'atroce delusione musicale lo scrittore di Guadix
si trovò indennizzato «piando nel Giardino Pubblico
s'imbattè in una ventina di soldati ed altrettanti
pescatori del Po. che. tenendosi per braccio, can
tavano con bellissime voci, sotto la luna (così ir
risa poco prima dalla sacerdotessa), il
Miserere
del
Trovatore.
A l
VHótel
egli ritrovò l'Y ria rte . fuggito... innanzi
ad Adalgisa, peggiore ancora di Norma. Solo Y'ussuf
era rimasto, impav ido, al Nazionale, trattenuto da
speciali impegni con il corpo dei cori. Erano le
nove di notte: i due decisero di recarsi al vicino
Teatro Carignano.
Si rappresentava il ballo
Esmeralda
, inspirato al
noto romanzo victorughiano. Regina della serata
era la signorina Salvioni. « ballerina assai bella,
sebbene troppo alta per una silfide » ( 14). Ma, più
che dal ballo, l'attenzione dei due nuovi spettatori
era richiamata da un personaggio se',•’,'' in un
palco di proscenio, con la spalle voltate ai pub
blico...
« D ima cinquantina d'anni, grassoccio, di piccola
statura, dall'alta fronte e dagli occhi vivissimi che
tralucevano attraverso gli occhiali, un po' trascu
rato, sebbene decoroso neU'abito. con una fisio
nomia più di scienziato, di bibliomane o di archeo
logo che di diplomatico o di guerriero, semplice,
insomma, nell'aspetto e nelle attitudini», egli an
dava scorrendo giornali su giornali, che deponeva
sul seggiolone accanto, lasciando la lettura solo
quando la Salvioni appariva in isccna. Avanzando
sino al parapetto del palco, egli afferrava allora il
binoccolo e lo puntava sulla voluttuosa Esmeralda.
Quel personaggio era « Papà Camillo », come lo
chiamavano i Torinesi: il conte di Cavour.
Un vicino diede aU'Alarcón minute notizie sulle
abitudini di vita del grande statista. Cavour si al
zava alle quattro di mattino e studiava fino alle
sei. A quell'ora cominciava a «sbrigare» i due o
tre ministeri che aveva sempre a suo carico. Alle
dieci lo si poteva vedere a passeggio per le vie di
Torino, alle undici si recava al Caffè del Cambio
(di fianco al Teatro), dove faceva colazione, con
fuso tra gli altri avventori. Poi si recava succes
sivamente al Palazzo Reale od al Consiglio dei
Ministri, ed al Parlamento. In seguito pranzava
splendidamente. Alla sera riceveva i diplomatici o
dava pubblica udienza. Alle dieci faceva una scap
patina a teatro, a veder ballare, e leggere i giornali
stranieri, a parlare dal proprio palco con le balle


















