
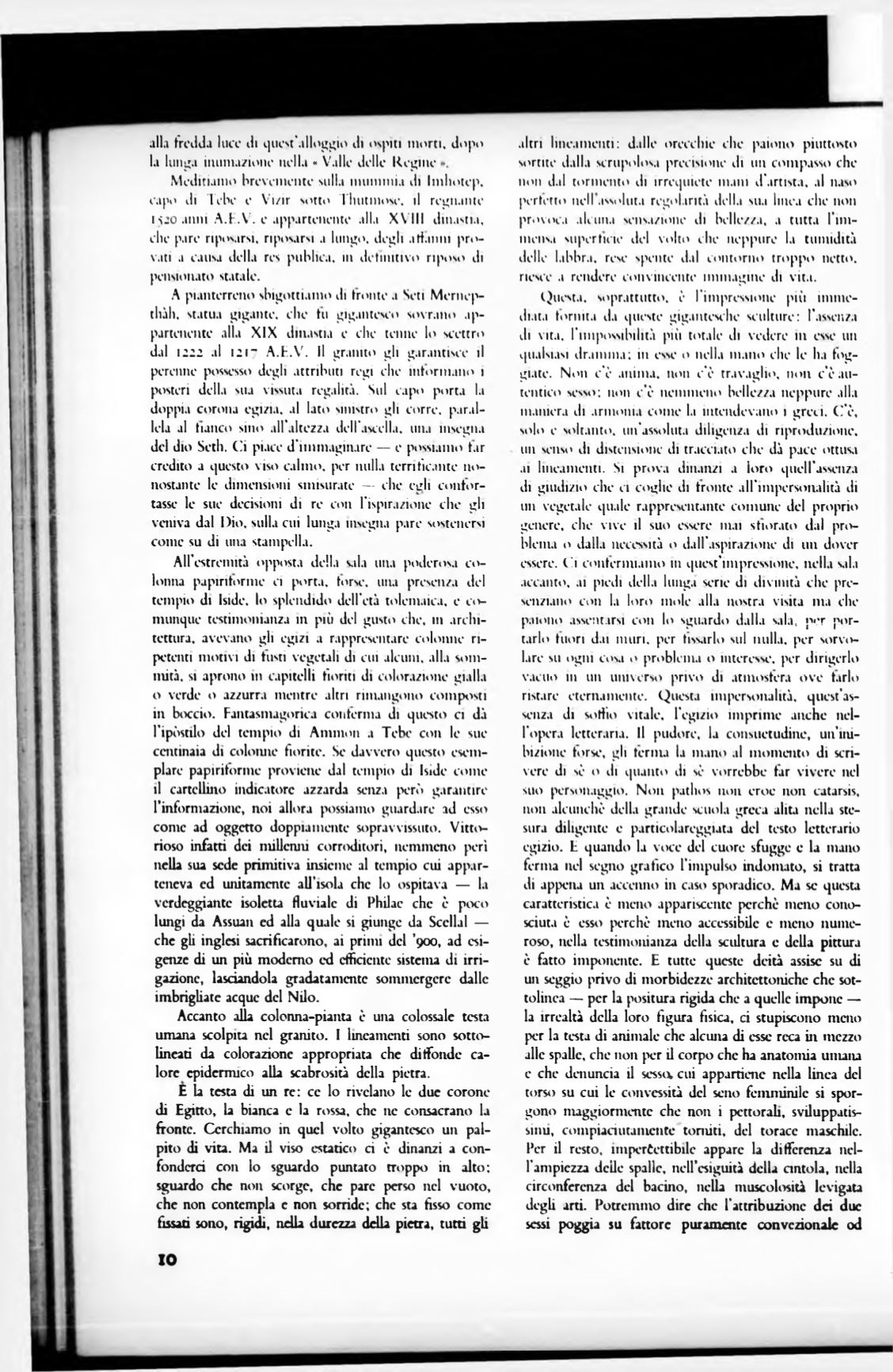
alla fredda luce di quest'alloggio di ospiti morti, dopo
la lunga inumazione nella « Valle delle Regine
Meditiamo brevemente sulla mummia ili Imliotep,
capo ili Tebe e Vi/ir sotto Tliutmose, il regnante
1 S-0 anni A.E.V. e appartenente alla XVIII dinastia,
elle pare riposarsi, riposarsi a lungo, degli affanni pro
vati .1 causa della res publica. in definitivo riposo di
pensionato statale.
A pianterreno sbigottiamo di fronte a Seti Mernep-
tlùh, statua gigante, che tu gigantesco sovrano ap
partenente alla XIX dinastia e che tenne lo scettro
dal 1222 al 12 17 A.E.V . Il granito gli garantisce il
perenne possesso degli attributi regi che intorniano 1
posteri della sua vissuta regalità. Sul capo porta la
doppia corona egizia, al lato sinistro gli corre, paral
lela al tianco sino all'altezza dell'ascella, una insegna
del dio Seth. Ci piace d'immaginare — e possiamo tar
credito a questo viso calmo, per nulla terrificante no
nostante le dimensioni smisurate — che eirli contor-
tasse le sue decisioni di re con l’ispirazione che gli
veniva dal Dio, sulla cui lunga insegna pare sostenersi
come su di una stampella.
All’estremità opposta della sala una poderosa co
lonna papintorme ci porta, torsi.-, una presenza del
tempio di Iside, lo splendido dell’età tolemaica, e co
munque testimonianza in più del gusto che, 111 archi
tettura, avevano gli egizi .1 rappresentare colonne ri
petenti motivi di fusti vegetali di cui alcuni, alla som
mità. si aprono 111 capitelli fioriti di colorazione gialla
o verde o azzurra mentre altri rimangono composti
in boccio. Fantasmagorica conferma di questo ci dà
l’ipòstilo del tempio di Aminoti .1 Tebe con le sue
centinaia di colonne fiorite. Se davvero questo esem
plare papiritorme proviene dal tempio di Iside come
il cartellino indicatore azzarda senza però garantire
l’informazione, noi allora possiamo guardare ad esso
come ad oggetto doppiamente sopravvissuto. Vitto-
rioso infatti dei millenni corroditori, nemmeno perì
nella sua sede primitiva insieme al tempio cui appar
teneva ed unitamente all’isola che lo ospitava — la
verdeggiante isoletta fluviale di Philae che è poco
lungi da Assuan ed alla quale si giunge da Scellal —
che gli inglesi sacrificarono, ai primi del '900, ad esi
genze di un più moderno cd efficiente sistema di irri
gazione, lasciandola gradatamente sommergere dalle
imbrigliate acque del Nilo.
Accanto alla colonna-pianta è una colossale testa
umana scolpita nel granito. I lineamenti sono sotto-
lineati da colorazione appropriata che diffonde ca
lore epidermico alla scabrosità della pietra.
E la testa di un re: ce lo rivelano le due corone
di Egitto, la bianca e la rossa, che ne consacrano la
fronte. Cerchiamo in quel volto gigantesco un pal
pito di vita. Ma il viso estatico ci è dinanzi a con
fonderci con lo sguardo puntato troppo in alto:
sguardo che non scorge, che pare perso nel vuoto,
che non contempla e non sorride; che sta fisso come
fissati sono, rigidi, nella durezza della pietra, tutti gli
altri lineamenti: dalle orecchie che paiono piuttosto
sortite dalla scrupolosa precisione di un compasso che
non dal tormento di irrequiete mani d’artista, al naso
perfetto nell assoluta regolarità della sua linea che non
provoca alcuna sensazione di bellezza, a tutta l’im
mensa superficie del volto che neppure la tumidità
delle labbra, rese spente dal contorno troppo netto,
riesce a rendere convincente immagine di vita.
Questa, soprattutto, è l’impressione più imme
diata tornita da queste gigantesche sculture: l’assenza
di vita, l’impossibilità più totale di vedere
111
esse un
qualsiasi dramma: in esse o nella mano che le ha fog
giate. Non c’è anima, non c’è travaglio, non c’è au
tentico sesso; 11011 c’è nemmeno bellezza neppure alla
maniera di armonia come la intendevano 1 greci. C ’è,
solo e soltanto, un’assoluta diligenza di riproduzione,
un senso di distensione di tracciato che dà pace ottusa
ai lineamenti. Si prova dinanzi a loro quell’assenza
di giudizio che ci coglie di fronte all'impersonalità di
1111
vegetale quale rappresentante comune del proprio
genere, che vive il suo essere 111.11 sfiorato dal pn>-
blema o dalla necessità o dall'aspirazione di
1111
dover
essere. Ci confermiamo in quest’impressione, nella sala
accanto, ai piedi della lunga serie di divinità che pre
senziano con la loro mole alla nostra visita ma che
paiono assentarsi con lo sguardo dalla sala, per por
tarlo fuori dai muri, per fissarlo sul nulla, per sorviv-
lure su ogni cosa o problema o interesse, per dirigerlo
vacuo 111 un universo privo di atmosfera ove tarlo
ristare eternamente. Questa impersonalità, quest’as
senza di soffio vitale, l’egizio imprime anche nel
l’opera letteraria. Il pudore, la consuetudine, un’ini
bizione torse, gli ferma la mano al momento di scri
vere di sè o di quanto di sì- vorrebbe tar vivere nel
suo personaggio. Non pathos 11011 eroe non catarsis,
non alcunché della grande scuola greca alita nella ste
sura diligente e particolareggiata del testo letterario
egizio. E quando la voce del cuore sfugge e la mano
ferma nel segno grafico l'impulso indomato, si tratta
di appena un accenno in caso sporadico. Ma se questa
caratteristica è meno appariscente perché meno cono
sciuta è esso perchè meno accessibile e meno nume
roso, nella testimonianza della scultura e della pittura
è fatto imponente. E tutte queste deità assise su di
un seggio privo di morbidezze architettoniche che sot
tolinea — per la positura rigida che a quelle impone —
la irrealtà della loro figura fisica, ci stupiscono meno
per la testa di animale che alcuna di esse reca in mezzo
alle spalle, che non per il corpo che ha anatomia umana
e che denuncia il sessa cui appartiate nella linea del
torso su cui le convessità del seno femminile si spor
gono maggiormente che non i pettorali, sviluppatis-
sinu, compiaciutamente torniti, del torace maschile.
Per il resto, imperfettibile appare la differenza nel
l’ampiezza delle spalle, nell’esiguità della cintola, nella
circonferenza del bacino, nella muscolosità levigata
degli arti. Potremmo dire che l’attribuzione dei due
sessi poggia su fattore puramente convczionalc od
IO


















