
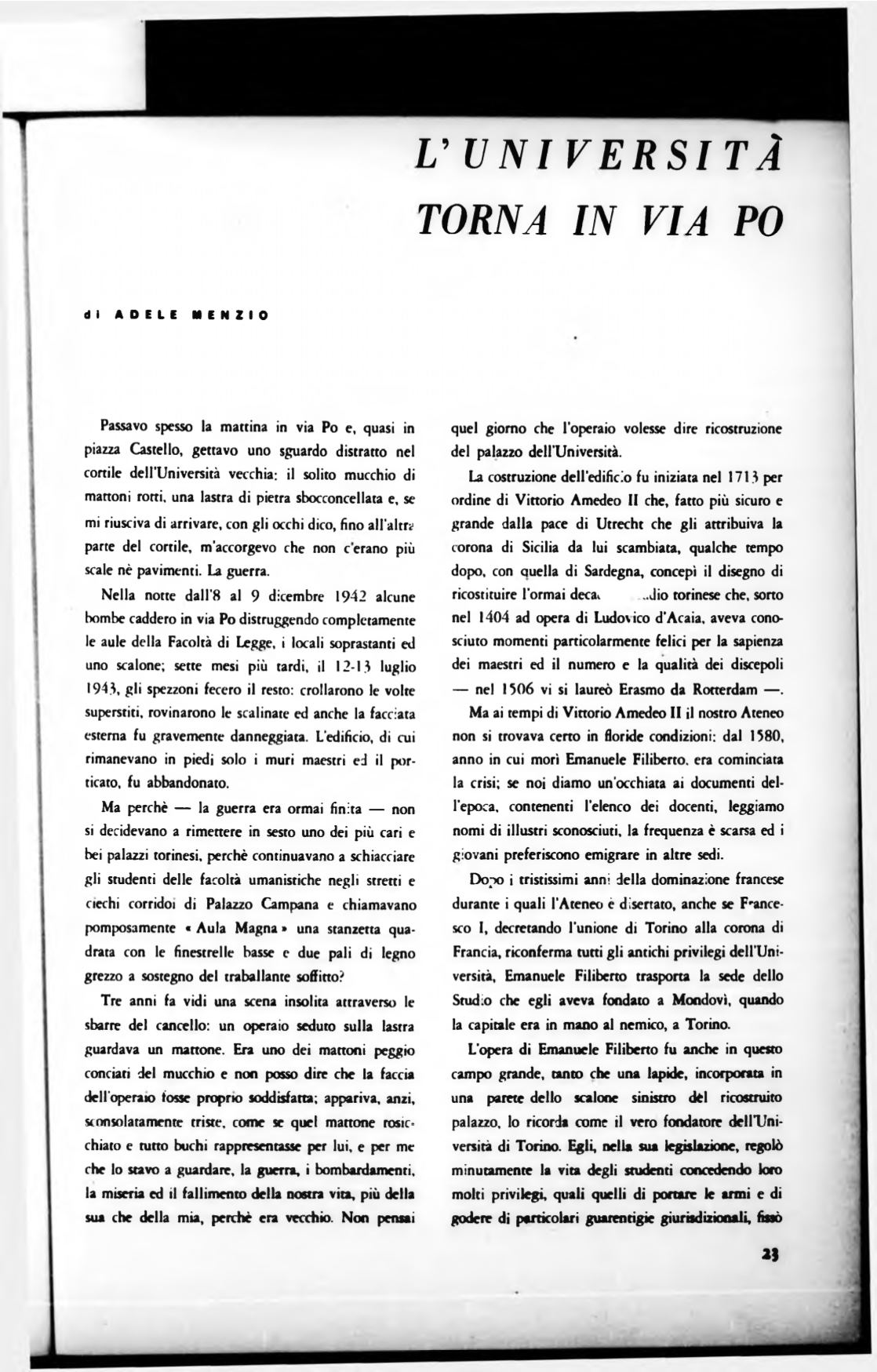
L ' U N I V E R S I T À
TORNA IN VIA PO
di A D E L E M E N Z I O
Passavo spesso la mattina in via Po e, quasi in
piazza Castello, gettavo uno sguardo distratto nel
cortile deH’Università vecchia: il solito mucchio di
mattoni rotti, una lastra di pietra sbocconcellata e, se
mi riusciva di arrivare, con gli occhi dico, fino all’altra
parte del cortile, m’accorgevo che non cerano più
scale nè pavimenti. La guerra.
Nella notte dall
'8
al 9 dicembre 1942 alcune
bombe caddero in via Po distruggendo completamente
le aule della Facoltà di Legge, i locali soprastanti ed
uno scalone; sette mesi più tardi, il
12 - 1 3
luglio
1943, gli spezzoni fecero il resto: crollarono le volte
superstiti, rovinarono le scalinate ed anche la facciata
esterna fu gravemente danneggiata. L’edificio, di cui
rimanevano in piedi solo i muri maestri ed il por
ticato, fu abbandonato.
Ma perchè — la guerra era ormai finita — non
si decidevano a rimettere in sesto uno dei più cari e
bei palazzi torinesi, perchè continuavano a schiacciare
gli studenti delle facoltà umanistiche negli stretti e
ciechi corridoi di Palazzo Campana e chiamavano
pomposamente « Aula Magna » una stanzetta qua
drata con le finestrelle basse e due pali di legno
grezzo a sostegno del traballante soffitto?
Tre anni fa vidi una scena insolita attraverso le
sbarre del cancello: un operaio seduto sulla lastra
guardava un mattone. Era uno dei mattoni peggio
conciari del mucchio e non posso dire che la faccia
dell'operaio fosse proprio soddisfatta; appariva, anzi,
sconsolatamente triste, come se quel mattone rosic
chiato e tutto buchi rappresentasse per lui, e per me
che lo stavo a guardare, la guerra, i bombardamenti,
la miseria ed il fallimento della nostra vita, più della
sua che della mia, perchè era vecchio. Non pensai
quel giorno che l’operaio volesse dire ricostruzione
del palazzo dell'Università.
La costruzione dell’edificio fu iniziata nel 1713 per
ordine di Vittorio Amedeo II che, fatto più sicuro e
grande dalla pace di Utrecht che gli attribuiva la
corona di Sicilia da lui scambiata, qualche tempo
dopo, con quella di Sardegna, concepì il disegno di
ricostituire l’ormai deca.
..dio torinese che, sono
nel 1404 ad opera di Ludo\ico d’Acaia, aveva cono
sciuto momenti particolarmente felici per la sapienza
dei maestri ed il numero e la qualità dei discepoli
— nel 1506 vi si laureò Erasmo da Rotterdam —.
Ma ai tempi di Vittorio Amedeo II il nostro Ateneo
non si trovava certo in floride condizioni: dal 1580,
anno in cui morì Emanuele Filiberto, era cominciata
la crisi; se noi diamo un'occhiata ai documenti del
l’epoca, contenenti l’elenco dei docenti, leggiamo
nomi di illustri sconosciuti, la frequenza è scarsa ed i
giovani preferiscono emigrare in altre sedi.
Dopo i tristissimi anni della dominazione francese
durante i quali l'Ateneo è disertato, anche se F-ance-
sco I, decretando l’unione di Torino alla corona di
Francia, riconferma tutti gli antichi privilegi dell’Uni-
versità, Emanuele Filiberto trasporta la sede dello
Studio che egli aveva fondato a Mondovì, quando
la capitale era in mano al nemico, a Torino.
L’opera di Emanuele Filiberto fu anche in questo
campo grande, tanto che una lapide,
incorporata in
una parete dello scalone sinistro dèi ricostruito
palazzo, lo ricorda come il vero fondatore dell’un i
versità di Torino. Egli, nella sua legislazione, regolò
minutamente la vita degli studenti concedendo loro
molti privilegi, quali quelli di portare le armi e di
godere di particolari guarentigie giurisdizionali, fissò
23


















