
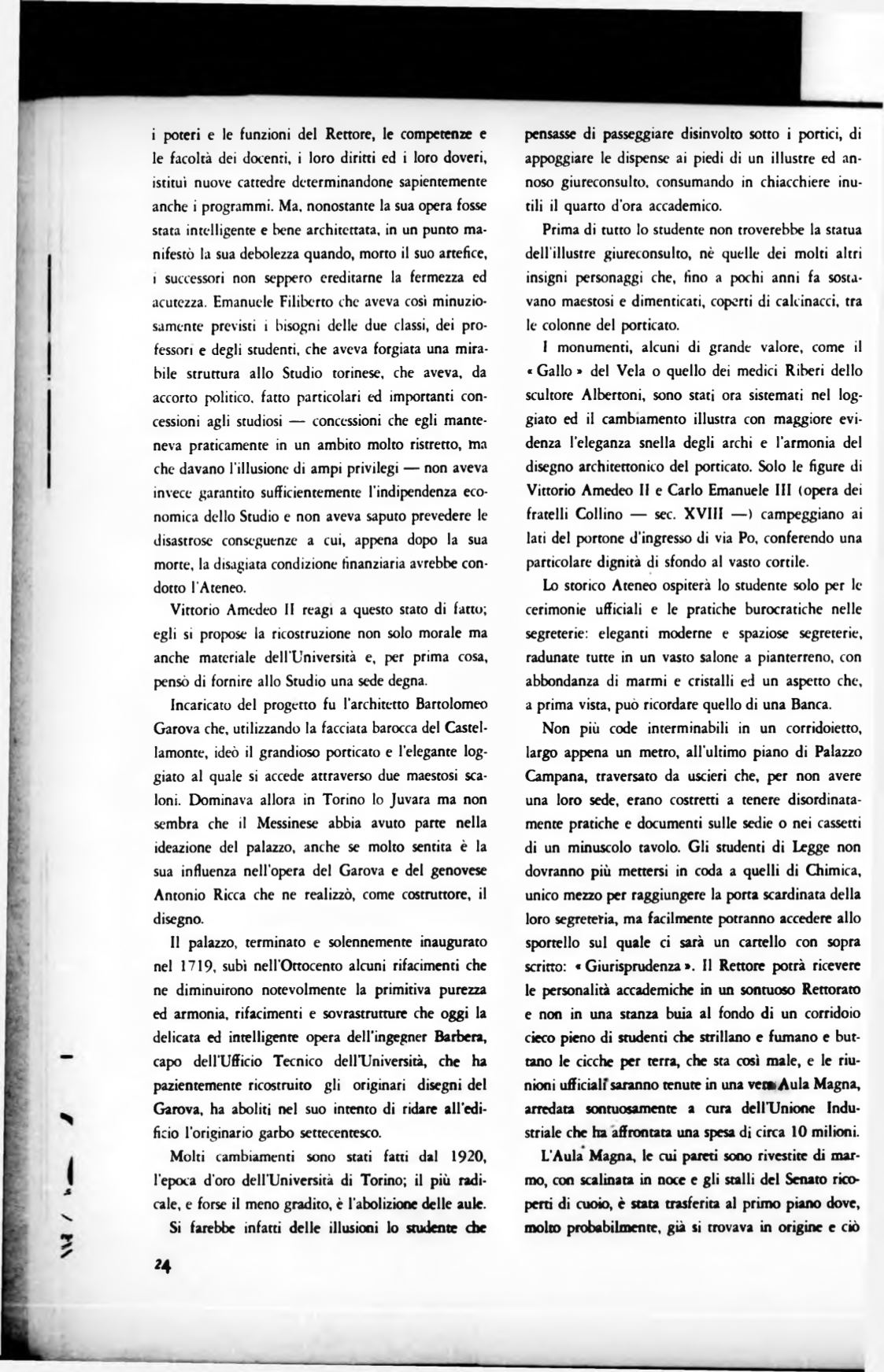
i poteri e le funzioni del Rettore, le competenze e
le facoltà dei docenti, i loro diritti ed i loro doveri,
istituì nuove cattedre determinandone sapientemente
anche i programmi. Ma, nonostante la sua opera fosse
stata intelligente e bene architettata, in un punto ma
nifestò la sua debolezza quando, morto il suo artefice,
i successori non seppero ereditarne la fermezza ed
acutezza. Emanuele Filiberto che aveva così minuzio
samente previsti i bisogni delle due classi, dei pro
fessori e degli studenti, che aveva forgiata una mira
bile struttura allo Studio torinese, che aveva, da
accorto politico, fatto particolari ed importanti con
cessioni agli studiosi — concessioni che egli mante
neva praticamente in un ambito molto ristretto, ma
che davano l'illusione di ampi privilegi — non aveva
invece garantito sufficientemente l’indipendenza eco
nomica dello Studio e non aveva saputo prevedere le
disastrose conseguenze a cui, appena dopo la sua
morte, la disagiata condizione finanziaria avrebbe con
dotto l'Ateneo.
Vittorio Amedeo II reagì a questo stato di fatto;
egli si propose la ricostruzione non solo morale ma
anche materiale dell'Università e, per prima cosa,
pensò di fornire allo Studio una sede degna.
Incaricato del progetto fu l’architetto Bartolomeo
Garova che, utilizzando la facciata barocca del Castel-
lamonte, ideò il grandioso porticato e l’elegante log
giato al quale si accede attraverso due maestosi sca
loni. Dominava allora in Torino lo Juvara ma non
sembra che il Messinese abbia avuto parte nella
ideazione del palazzo, anche se molto sentita è la
sua influenza nell’opera del Garova e del genovese
Antonio Ricca che ne realizzò, come costruttore, il
disegno.
Il
palazzo, terminato e solennemente inaugurato
nel 1719, subì neH’Ottocenro alcuni rifacimenti che
ne diminuirono notevolmente la primitiva purezza
ed armonia, rifacimenti e sovrastrutture che oggi la
delicata ed intelligente opera dell’ingegner Barbera,
capo dell’Ufficio Tecnico dell’Università, che ha
pazientemente ricostruito gli originari disegni del
Garova, ha aboliti nel suo intento di ridare all’edi
ficio l’originario garbo settecentesco.
Molti cambiamenti sono stati fatti dal 1920,
l’epoca d'oro dell’Università di Torino; il più radi
cale, e forse il meno gradito, è l’abolizione delle aule.
Si farebbe infatti delle illusioni lo studente che
pensasse di passeggiare disinvolto sotto i portici, di
appoggiare le dispense ai piedi di un illustre ed an
noso giureconsulto, consumando in chiacchiere inu
tili il quarto d’ora accademico.
Prima di tutto lo studente non troverebbe la statua
dell'illustre giureconsulto, nè quelle dei molti altri
insigni personaggi che, fino a pochi anni fa sosta
vano maestosi e dimenticati, coperti di calcinacci, tra
le colonne del porticato.
I
monumenti, alcuni di grande valore, come il
«Gallo » del Vela o quello dei medici Riberi dello
scultore Albertoni, sono stati ora sistemati nel log
giato ed il cambiamento illustra con maggiore evi
denza l’eleganza snella degli archi e l’armonia del
disegno architettonico del porticato. Solo le figure di
Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III (opera dei
fratelli Collino — sec. XVIII —) campeggiano ai
lati del portone d’ingresso di via Po, conferendo una
particolare dignità di sfondo al vasto cortile.
Lo storico Ateneo ospiterà lo studente solo per le
cerimonie ufficiali e le pratiche burocratiche nelle
segreterie: eleganti moderne e spaziose segreterie,
radunate tutte in un vasto salone a pianterreno, con
abbondanza di marmi e cristalli ed un aspetto che,
a prima vista, può ricordare quello di una Banca.
Non più code interminabili in un corridoietto,
largo appena un metro, all’ultimo piano di Palazzo
Campana, traversato da uscieri che, per non avere
una loro sede, erano costretti a tenere disordinata-
mente pratiche e documenti sulle sedie o nei cassetti
di un minuscolo tavolo. Gli studenti di Legge non
dovranno più mettersi in coda a quelli di Chimica,
unico mezzo per raggiungere la porta scardinata della
loro segreteria, ma facilmente potranno accedere allo
sportello sul quale ci sarà un cartello con sopra
scritto: «Giurisprudenza ». Il Rettore potrà ricevere
le personalità accademiche in un sontuoso Rettorato
e non in una stanza buia al fondo di un corridoio
cieco pieno di studenti che strillano e fumano e but
tano le cicche per terra, che sta così male, e le riu
nioni ufficiali saranno tenute in una vemAula Magna,
arredata sontuosamente a cura dell’Unione Indu
striale che ha affrontata una spesa di circa
10
milioni.
L’Aula Magna, le cui pareti sono rivestite di mar
mo, con scalinata in noce e gli stalli del Senato rico
perti di cuoio, è stata trasferia al primo piano dove,
molto probabilmente, già si trovava in origine e ciò
* 4


















