
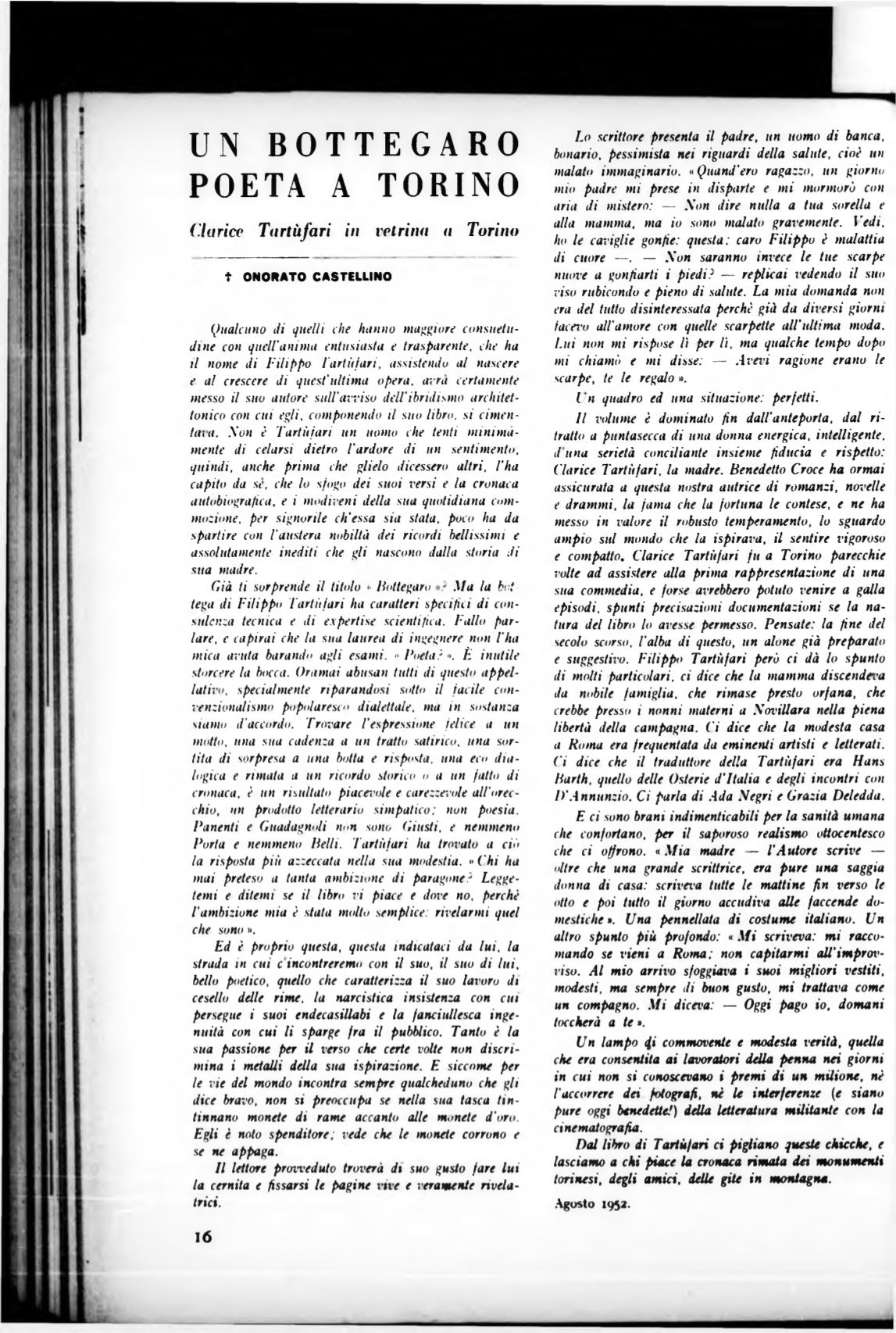
UN B O T T E G A R O
POETA A TORINO
('.lurice Tar tù fari in vetrina a Turino
t
ONORATO CASTELL INO
{inclinino di quelli che hanno maggiore consuetu
dine con quell'anima entusiasta e trasparente, che ha
il nome di I-'ilippo Tartùfari, assistendo al nascere
e al crescere di quest'ultima opera, arra certamente
messo il suo autore suH'avi'iso dell'ibridismo architet
tonico con cui egli, componendo il suo libro, si cimen
tata. Son è Tartùfari un uomo che tenti minima
mente di celarsi dietro l'ardore di un sentimento,
quindi, anche prima che glielo dicessero altri, l'ha
capito da se, che lo sfogo dei suoi versi e la cronaca
autobiografica, e i modiveni della sua quotidiana
com
mozione, per signorile ch'essa sia stata, poco ha da
spartire con l'austera nobiltà dei ricordi bellissimi e
assolutamente inediti che gli nascono dalla storia di
sua madre.
Già ti sorprende il titolo
<■
liottegaro
Ma la bot
tega di Filippo l'artùfari ha caratteri specifici di con
sulenza tecnica e di expertise scientifica. Fallo par
lare, e capirai che la sua laurea di ingegnere non l'ha
mica avuta barando agli esami. <• Poeta?
».
ti
inutile
storcere la bocca. Oramai abusati tutti di questo appel
lativo, specialmente riparandosi sotto il facile con
venzionalismo popolaresco dialettale, ma in sostanza
siamo d'accordo. Trovare l'espressione felice a un
motto, una sua cadenza a un tratto satirico, una sor
tita di sorpresa a una botta e risposta, una eco dia
logica e rimata a un ricordo storico o a un fatto di
cronaca, è un risultato piacrcole e carezzevole all'orec
chio, un prodotto letterario simpatico: non poesia.
Punenti e Guadagnoli non sono Giusti, e nemmeno
Porta e nemmeno Pelli. Tartùfari ha trovato a ciò
la risposta più azzeccata nella sua modestia.
<•
Chi ha
mai preteso a tanta ambizione di paragone? Legge
temi e ditemi se il libro vi piace e dove no, perchè
l'ambizione mia è stata molto semplice: rivelarmi quel
che sono
».
Ed è proprio questa, questa indicataci da lui, la
strada in cui c incontreremo con il suo, il suo di lui,
bello poetico, quello che caratterizza il suo lavoro di
cesello delle rime, la narcistica insistenza con cui
persegue i suoi endecasillabi e la fanciullesca inge
nuità con cui li sparge fra il pubblico. Tanto è la
sua passione per il verso che certe volte non discri
mina i metalli della sua ispirazione. E siccome per
le vie del mondo incontra sempre qualcheduno che gli
dice bravo, non si preoccupa se nella sua tasca tin
tinnano monete di rame accanto alle monete d'oro.
Egli è noto spenditore: vede che le monete corrono e
se ne appaga.
Il
lettore provveduto troverà di suo gusto fare lui
la cernita e fissarsi le pagine vive e veramente rivela
trici.
Lo scrittore presenta il padre, un uomo di banca,
bonario, pessimista nei riguardi della salute, cioè un
malato immaginario. «Quand'ero ragazzo, un giorno
mio padre mi prese in disparte e mi mormorò con
aria di mistero:
—
Son dire nulla a tua sorella e
alla mamma, ma io sono malato gravemente. Vedi,
ho le caviglie gonfie: questa: caro Filippo è malattia
di cuore
—. —
Son saranno invece le tue scarpe
nuove a gonfiarti i piedi
? —
replicai vedendo il suo
viso rubicondo e pieno di salute. La mia domanda non
era del tutto disinteressata perchè già da diversi giorni
tacevo all'amore con quelle scarpette all'ultima moda.
Liti non mi rispose lì per lì, ma qualche tempo dopo
mi chiamò e mi disse:
—
Avevi ragione erano le
scarpe, te le regalo
».
i n quadro ed una situazione: perfetti.
Il
volume è dominato fin dall'anteporta, dal
tratto a puntasecca di una donna energica, intelligente,
d una serietà conciliante insieme fiducia e rispetto:
Clarice Tartùfari, la madre. Benedetto Croce ha ormai
assicurata a questa nostra autrice di romanzi, novelle
e drammi, la fama che la fortuna le contese, e ne ha
messo in valore il robusto temperamento, lo sguardo
ampio sul mondo che la ispirava, il sentire vigoroso
e compatto. Clarice Tartùfari fu a Torino parecchie
volte ad assistere alla prima rappresentazione di una
sua commedia, e forse avrebbero potuto venire a galla
episodi, spunti precisazioni documentazioni se la na
tura del libro lo avesse permesso. Pensate: la fine del
secolo scorso, l'alba di questo, un alone già preparato
e suggestivo. Filippo Tartùfari però ci dà lo spunto
di molti particolari, ci dice che la mamma discendei'a
da nobile famiglia, che rimase presto orfana, che
crebbe presso i nonni materni a Sovillara nella piena
libertà della campagna. Ci dice che la modesta casa
a Roma era frequentata da eminenti artisti e letterati.
Ci dice che il traduttore della Tartùfari era Hans
Harth, quello delle Osterie d'Italia e degli incontri con
D'Annunzio. Ci parla di Ada Segri e Grazia Deledda.
E ci sono brani indimenticabili per la sanità umana
che confortano, per il saporoso realismo ottocentesco
che ci offrono. «Mia madre
—
l'Autore scrive
—
oltre che una grande scrittrice, era pure una saggia
donna di casa: scriveva tutte le mattine fin verso le
otto e poi tutto il giorno accudiva alle faccende do
mestiche ». Una pennellata di costume italiano. Un
altro spunto più profondo:
«
Mi scriveva: mi racco
mando se vieni a Roma: non capitarmi all'improv
viso. Al mio arrivo sfoggiava i suoi migliori vestiti,
modesti, ma sempre di buon gusto, mi trattava come
un compagno. Mi diceva:
—
Oggi pago io, domani
toccherà a te ».
Un lampo ^i commovente e modesta verità, quella
che era consentita ai lavoratori della penna nei giorni
in cui non si conoscevano i premi di un milione, nè
l'accorrere dei fotografi, nè le interferenze (e siano
pure oggi benedette!) della letteratura militante con la
cinematografia.
Dal libro di Tartùfari ci pigliano queste chicche, e
lasciamo a chi piace la cronaca rimata dei monumenti
torinesi, degli amici, delle gite in montagna.
Agosto 1952.
16


















