
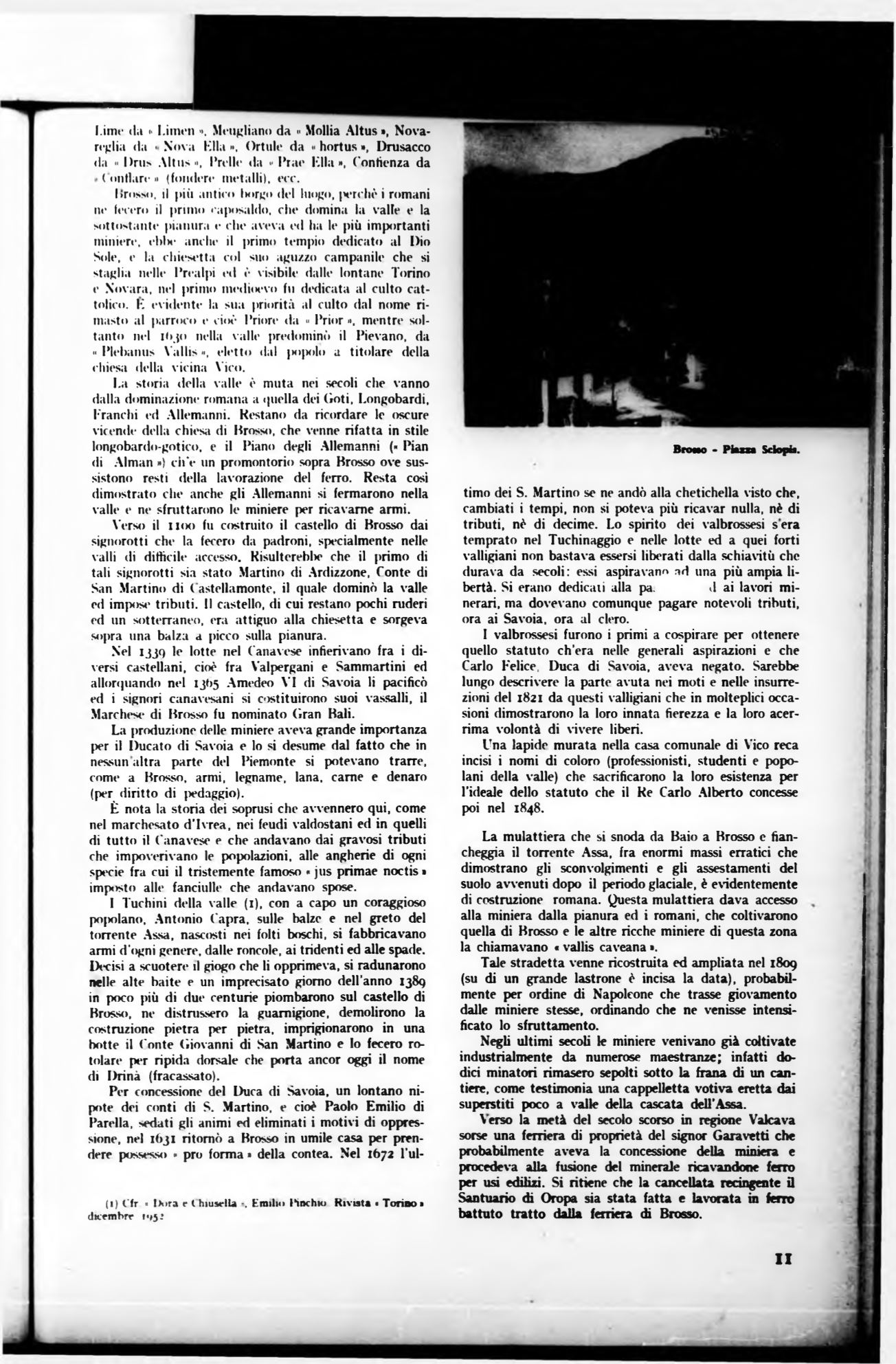
Limo da >• I.imen », Meugliano da «Mollia Altus », Nova-
reglia «la • Nova Klla », Ortule da
«
hortus », Drusacco
da »Drus Altus», Prelle da <■Prao Klla», Confienza da
• (onflare » (fondere metalli), ecc.
I>r«>s><», il più antico Imrgo del luogo, |vrchè i romani
ne fecero il primo caposaldo, che domina la valle e la
sottostante pianura e che aveva ed ha le più importanti
miniere, ebln* anche il primo tempio dedicato al Dio
Sole, e la chiesetta col suo aguzzo campanile che si
staglia nelle l‘realpi ed è visibile dalle lontane Torino
e Novara, nel primo medioevo fu dedicata al culto cat
tolico. K evidente la sua priorità al culto dal nome ri
masto al parroco e cioè Priore da »Prior », mentre sol
tanto nel K)jo nella valle predominò il Pievano, da
» Plebanus Vallis », eletto dal jxipolo a titolare della
chiesa della vicina Vico.
I.a storia della valle è muta nei secoli che vanno
dalla dominazione romana a quella dei (ioti, Longobardi,
Franchi ed Allemanni. Restano da ricordare le oscure
vicende della chiesa di Brosso, che venne rifatta in stile
longobardo-gotico, e il Piano degli Allemanni (« Pian
di Alman ») ch'e un promontorio sopra Brosso ove sus
sistono resti della lavorazione del ferro. Resta così
dimostrato che anche gli Allemanni si fermarono nella
valle e ne sfruttarono le miniere per ricavarne armi.
Verso il
IKK»
fu costruito il castello di Brosso dai
signorotti che la fecero da padroni, specialmente nelle
valli di difficile accesso. Kisultereblx1 che il primo di
tali signorotti sia stato Martino di Ardizzone, Conte di
San Martino di ( astellamonte, il quale dominò la valle
ed impose tributi. Il castello, di cui restano pochi ruderi
ed un sotterraneo, era attiguo alla chiesetta e sorgeva
sopra una balza a picco sulla pianura.
Nel 1339 le lotte nel Canavese infierivano fra i di
versi castellani, cioè fra Valpergani e Sammartini ed
allorquando nel 13O5 Amedeo VI di Savoia li pacificò
ed i signori canavesani si costituirono suoi vassalli, il
Marchese di Brosso fu nominato Gran Bali.
La produzione delle miniere aveva grande importanza
per il Ducato di Savoia e lo si desume dal fatto che in
nessun altra parte del Piemonte si potevano trarre,
come a Brosso, armi, legname, lana, carne e denaro
(per diritto di pedaggio).
È nota la storia dei soprusi che avvennero qui, come
nel marchesato d’Ivrea, nei feudi valdostani ed in quelli
di tutto il Canavese e che andavano dai gravosi tributi
che impoverivano le popolazioni, alle angherie di ogni
specie fra cui il tristemente famoso «jus primae noctis»
imposto alle fanciulle che andavano spose.
I
Tuchini della valle (1), con a capo un coraggioso
pojxilano, Antonio Capra, sulle balze e nel greto del
torrente Assa, nascosti nei folti boschi, si fabbricavano
armi d'ogni genere, dalle roncole, ai tridenti ed alle spade.
Decisi a scuotere il giogo che li opprimeva, si radunarono
nelle alte baite e un imprecisato giorno dell’anno 1389
in poco più di due centurie piombarono sul castello di
Brosso, ne distnissero la guarnigione, demolirono la
costruzione pietra per pietra, imprigionarono in una
botte il Conte Giovanni di San Martino e Io fecero ro
tolare per ripida dorsale che porta ancor oggi il nome
di Drinà (fracassato).
Per concessione del Duca di Savoia, un lontano ni
pote dei conti di S. Martino, e cioè Paolo Emilio di
Parella, sedati gli animi ed eliminati i motivi di oppres
sione, nel 1631 ritornò a Brosso in umile casa per pren
dere possesso <• prò forma » della contea. Nel 1672 l’ul(
1
) t'fr « !*>ra e Ihiusella -, Emilio l*inchio Rivista • Torino»
dtcrmbrr n>5-*
Brosso - P ian a Sclopii.
timo dei S. Martino se ne andò alla chetichella visto che,
cambiati i tempi, non si poteva più ricavar nulla, nè di
tributi, nè di decime. Lo spirito dei valbrossesi sera
temprato nel Tuchinaggio e nelle lotte ed a quei forti
valligiani non bastava essersi liberati dalla schiavitù che
durava da secoli: essi aspiravano nd una più ampia li
bertà. Si erano dedicati alla pa.
J ai lavori mi
nerari, ma dovevano comunque pagare notevoli tributi,
ora ai Savoia, ora al clero.
I
valbrossesi furono i primi a cospirare per ottenere
quello statuto ch’era nelle generali aspirazioni e che
Carlo Felice, Duca di Savoia, aveva negato. Sarebbe
lungo descrivere la parte avuta nei moti e nelle insurre
zioni del 1821 da questi valligiani che in molteplici occa
sioni dimostrarono la loro innata fierezza e la loro acer
rima volontà di vivere liberi.
Una lapide murata nella casa comunale di Vico reca
incisi i nomi di coloro (professionisti, studenti e popo
lani della valle) che sacrificarono la loro esistenza per
l’ideale dello statuto che il Re Carlo Alberto concesse
poi nel 1848.
La mulattiera che si snoda da Baio a Brosso e fian
cheggia il torrente Assa, fra enormi massi erratici che
dimostrano gli sconvolgimenti e gli assestamenti del
suolo avvenuti dopo il periodo glaciale, è evidentemente
di costruzione romana. Questa mulattiera dava accesso
alla miniera dalla pianura ed i romani, che coltivarono
quella di Brosso e le altre ricche miniere di questa zona
la chiamavano «vallis caveana ».
Tale stradetta venne ricostruita ed ampliata nel 1809
(su di un grande lastrone è incisa la data), probabil
mente per ordine di Napoleone che trasse giovamento
dalle miniere stesse, ordinando che ne venisse intensi
ficato lo sfruttamento.
Negli ultimi secoli le miniere venivano già coltivate
industrialmente da numerose maestranze; infatti do
dici minatori rimasero sepolti sotto la frana di un can
tiere, come testimonia una cappelletta votiva eretta dai
superstiti poco a valle della cascata dell’Assa.
Verso la metà del secolo scorso in regione Vaicava
sorse una ferriera di proprietà del signor Garavetti che
probabilmente aveva la concessione della miniera e
procedeva alla fusione del minerale ricavandone ferro
per usi edilizi. Si ritiene che la cancellata recingente il
Santuario di Oropa sia stata fatta e lavorata in ferro
battuto tratto dalla ferriera di Brosso.
II


















