
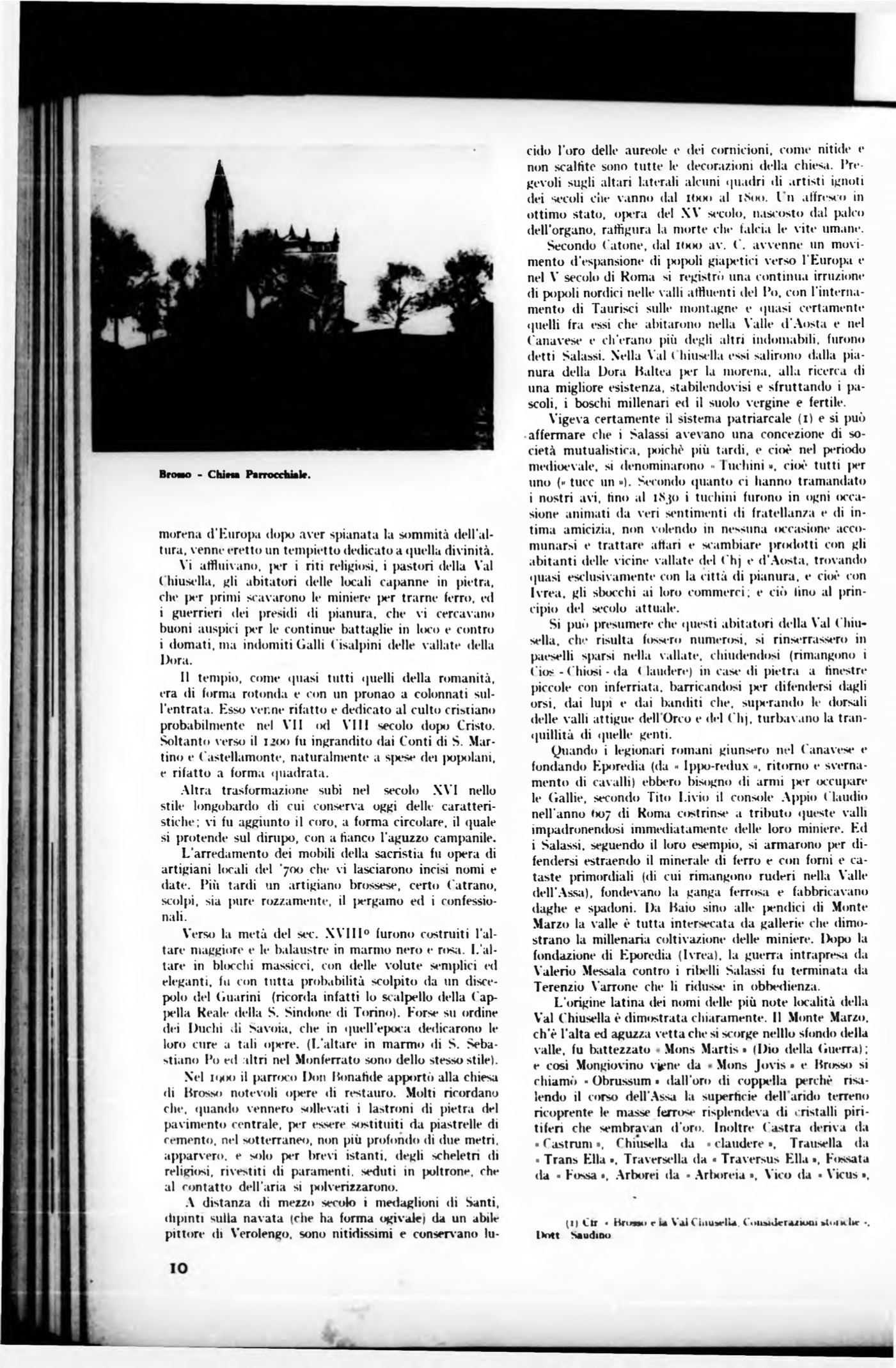
i
Brotso - China Parrocchiale.
morena d'Europa dopo aver spianata la sommità dell'al
tura, venne eretto un tempietto dedicato a quella divinità.
Vi affluivano, j>er i riti religiosi, i pastori della Val
(hiusella, gli abitatori delle locali capanne in pietra,
che |>er primi scavarono le miniere j>er trarne ferro, ed
i guerrieri dei presidi di pianura, che vi cercavano
buoni auspici per le continue battaglie in loco e contro
i domati, ma indomiti Galli Cisalpini delle vallate della
Dora.
Il
tempio, come (piasi tutti quelli della romanità,
era di forma rotonda e con un pronao a colonnati sul
l'entrata. Esso venne rifatto e dedicato al culto cristiano
probabilmente nel VII od Vi l i secolo dopo Cristo.
Soltanto verso il i »oo fu ingrandito dai Conti di S. Mar
tino e Castellamonte, naturalmente a spese dei popolani,
e rifatto a forma quadrata.
Altra trasformazione subi nel secolo XVI nello
stile longobardo di cui conserva oggi delle caratteri
stiche; vi fu aggiunto il coro, a forma circolare, il quale
si protende sul dirupo, con a fianco l'aguzzo campanile.
L ’arredamento dei mobili della sacristia fu opera di
artigiani locali del '700 che vi lasciarono incisi nomi e
date. Più tardi un artigiano brossese, certo Catrano,
scolpì, sia pure rozzamente, il j>ergamo ed i confessio
nali.
Verso la metà del sec. XVI
11
° furono costruiti l’al
tare maggiore e le balaustre in marmo nero e rosa. I.'al
tare in blocchi massicci, con delle volute semplici ed
eleganti, fu con tutta probabilità scolpito da un disce
polo del Guarini (ricorda infatti lo scalpello della Cap
itila Reale della S. Sindone di Torino). Forse su ordine
dei Duchi di Savoia, che in quell’epoca dedicarono le
loro cure a tali opere. (L'altare in marmo di S. Seba
stiano Po ed altri nel Monferrato sono dello stesso stile).
Nel H|oo il parroco Don Honatìde apportò alla chiesa
di Hrosso notevoli opere di restauro. Molti ricordano
che, quando vennero sollevati i lastroni di pietra del
pavimento centrale, per essere sostituiti da piastrelle di
cemento, nel sotterraneo, non più profondo di due metri,
apparvero, e solo per brevi istanti, degli scheletri di
religiosi, rivestiti di paramenti, seduti in poltrone, che
al contatto dell’aria si polverizzarono.
A distanza di mezzo secolo i medaglioni di Santi,
dipinti sulla navata (che ha forma ogivale) da un abile
pittore di Verolengo, sono nitidissimi e conservano lu
cido l’oro delle aureole e dei cornicioni, come nitide e
non scalfite sono tutte le decorazioni della chiesa. Pre
gevoli sugli altari laterali alcuni quadri di artisti ignoti
dei secoli che vanno dal K
kmi
al 1S00. I n affresco in
ottimo stato, opera del XV secolo, nascosto dal palco
dell’organo, raffigura la morte che falcia le vite umane.
Secondo Catone, dal
i(h h )
av. C. avvenne un movi
mento d'espansione di jMtpoli giapetici verso l’Europa e
nel V secoli) di Roma si registrò una continua irruzione
di popoli nordici nelle valli affluenti ilei Po, con l'interna
mento di Taurisci sulle montagne e quasi certamente
quelli fra essi che abitarono nella Valle d'Aosta e nel
Canavese e eli'erano più degli altri indomabili, furono
detti Salassi. Nella Val ( hiusella essi salirono dalla pia
nura della Dora Baltea
jht
la morena, alla ricerca di
una migliore esistenza, stabilendovisi e sfruttando i pa
scoli, i boschi millenari ed il suolo vergine e fertile.
Vigeva certamente il sistema patriarcale (I) e si può
affermare che i Salassi avevano una concezione di so
cietà mutualistica, poiché più tardi, e cioè nel periodo
medioevale, si denominarono ■ Inchini », cioè tutti |x*r
uno (>• tucc 1111 *•). Secondo quanto ci hanno tramandato
i nostri avi, fino al
i
S
jo
i tuchini furono in ogni occa
sione animati da veri sentimenti di fratellanza e di in
tima amicizia, non volendo in nessuna occasione acco
munarsi e trattare affari e scambiare prodotti con gli
abitanti delle vicine vallate del Chj e d’Aosta, trovando
quasi esclusivamente con la città di pianura, e cioè con
Ivrea, gli sbocchi ai loro commerci; e ciò lino al prin
cipio del secolo attuale.
Si può presumere che questi abitatori della Val Chiu-
sella, che risulta fossero numerosi, si rinserrassero in
paeselli sparsi nella vallate, chiudendosi (rimangono i
Cios - Chiosi - da < lamiere) in case ili pietra a finestre
piccole con inferriata, barricandosi j>er difendersi dagli
orsi, dai lupi e dai banditi che, superando le dorsali
delle valli attigue dell Orco e del Chj, turbavano la tran
quillità di quelle genti.
Quando i legionari romani giunsero nel Canavese e
fondando Eporedia (da » Ippo-redux », ritorno e sverna
mento di cavalli) ebbero bisogno di armi
jht
occupare
le Gallie, secondo Tito Livio il console Appio Claudio
nell'anno (>07 di Roma costrinse a tributo queste valli
impadronendosi immediatamente delle loro miniere. Ed
i Salassi, seguendo il loro esempio, si armarono per di
fendersi estraendo il minerale di ferro e con forni e ca
taste primordiali (di cui rimangono ruderi nella Valle
dell’Assa), fondevano la ganga ferrosa e fabbricavano
daghe e spadoni. Da Baio sino alle [«endici di Monte
Marzo la valle è tutta intersecata da gallerie che dimo
strano la millenaria coltivazione delle miniere. Dopo la
fondazione di Eporedia (Ivrea), la guerra intrapresa da
Valerio Messala contro i nln-lli Salassi fu terminata da
Terenzio Vairone che li ridusse in obbedienza.
L'origine latina dei nomi delle più note località della
Val Chiusella è dimostrata chiaramente. Il Monte Marzo,
ch’è l’alta ed aguzza vetta che si scorge nelllo sfondo della
valle, fu battezzato Mons Martis » (Dio della Guerra);
e cosi Mongiovino v^ne ila Mons Jovis • e Krosso si
chiamò »Obrussum • dall'oro di coprila perchè risa
lendo il corso dell’Assa la superficie dettando terreno
ricoprente le masse ferrose risplendeva di cristalli piri-
tiferi che sembravan d’oro. Inoltre Castra deriva da
• Castrum», Chiusella da • claudere », Trausella da
«Trans Ella ». Traversala da «Traversus Ella », Fossata
da • Fossa », Arborei da - Arboreia », Vico da • Vicus »,
( l | C t r • B r i n a l i
r
u V a i C h i u s e l i * . C o iu » u lc r a U Ìu iii » l o l k l i c -,
LVttt Saudino


















