
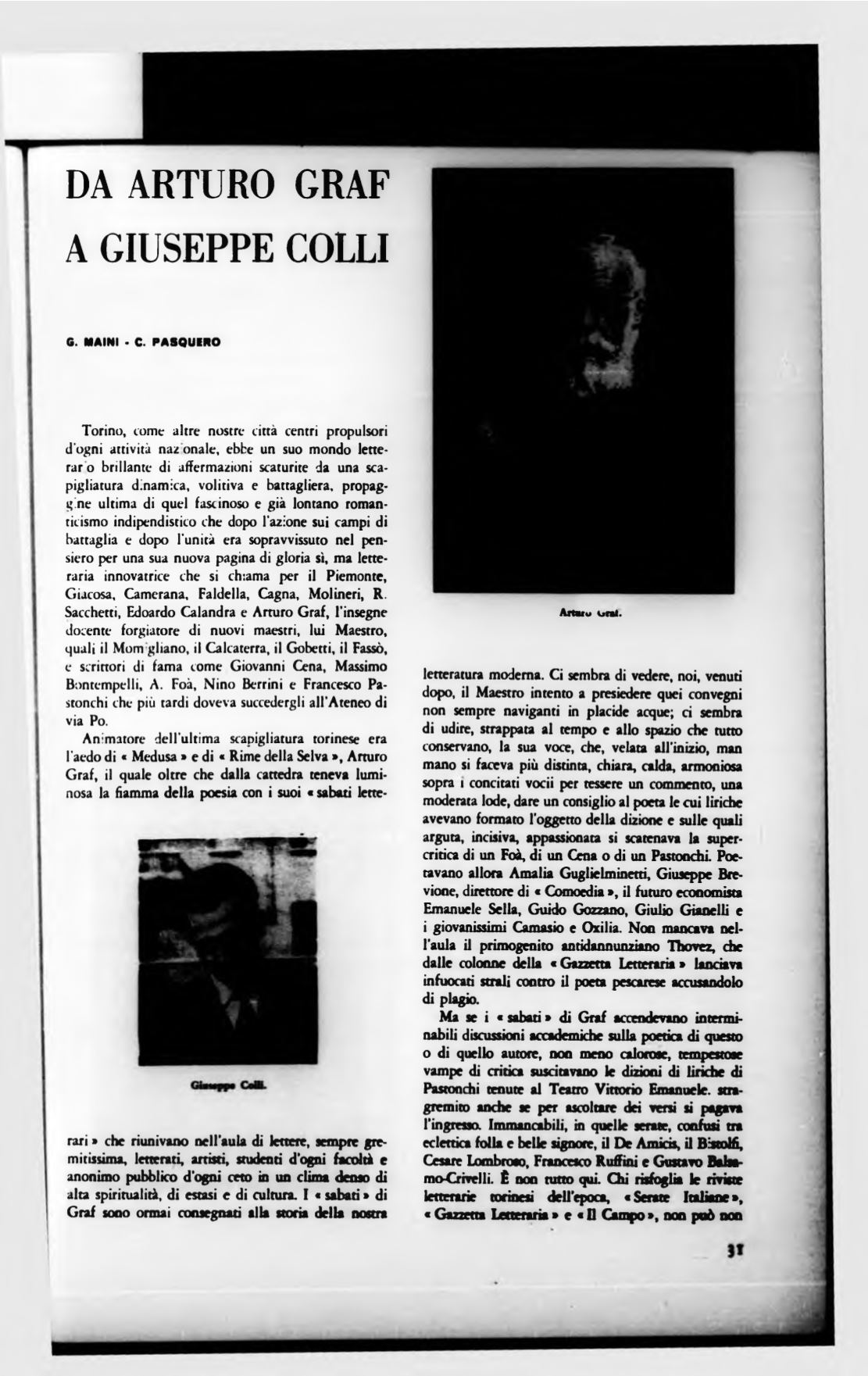
DA ARTURO GRAF
A GIUSEPPE COLLI
G. MAINI - C. PASQUERO
Torino, come altre nostre città centri propulsori
d'ogni attività naz onale, ebbe un suo mondo lette-
rar o brillante di affermazioni scaturite da una sca
pigliatura dinamica, volitiva e battagliera, propag
ane ultima di quel fascinoso e già lontano roman
ticismo indipendistico che dopo l’azione sui campi di
battaglia e dopo l'unità era sopravvissuto nel pen
siero per una sua nuova pagina di gloria sì, ma lette
raria innovatrice che si chiama per il Piemonte,
Giacosa, Camerana, Faldella, Cagna, Molineri, R.
Sacchetti, Edoardo Calandra e Arturo Graf, l'insegne
docente forgiatore di nuovi maestri, lui Maestro,
quali il Mom gliano, il Calcaterra, il Gobetti, il Fassò,
e scrittori di fama come Giovanni Cena, Massimo
Bontempelii, A. Foà, Nino Berrini e Francesco Pa-
stonchi che più tardi doveva succedergli all’Ateneo di
via Po.
Animatore dell'ultima scapigliatura torinese era
l’aedo di « Medusa » e di « Rime della Selva », Arturo
Graf, il quale oltre che dalla cattedra teneva lumi
nosa la fiamma della poesia con i suoi « sabati lette
rari » che riunivano nell’aula di lettere, sempre gre
mitissima, letterati, artisti, studenti d’ogni facoltà e
anonimo pubblico d'ogni ceto in un clima denso di
alta spiritualità, di estasi e di cultura. I « sabati » di
Graf sono ormai consegnati alla storia della nostra
Astato u n i.
letteratura moderna. Ci sembra di vedere, noi, venuti
dopo, il Maestro intento a presiedere quei convegni
non sempre naviganti in placide acque; ci sembra
di udire, strappata al tempo e allo spazio che tutto
conservano, la sua voce, che, velata all’inizio, man
mano si faceva più distinta, chiara, calda, armoniosa
sopra i concitati vocii per tessere un commento, una
moderata lode, dare un consiglio al poeta le cui liriche
avevano formato l’oggetto della dizione e sulle quali
arguta, incisiva, appassionata si scatenava la super-
critica di un Foà, di un Cena o di un Pastonchi. Poe
tavano allora Amalia GuglieIminetti, Giuseppe Bre-
vione, direttore di « Comoedia », il futuro economista
Emanuele Sella, Guido Gozzano, Giulio Gianelli e
i giovanissimi Camasio e Oxilia. Non mancava nel
l’aula il primogenito antidannunziano Thovez, die
dalle colonne della « Gazzetta Letteraria » lanciava
infuocati strali contro il poeta pescarese accusandolo
di plagio.
Ma se i « sabati » di Graf accendevano intermi
nabili discussioni accademiche sulla poetica di questo
o di quello autore, non meno calorose, tempestose
vampe di critica suscitavano le dizioni di liriche di
Pastonchi tenute al Teatro Vittorio Emanuele, stra-
gremito anche se per ascoltare dei versi si pagava
l’ingressa Immancabili, in quelle serate, confusi tra
eclettica folla e belle signore, il De Amiàs, il Biscotti,
Cesare Lombroso, Francesco Ruffini e Gustavo Balsa-
mo-Crivelli. È non tutto qui. Chi risfòglia le rivisse
letterarie torinesi dell’epoca, «Serale Italiane »,
« Gazzetta Letteraria » e « Il Campo »,
non può non


















