
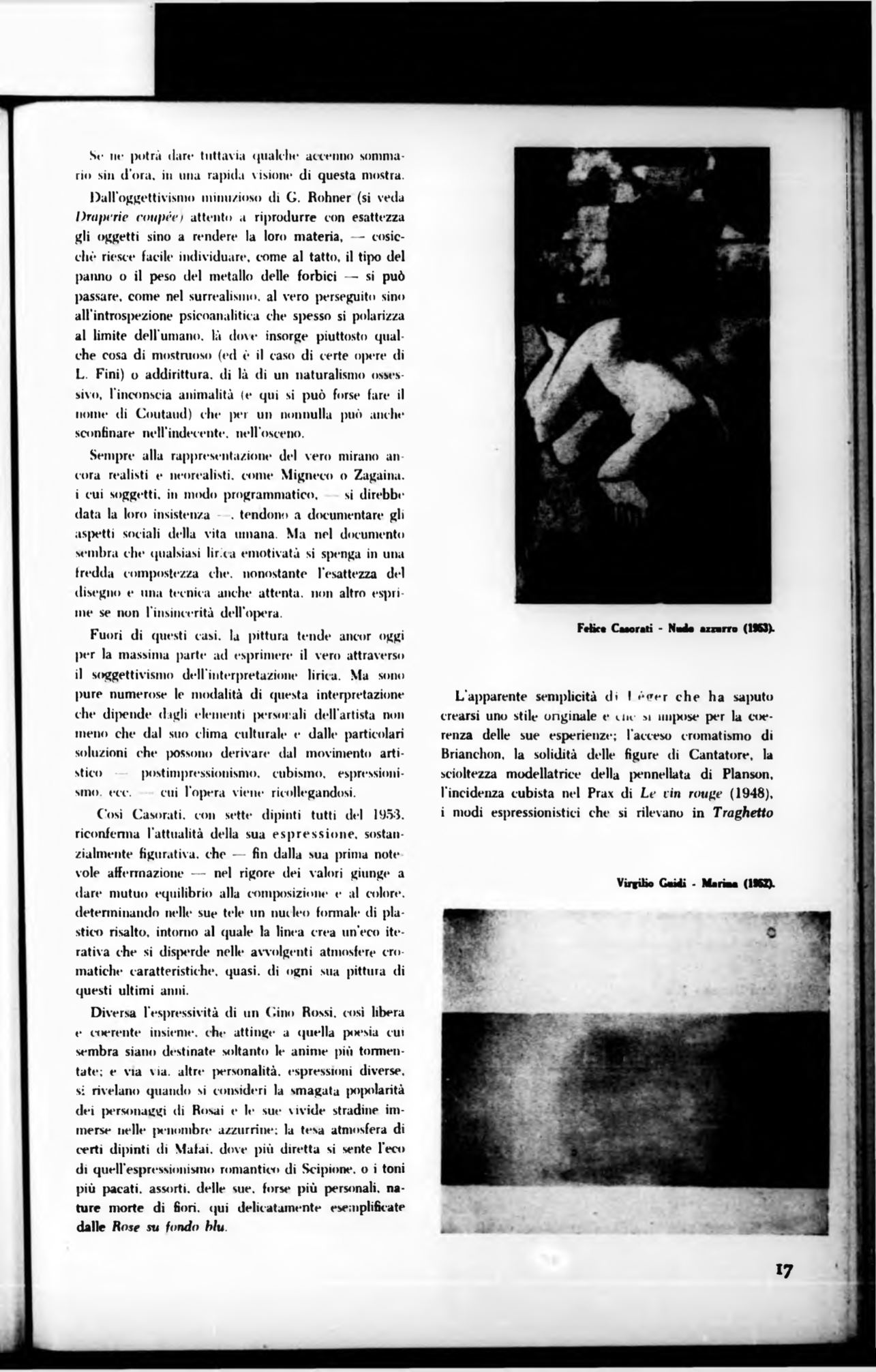
Se in* potrà ilare tuttavia qualche accenno somma
rio sin d ’ora, ili una rapida visione di questa mostra.
Dall’oggettivismo minuzioso di G. Rohner (si veda
Druperie cotipée)
attento a riprodurre con esattezza
gli oggetti sino a rendere la loro materia, — cosic
ché riesce facile individuare, come al tatto, il tipo del
panno o il peso del metallo delle forbici — si può
passare, come nel surrealismo, al vero perseguito sino
all’introspezione psicoanalitica che spesso si polarizza
al limite dell'umano, là dove insorge piuttosto qual
che cosa di mostruoso (ed è il caso di certe ojiere di
L. Fini) o addirittura, di là di un naturalismo osses
sivo, l'inconscia animalità (e qui si può forse fare il
nome di Coutaud) che per un nonnulla può anche
sconfinare nell’indecente, nell'osceno.
Sempre alla rappresentazione del vero mirano an
cora realisti e neorealisti, come Nligneco o Zagaina.
i cui soggetti, ili modo programmatico.
si direbbe
data la loro insistenza —, tendono a documentare gli
aspetti sociali della vita umana. Ma nel documento
sembra che qualsiasi lirica emotivatà si spenga in una
fredda compostezza che. nonostante l’esattezza del
disegno e una tecnica anche attenta, non altro espri
me se non l'insincerità dell’opera.
Fuori di questi casi, la pittura tende ancor oggi
per la massima parte ad esprimere il vero attraverso
il soggettivismo deU'interpretazione lirica. Ma sono
pure numerose le modalità di questa interpretazione
che dipende dagli elementi |M‘rsoi:ali dell’artista non
meno che dal suo clima culturale e dalle particolari
soluzioni ohe possono derivare dal movimento arti
stico — postimpressionismo, cubismo, espressioni
smo. ecc. — cui l'opera viene ricollegandosi.
Così Casorati, con sette dipinti tutti del 1953.
riconferma l'attualità della sua e s p r e s s io n e , sostan
zialmente figurativa, che — fin dalla sua prima note
vole affermazione — nel rigore dei valori giunge a
dare mutuo equilibrio alla composizione e al colore,
determinando nelle sue tele un nucleo formale di pla
stico risalto, intorno al quale la linea crea un’eco ite
rativa che si disperde nelle avvolgenti atmosfere cro
matiche caratteristiche, quasi, di ogni sua pittura di
questi ultimi anni.
Diversa l’espressività di un Gino Rossi, così libera
e coerente insieme, che attinge a quella poesia cui
sembra siano destinate soltanto le anime più tormen
tate; e via via. altre (ìersonalità. espressioni diverse,
si rivelano quando si consideri la smagata popolarità
dei personaggi di Rosai e le sue vivide stradine im
merse nelle penombre azzurrine; la tesa atmosfera di
certi dipinti di Mafai, dove più diretta si sente l'eco
di quell’espressionismo romantico di Scipione, o i toni
più pacati, assorti, delle sue. forse più personali,
na
ture
morte di fiori, qui delicatamente esemplificate
dalle
Rose su fondo blu.
Felic. Caiorati - Nudo azzurro (1963).
L’apparente semplicità d i I è p e r c h e h a saputo
crearsi uno stile originale e uu- si impose per la coe
renza delle sue esperienze; l’acceso cromatismo di
Brianchon, la solidità delle figure di Cantatore, la
scioltezza modellatrice della pennellata di Planson,
l’incidenza cubista nel Prax di
Le vin rouge
(1948),
i modi espressionistici che si rilevano in
Traghetto
Viriilio Gnidi - Marina (1952).
17


















