
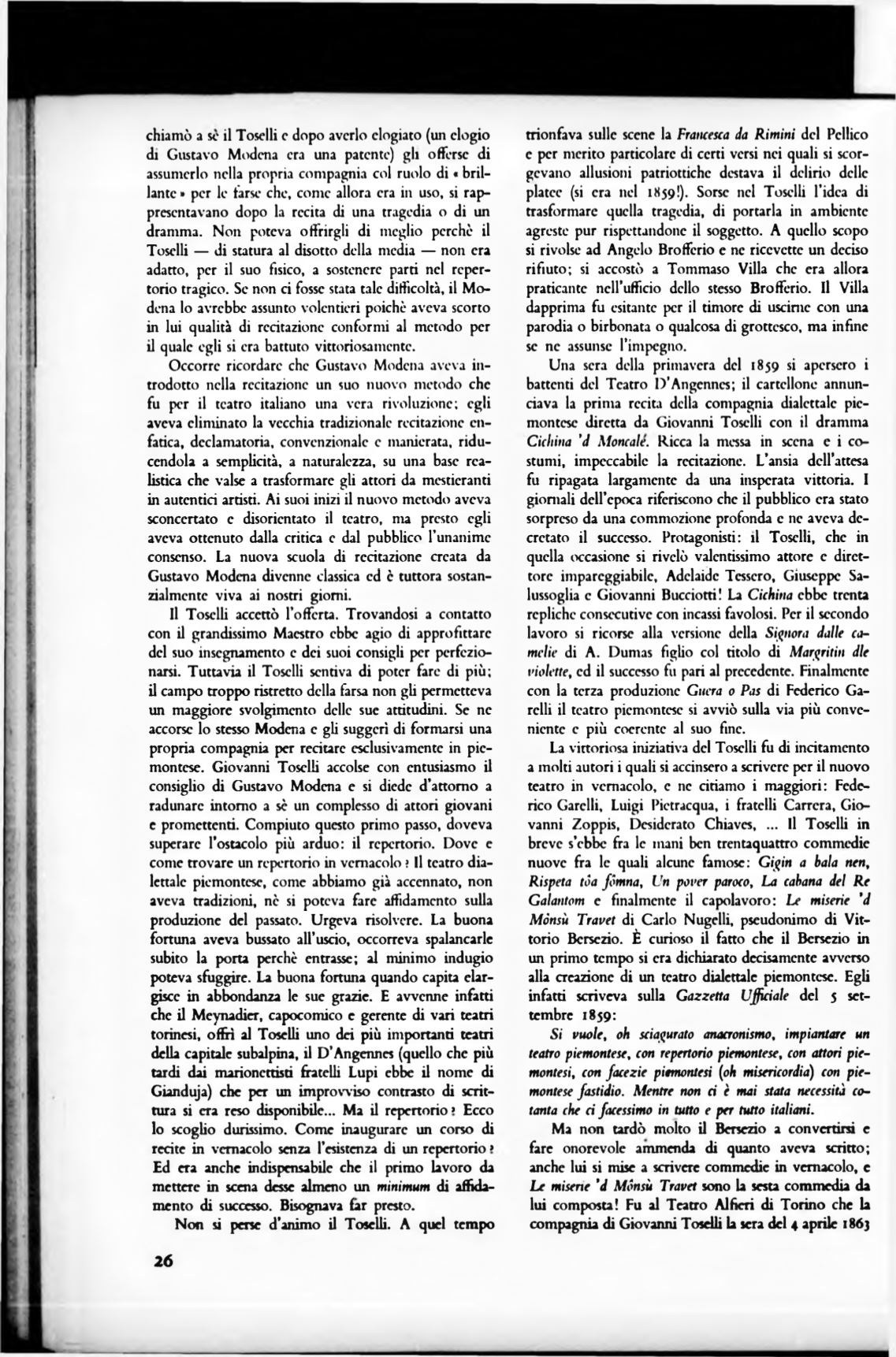
chiamò a se il Tosclli c dopo averlo elogiato (un elogio
di Gustavo Modena era una patente) gli offerse di
assumerlo nella propria compagnia col ruolo di « bril
lante » per le farse che, come allora era in uso, si rap
presentavano dopo la recita di una tragedia o di un
dramma. Non poteva offrirgli di meglio perchè il
Tosclli — di sutura al disotto della media — non era
adatto, per il suo fisico, a sostenere parti nel reper
torio tragico. Se non ci fosse stata tale difficoltà, il Mo
dena lo avrebbe assunto volentieri poiché aveva scorto
in lui qualità di recitazione conformi al metodo per
il quale egli si era battuto vittoriosamente.
Occorre ricordare che Gustavo Modena aveva in
trodotto nella recitazione un suo nuovo metodo che
fu per il teatro italiano una vera rivoluzione; egli
aveva eliminato la vecchia tradizionale recitazione en
fatica, declamatoria, convenzionale c manierata, ridu-
ccndola a semplicità, a naturalezza, su una base rea
listica che valse a trasformare gli attori da mestieranti
in autentici artisti. Ai suoi inizi il nuovo metodo aveva
sconcertato e disorientato il teatro, ma presto egli
aveva ottenuto dalla critica c dal pubblico l’unanime
consenso. La nuova scuola di recitazione creata da
GusUvo Modena divenne classica cd è tuttora sostan
zialmente viva ai nostri giorni.
Il
Tosclli accettò l'offerta. Trovandosi a contatto
con il grandissimo Maestro ebbe agio di approfittare
del suo insegnamento e dei suoi consigli per perfezio
narsi. Tuttavia il Tosclli sentiva di poter fare di più;
il campo troppo ristretto della farsa non gli permetteva
un maggiore svolgimento delle sue attitudini. Se ne
accorse lo stesso Modena c gli suggerì di formarsi una
propria compagnia per reciurc esclusivamente in pie
montese. Giovanni Tosclli accolse con entusiasmo il
consiglio di Gusuvo Modena e si diede d’attomo a
radunare intorno a sè un complesso di attori giovani
e promettenti. Compiuto questo primo passo, doveva
superare l’osucolo più arduo: il repertorio. Dove e
come trovare un repertorio in vernacolo ? Il teatro dia
lettale piemontese, come abbiamo già accennato, non
aveva tradizioni, nè si poteva fare affidamento sulla
produzione del passato. Urgeva risolvere. La buona
fortuna aveva bussato all’uscio, occorreva spalancarle
subito la porta perchè entrasse; al minimo indugio
poteva sfuggire. La buona fortuna quando capiu elar
gisce in abbondanza le sue grazie. E avvenne infatti
che il Meynadier, capocomico e gerente di vari teatri
torinesi, offri al Toselli uno dei più importanti teatri
della capitale subalpina, il D ’Angennes (quello che più
tardi dai marionettisti fratelli Lupi ebbe il nome di
Gianduja) che per un improvviso contrasto di scrit
tura si era reso disponibile... Ma il repertorio» Ecco
lo scoglio durissimo. Come inaugurare un corso di
recite in vernacolo senza l’esistenza di un repertorio »
Ed era anche indispensabile che il primo lavoro da
mettere in scena desse almeno un
minimum
di affida
mento di successo. Bisognava far presto.
Non si pene d’animo il Tosclli. A quel tempo
trionfava sulle scene la
Francesca da Rimini
del Pellico
e per merito particolare di certi versi nei quali si scor
gevano allusioni patriottiche destava il delirio delle
platee (si era nel
1859
!). Sorse nel Tosclli l’idea di
trasformare quella tragedia, di portarla in ambiente
agreste pur rispettandone il soggetto. A quello scopo
si rivolse ad Angelo Broffcrio e ne ricevette un deciso
rifiuto; si accostò a Tommaso Villa che era allora
praticante nell’ufficio dello stesso Brofferio. Il Villa
dapprima fu esitante per il timore di uscirne con una
parodia o birbonata o qualcosa di grottesco, ma infine
se ne assunse l’impegno.
Una sera della primavera del
1859
si apersero i
battenti del Teatro D’Angennes; il cartellone annun
ciava la prima recita della compagnia dialettale pie
montese diretta da Giovanni Toselli con il dramma
Cichina ’d Montale.
Ricca la messa in scena e i co
stumi, impeccabile la recitazione. L’ansia dell’attesa
fu ripagau largamente da una insperata vittoria. I
giornali dell’epoca riferiscono che il pubblico era stato
sorpreso da una commozione profonda c ne aveva de
cretato il successo. Protagonisti: il Toselli, che in
quella occasione si rivelò valentissimo attore e diret
tore impareggiabile, Adelaide Tessero, Giuseppe Sa-
lussoglia c Giovanni Bucciotti! La
Cichina
ebbe trenu
repliche consecutive con incassi favolosi. Per il secondo
lavoro si ricorse alla versione della
Signora dalle ca
melie
di A. Dumas figlio col titolo di
Margritin die
violette,
ed il successo fu pari al precedente. Finalmente
con la terza produzione
Giura
0
Pas
di Federico Ga
relli il teatro piemontese si avviò sulla via più conve
niente e più coerente al suo fine.
La vittoriosa iniziativa del Tosclli fu di incitamento
a molti autori i quali si accinsero a scrivere per il nuovo
teatro in vernacolo, c ne citiamo i maggiori: Fede
rico Garelli, Luigi Pietracqua, i fratelli Carrcra, Gio
vanni Zoppis, Desiderato Chiavcs, ... Il Tosclli in
breve s’ebbe fra le mani ben trenuquattro commedie
nuove fra le quali alcune famose:
Gigin a baia nen,
Rispeta tòa fómna, Un pover paroco. La cabana del Re
Galantom
e finalmente il capolavoro:
Le miserie 'd
Mòttsù Travet
di Carlo Nugelli, pseudonimo di Vit
torio Bcrsezio. È curioso il fatto che il Bersezio in
un primo tempo si era dichiarato decisamente avverso
alla creazione di un teatro dialettale piemontese. Egli
infatti scriveva sulla
Gazzetta Ufficiale
del
5
set
tembre
1 8 5 9
:
Si vuole, oh sciagurato anacronismo, impiantare un
teatro piemontese, con repertorio piemontese, con attori pie
montesi, con facezie piemontesi (oh misericordia) con pie
montese fastidio. Mentre non ci è mai stata necessità co
tanta che cifacessimo in tutto e per tutto italiani.
Ma non tardò molto il Bersezio a convertirsi e
fare onorevole ammenda di quanto aveva scritto;
anche lui si mise a scrivere commedie in vernacolo, e
Le miserie 'd Mónsù Travet
sono la sesu commedia da
lui composu ! Fu al Teatro Alfieri di Torino che la
compagnia di Giovanni Toselli la sera del
4
aprile
1863
26


















