
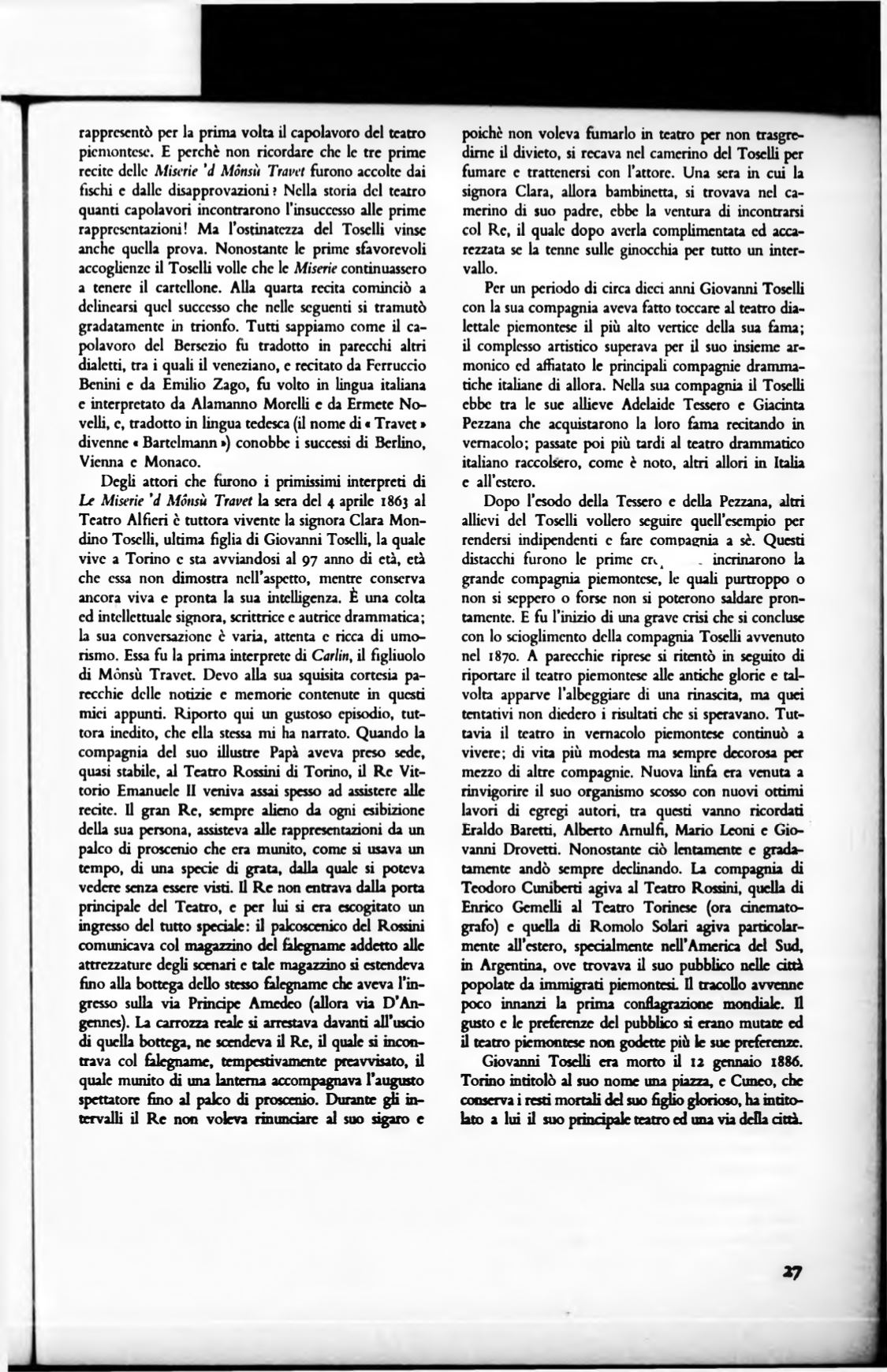
rappresentò per la prima volta il capolavoro del teatro
piemontese. E perchè non ricordare che le tre prime
recite delle
Miserie ’d MSnsù Travet
furono accolte dai
fischi e dalle disapprovazioni? Nella storia del teatro
quanti capolavori incontrarono l’insuccesso alle prime
rappresentazioni! Ma l'ostinatezza del Tosclli vinse
anche quella prova. Nonostante le prime sfavorevoli
accoglienze il Tosclli volle che le
Miserie
continuassero
a tenere il cartellone. Alla quarta recita cominciò a
delinearsi quel successo che nelle seguenti si tramutò
gradatamente in trionfo. Tutti sappiamo come il ca
polavoro del Bersezio fu tradotto in parecchi altri
dialetti, tra i quali il veneziano, c recitato da Ferruccio
Bcnini e da Emilio Zago, fu volto in lingua italiana
e interpretato da Alamanno Morelli e da Ermete No
velli, c, tradotto in lingua tedesca (il nome di « Travet *
divenne « Bartelmann *) conobbe i successi di Berlino,
Vienna e Monaco.
Degli attori che furono i primissimi interpreti di
Le Miserie 'd Mónsù Travet
la sera del
4
aprile
1863
al
Teatro Alfieri è tuttora vivente la signora Clara Mon
dino Tosclli, ultima figlia di Giovanni Tosclli, la quale
vive a Torino e sta avviandosi al
97
anno di età, età
che essa non dimostra nell’aspetto, mentre conserva
ancora viva e pronta la sua intelligenza. È una colta
ed intellettuale signora, scrittrice e autrice drammatica;
la sua conversazione è varia, attenta c ricca di umo
rismo. Essa fu la prima interprete di
Carliti,
il figliuolo
di Mònsù Travet. Devo alla sua squisita cortesia pa
recchie delle notizie e memorie contenute in questi
mici appunti. Riporto qui un gustoso episodio, tut
tora inedito, che ella stessa mi ha narrato. Quando la
compagnia del suo illustre Papà aveva preso sede,
quasi stabile, al Teatro Rossini di Torino, il Re Vit
torio Emanuele li veniva assai spesso ad assistere alle
recite. Il gran Re, sempre alieno da ogni esibizione
della sua persona, assisteva alle rappresentazioni da un
palco di proscenio che era munito, come si usava un
tempo, di una specie di grata, dalla quale si poteva
vedere senza essere visti. Il Re non entrava dalla porta
principale del Teatro, e per lui si era escogitato un
ingresso del tutto speciale: il palcoscenico del Rossini
comunicava col magazzino del falegname addetto alle
attrezzature degli scenari e tale magazzino si estendeva
fino alla bottega dello stesso falegname che aveva l’in
gresso sulla via Principe Amedeo (allora via D ’An
gennes). La carrozza reale si arrestava davanti all’uscio
di quella bottega, ne scendeva il Re, il quale si incon
trava col falegname, tempestivamente preavvisato, il
quale munito di una lanterna accompagnava l’augusto
spettatore fino al palco di proscenio. Durante gli in
tervalli il Re non voleva rinunciare al suo sigaro e
poiché non voleva fumarlo in teatro per non trasgre
dirne il divieto, si recava nel camerino del Toselli per
fumare c trattenersi con l’attore. Una sera in cui la
signora Clara, allora bambinetta, si trovava nel ca
merino di suo padre, ebbe la ventura di incontrarsi
col Re, il quale dopo averla complimentata cd acca
rezzata se la tenne sulle ginocchia per tutto un inter
vallo.
Per un periodo di circa dicci anni Giovanni Toselli
con la sua compagnia aveva fatto toccare al teatro dia
lettale piemontese il più alto vertice della sua fama;
il complesso artistico superava per il suo insieme ar
monico cd affiatato le principali compagnie dramma
tiche italiane di allora. Nella sua compagnia il Toselli
ebbe tra le sue allieve Adelaide Tessero e Giacinta
Pezzana che acquistarono la loro fama recitando in
vernacolo; passate poi più tardi al teatro drammatico
italiano raccolsero, come è noto, altri allori in Italia
e all’estero.
Dopo l’esodo della Tessero e della Pezzana, altri
allievi del Toselli vollero seguire quell’esempio per
rendersi indipendenti c fare compagnia a sè. Questi
disucchi furono le prime cr^
. incrinarono la
grande compagnia piemontese, le quali purtroppo o
non si seppero o forse non si poterono saldare pron-
umcnte. E fu l’inizio di una grave crisi che si concluse
con lo scioglimento della compagnia Toselli avvenuto
nel
1870
. A parecchie riprese si ritentò in seguito di
riportare il teatro piemontese alle antiche glorie e tal
volta apparve l’albeggiare di una rinasciu, ma quei
tenutivi non diedero i risultati che si speravano. Tut-
uvia il teatro in vernacolo piemontese continuò a
vivere; di viu più modesu ma sempre decorosa per
mezzo di altre compagnie. Nuova linfa era venuu a
rinvigorire il suo organismo scosso con nuovi ottimi
lavori di egregi autori, tra questi vanno ricordati
Eraldo Baretti, Alberto Amulfì, Mario Leoni e Gio
vanni Drovetti. Nonostante ciò lentamente e grada
tamente andò sempre declinando. La compagnia di
Teodoro CUmberti agiva al Teatro Rossini, quella di
Enrico Gemelli al Teatro Torinese (ora cinemato
grafo) e quella di Romolo Solari agiva particolar
mente all’estero, specialmente nell’America del Sud,
in Argentina, ove trovava il suo pubblico nelle città
popolate da immigrati piemontesi II tracollo avvenne
poco innanzi la prima conflagrazione mondiale. U
gusto e le preferenze del pubblico si erano muute ed
il teatro piemontese non godette più le sue preferenze.
Giovanni Toselli era morto il
12
gennaio
1886
.
Torino intitolò al suo nome una piazza, e Cuneo, che
conserva i resti mortali del suo figlio glorioso, ha intito
lato a lui il suo principale teatro ed una via della città.
27


















