
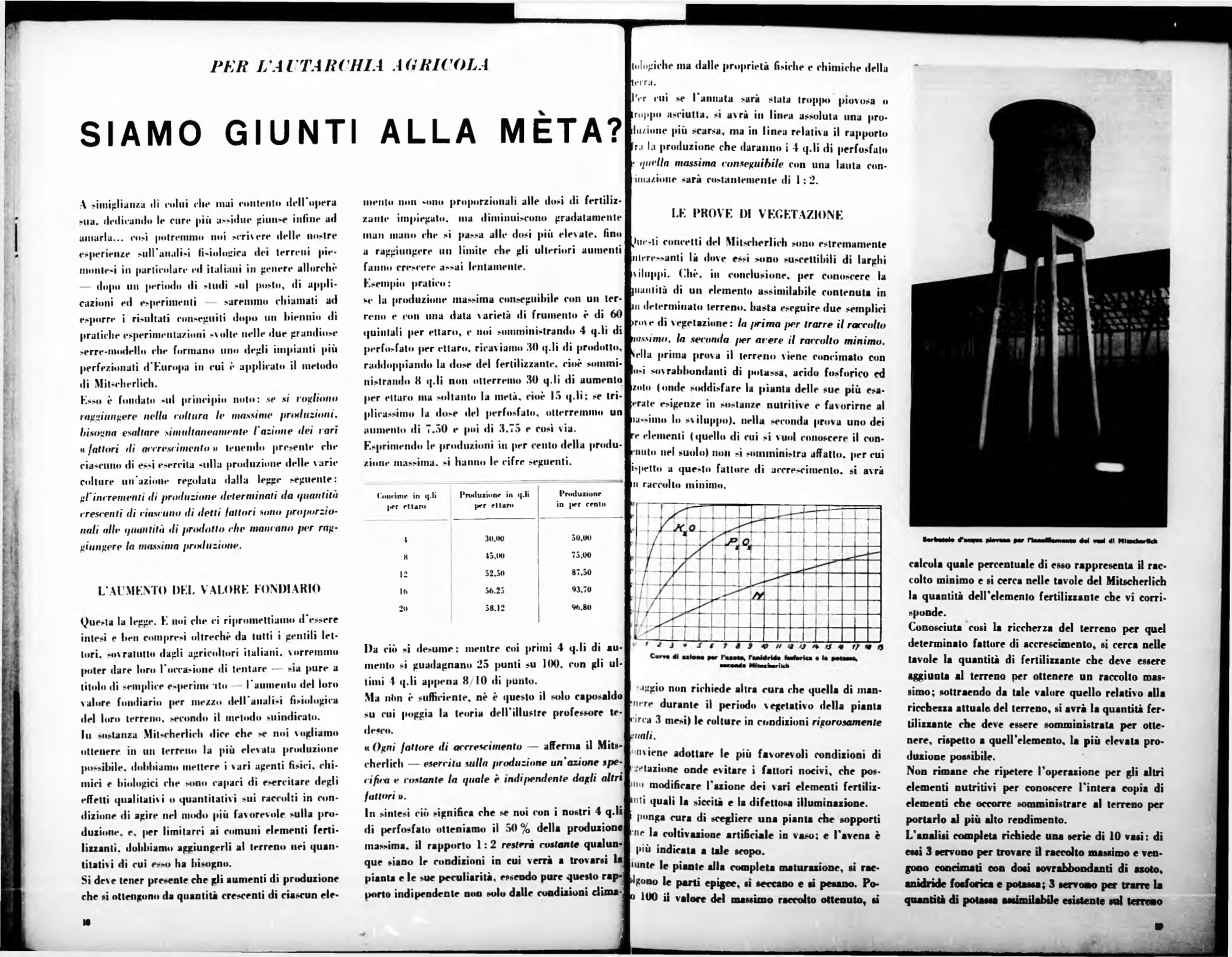
P E R L AUTARCH IA AURICOLA
S I AMO G I UNT I A L L A M È T A ?
A siinigliunza «li colui die mai contento dell'opera
sua. dedicando le cure più assidue giunse infine ad
amarla... così potremmo noi seri\ere delle nostre
esperienze sull’analisi fisiologica dei terreni pie
montesi in particolare ed italiani in genere allorché
— dopo un periodo di studi sul posto, di appli
cazioni ed esperimenti — saremmo chiamati ad
esporre i risultati conseguiti dopo un biennio di
pratiche esperimentazioui svolte nelle due grandiose
serre-modello che formano uno degli impianti più
perfezionati d'Europa in cui è applicato il metodo
di Mitscherlich.
Ksso è fondato
sul
principio noto: .se si caulinno
raggiungere nella coltura le massime produzioni,
bisogna esaltare simultaneamente l'azione (lei cari
« fattori ili accrescimento » tenendo presente che
ciascuno di es'i esercita sulla produzione delle varie
colture un’azione regolata dalla legge seguente:
pi'incrementi di produzione determinati da quantità
crescenti di ciascuno di detti fattori sono pro/torzio-
nali alle quantità di prodotto che mancano per rag-
giungere la massima produzione.
L'A UM EN TO D E L V A L O R E FO N D IA R IO
Questa la legge. E noi che ci ripromettiamo d'essere
intesi e hen compresi oltreché da tutti i gentili let
tori, sovratutto dagli agricoltori italiani, vorremmo
poter «lare loro l'occasione di tentare — sia pure a
titolo di semplice esperitili 'ito — l'aumento del loro
\alore fondiario per mezzo dell ‘aliai i«i fisiologica
del loro terreno, secondo il metodo suindicato,
lu sostanza Mitscherlich dice che se noi \ogliamo
ottenere in un terreno la più ele\ata produzione
possibile, dobbiamo mettere i vari agenti fìsici, chi
mici e biologici che sono capaci di esercitare degli
effetti qualitativi o quantitativi sui raccolti in con
dizione di agire nel modo più favorev«de sulla pro
duzione. e. per limitarci ai comuni elementi ferti
lizzanti. dubbiarmi aggiungerli al terreno nei quan
titativi di cui esso ha bisogno.
Si deve tener presente che gli aumenti di produzione
che si ottengono da quantità crescenti di ciascun eie*
»
melilo non sono proporzionali alle dosi di fertiliz
zatile impiegato, ma diminuiscono gradatamente
man mano che si passa alle dosi più elevate, fino
a raggiungere un limite che gli ulteriori aumenti
fanno crescere assai lentamente.
Esempio pratico:
se la produzione massima conseguibile con un ter
reno e con una data varietà di frumento é di 60
quintali per ettaro, e noi somministrando 4
q.lidi
perfosfato per ettaro, ricaviamo .
HOq.lidi prodotto,
raddoppiando la dose del fertilizzante, cioè sommi
nistrando 8
q.linon otterremo 30
q.lidi aumento
per ettaro ma soltanto la metà, cioè 15
q.li; se tri
plicassimo la dose «lei perfosfato, otterremmo un
aumento di 7.50 e poi di 3,75 e così via.
Esprimendo le produzioni iu per cento della produ
zione
massima,
si hanno le cifre seguenti.
Gm tim r in
q.liprr rttaro
l’nxiuzionr in
q.liprr filar»
t’roduzionr
in |»rr crnlo
l
30.00
50,00
H
45.00
75.00
12
52.50
87.50
16
56.25
93,70
20
58.12
96.80
Da ciò
si
desume: mentre coi primi 4
q.lidi au
mento
si
guadagnano 25 punti su 100. con gli ul
timi 4
q.liappena 8/10 di punto.
Ma
ntm
è sufficiente, nè è questo il solo caposaldo
su cui poggia la teoria dell'illustre professore te*
desco.
« Ogni fattore di accrescimento
— afferma il Mits
cherlich —
esercita sulla produzione un'azione spe
cifica e costante la quale è indifwndente dagli altri
fattori ».
In sintesi ciò significa che se noi con i nostri 4
q.lidi perfosfato otteniamo il 50 % della produzione
massima, il rapporto 1:2
resterà costante
qualun
que siano le condizioni in cui verrà a trovarsi la
(illogiche ma dalle proprie(à fisiche e chimiche della
terra.
Ter cui se l'anna(a sarà stata trop|M> piovosa o
troppo asciutta, si avrà in linea assoluta una prò*
ilti/.ione più scarsa, ma in linea relativa il rapporto
Ira la produzione che daranno i 4
q.lidi perfosfato
? quella massima conseguibile con una lauta con
ima/ione sarà costantemente di 1: 2.
L E P R O V E DI V E G E T A Z IO N E
Questi concetti del Mitscherlich sono estremamente
nteressanti là dove essi sono suscettibili di larghi
viluppi. Ghè. in conclusione, per conoscere la
piantila di un elemento assimilabile contenuta in
in determinato terreno, basta eseguire due semplici
irove di vegetazione: la {tritila /ter trarre il raccolto
inissimo, la seconda /ter avere il raccolto minimo.
Sella prima prova il terreno viene concimato con
lusi
sovrabbondanti di potassa, acido fosforico ed
iziito (onde soddisfare la pianta delle sue più esa*
erale esigenze in sostanze nutritive e favorirne al
nassiino
lo sviluppo), nella seconda prova uno dei
re elementi (quello di cui si vuol conoscere il con
fluito nel suolo) non si somministra affatto, per cui
ispetto a questo fattore di accrescimento, si avrà
in raccolto minimo.
_______ «—
-----»- - »■
Mcorrao n in c n trin n
aggio non richiede altra cura che quella di man-
‘nere
durante il periodo vegetativo della pianta
circa 3
mesi) le colture in condizioni
rigorosamente
anali.
"in
iene adottare le più favorevoli condizioni di
gelazione onde evitare i fattori nocivi, che pos
ino modificare l'azione dei vari elementi fertiliz-
ititi
quali la siccità e la difettosa illuminazione,
i ponga cura di scegliere una pianta che sopporti
tue
la coltivazione artificiale in vaso; e l'avena
è
più indicata a tale scopo.
Sarfcatala faceta pJovaaa par riaaaWamanta
M
vati di Miodtarllch
calcola quale percentuale di esso rappresenta il rac
colto minimo e si cerca nelle tavole del Mitscherlich
la quantità dell'elemento fertilizzante che vi corri
sponde.
Conosciuta così la ricchezza del terreno per quel
determinato fattore di accrescimento, si cerca nelle
tavole la quantità di fertilizzante che deve essere
aggiunta al terreno per ottenere un raccolto mas
simo; sottraendo da tale valore quello relativo alla
ricchezza attuale del terreno, si avrà la quantità fer
tilizzante che deve essere somministrata per otte
nere, rispetto a quell'elemento, la più elevata pro
duzione possibile.
Non rimane che ripetere l'operazione per gli altri
elementi nutritivi per conoscere l'intera copia di
elementi che occorre somministrare al terreno per
portarlo al più alto rendimento.
L'analisi completa richiede una serie di 10 vasi : di
essi 3 servono per trovare il raccolto massimo e ven
gono concimati con dosi sovrabbondanti di azoto,
anidride fosforica e potassa; 3 servono per tram la
quantità di potassa assimilabile esistente sol terreao
I»
,
. ,
,
J n,f piante alla completa maturazione, si rac-
pianta e le sue peculiarità, essendo pure questo rap-li....^ .
. .
_
. . .
,
i » ii
j
* • • i* W ^ ono *e P«rti epigee, si seccano e si pesano. Po*
porto indipendente n«»n «olo dalle condizioni clima*!.. i.w .. ,
, ,
.
,
1 ° IUU « valore del massimo raccolto ottenuto, si


















