
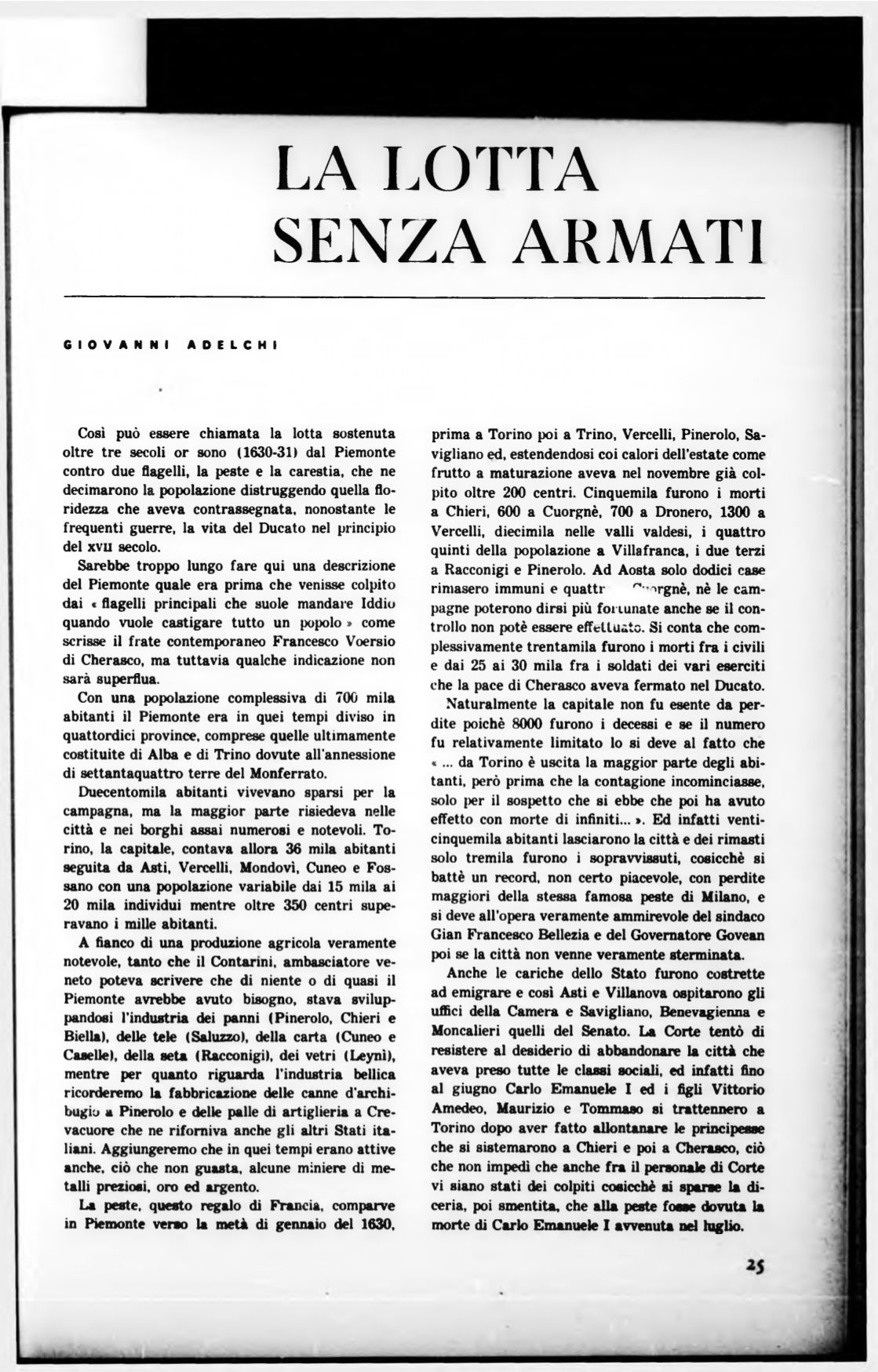
L A L O T T A
S E N Z A A R M A T I
G I O V A N N I A D E L C H I
Così può essere chiamata la lotta sostenuta
oltre tre secoli or sono (1630-31) dal Piemonte
contro due flagelli, la peste e la carestia, che ne
decimarono la popolazione distruggendo quella flo
ridezza che aveva contrassegnata, nonostante le
frequenti guerre, la vita del Ducato nel principio
del xvu secolo.
Sarebbe troppo lungo fare qui una descrizione
del Piemonte quale era prima che venisse colpito
dai « flagelli principali che suole mandare Iddio
quando vuole castigare tutto un popolo » come
scrisse il frate contemporaneo Francesco Voersio
di Cherasco, ma tuttavia qualche indicazione non
sarà superflua.
Con una popolazione complessiva di 700 mila
abitanti il Piemonte era in quei tempi diviso in
quattordici province, comprese quelle ultimamente
costituite di Alba e di Trino dovute all'annessione
di settantaquattro terre del Monferrato.
Duecentomila abitanti vivevano sparsi per la
campagna, ma la maggior parte risiedeva nelle
città e nei borghi assai numerosi e notevoli. To
rino, la capitale, contava allora 36 mila abitanti
seguita da Asti, Vercelli, Mondovi, Cuneo e Fos-
sano con una popolazione variabile dai 15 mila ai
20 mila individui mentre oltre 350 centri supe
ravano i mille abitanti.
A fianco di una produzione agricola veramente
notevole, tanto che il Contarmi, ambasciatore ve
neto poteva scrivere che di niente o di quasi il
Piemonte avrebbe avuto bisogno, stava svilup
pandosi l’industria dei panni (Pinerolo, Chieri e
Biella), delle tele (Saluzzo), della carta (Cuneo e
Caselle), della seta (Racconigi), dei vetri (Leynì),
mentre per quanto riguarda l’industria bellica
ricorderemo la fabbricazione delle canne d'archi
bugio a Pinerolo e delle palle di artiglieria a Cre-
vacuore che ne riforniva anche gli altri Stati ita
liani. Aggiungeremo che in quei tempi erano attive
anche, ciò che non guasta, alcune miniere di me
talli preziosi, oro ed argento.
La peste, questo regalo di Francia, comparve
in Piemonte verso la metà di gennaio del 1630,
prima a Torino poi a Trino, Vercelli, Pinerolo, Sa-
vigliano ed, estendendosi coi calori dell’estate come
frutto a maturazione aveva nel novembre già col
pito oltre 200 centri. Cinquemila furono i morti
a Chieri, 600 a Cuorgnè, 700 a Dronero, 1300 a
Vercelli, diecimila nelle valli valdesi, i quattro
quinti della popolazione a Villa franca, i due terzi
a Racconigi e Pinerolo. Ad Aosta solo dodici case
rimasero immuni e quattr
r,-->rgnè, nè le cam
pagne poterono dirsi più fortunate anche se il con
trollo non potè essere effettuate. Si conta che com
plessivamente trentamila furono i morti fra i civili
e dai 25 ai 30 mila fra i soldati dei vari eserciti
che la pace di Cherasco aveva fermato nel Ducato.
Naturalmente la capitale non fu esente da per
dite poiché 8000 furono i decessi e se il numero
fu relativamente limitato lo si deve al fatto che
«... da Torino è uscita la maggior parte degli abi
tanti, però prima che la contagione incominciasse,
solo {>er il sospetto che si ebbe che poi ha avuto
effetto con morte di infiniti... ». Ed infatti venti-
cinquemila abitanti lasciarono la città e dei rimasti
solo tremila furono i sopravvissuti, cosicché si
battè un record, non certo piacevole, con perdite
maggiori della stessa famosa peste di Milano, e
si deve all’opera veramente ammirevole del sindaco
Gian Francesco Bellezia e del Governatore Govean
poi se la città non venne veramente sterminata.
Anche le cariche dello Stato furono costrette
ad emigrare e così Asti e Villanova ospitarono gli
uffici della Camera e Savigliano, Benevagienna e
Moncalieri quelli del Senato. La Corte tentò dì
resistere al desiderio di abbandonare la città che
aveva preso tutte le classi sociali, ed infatti fino
al giugno Carlo Emanuele I ed i figli Vittorio
Amedeo, Maurizio e Tommaso si trattennero a
Torino dopo aver fatto allontanare le principesse
che si sistemarono a Chieri e poi a Cherasco, ciò
che non impedì che anche fra il personale di Corte
vi siano stati dei colpiti cosicché si sparse la di
ceria, poi smentita, che alla peste fosse dovuta la
morte di Carlo Emanuele I avvenuta nel luglio.


















