
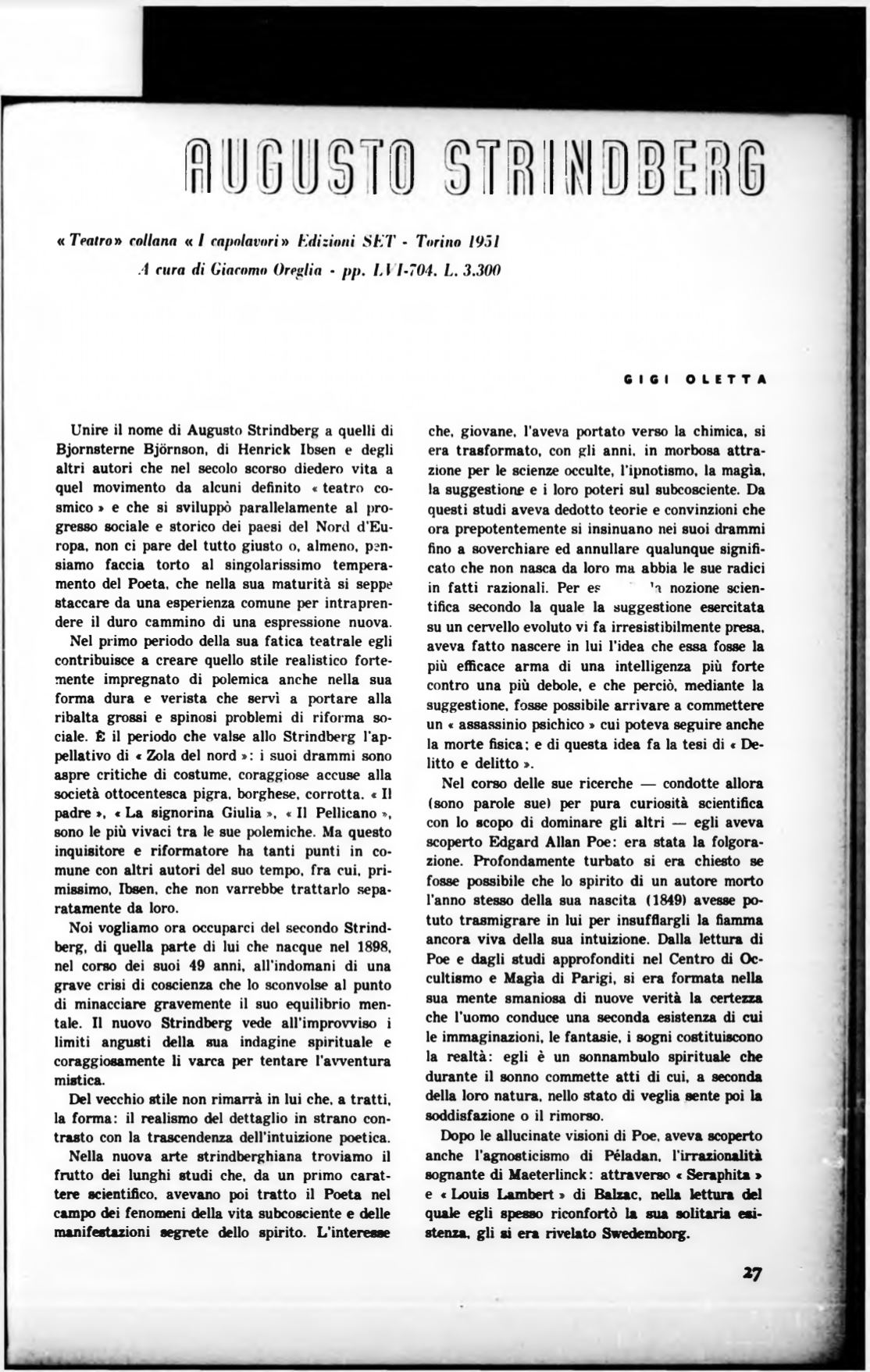
«
Teatro
»
collana
« /
capolavori» Edizioni SE T
-
Torino 1951
A cura di Giacomo Oreglia
- />/>.
L
I
1-704. L. 3.300
G I G I O L E T T A
Unire il nome di Augusto Strindberg a quelli di
Bjornsterne Bjòrnson, di Henrick Ibsen e degli
altri autori che nel secolo scorso diedero vita a
quel movimento da alcuni definito « teatro co
smico » e che si sviluppò parallelamente al pro
gresso sociale e storico dei paesi del Nord d'Eu
ropa, non ci pare del tutto giusto o, almeno, pen
siamo faccia torto al singolarissimo tempera
mento del Poeta, che nella sua maturità si seppe
staccare da una esperienza comune per intrapren
dere il duro cammino di una espressione nuova.
Nel primo periodo della sua fatica teatrale egli
contribuisce a creare quello stile realistico forte
mente impregnato di polemica anche nella sua
forma dura e verista che servì a portare alla
ribalta grossi e spinosi problemi di riforma so
ciale. È il periodo che valse allo Strindberg l’ap
pellativo di « Zola del nord » : i suoi drammi sono
aspre critiche di costume, coraggiose accuse alla
società ottocentesca pigra, borghese, corrotta. « Il
padre », « La signorina Giulia », « Il Pellicano »,
sono le più vivaci tra le sue polemiche. Ma questo
inquisitore e riformatore ha tanti punti in co
mune con altri autori del suo tempo, fra cui, pri
missimo, Ibsen, che non varrebbe trattarlo sepa
ratamente da loro.
Noi vogliamo ora occuparci del secondo Strind
berg, di quella parte di lui che nacque nel 1898,
nel corso dei suoi 49 anni, all'indomani di una
grave crisi di coscienza che lo sconvolse al punto
di minacciare gravemente il suo equilibrio men
tale. Il nuovo Strindberg vede all’improwiso i
limiti angusti della sua indagine spirituale e
coraggiosamente li varca per tentare l'avventura
mistica.
Del vecchio stile non rimarrà in lui che. a tratti,
la forma: il realismo del dettaglio in strano con
trasto con la trascendenza dell’intuizione poetica.
Nella nuova arte strindberghiana troviamo il
frutto dei lunghi studi che, da un primo carat
tere scientifico, avevano poi tratto il Poeta nel
campo dei fenomeni della vita subcosciente e delle
manifestazioni segrete dello spirito. L ’interesse
che, giovane, l’aveva portato verso la chimica, si
era trasformato, con gli anni, in morbosa attra
zione per le scienze occulte, l’ipnotismo, la magìa,
la suggestione e i loro poteri sul subcosciente. Da
questi studi aveva dedotto teorie e convinzioni che
ora prepotentemente si insinuano nei suoi drammi
fino a soverchiare ed annullare qualunque signifi
cato che non nasca da loro ma abbia le sue radici
in fatti razionali. Per e?
’i nozione scien
tifica secondo la quale la suggestione esercitata
su un cervello evoluto vi fa irresistibilmente presa,
aveva fatto nascere in lui l’idea che essa fosse la
più efficace arma di una intelligenza più forte
contro una più debole, e che perciò, mediante la
suggestione, fosse possibile arrivare a commettere
un « assassinio psichico » cui poteva seguire anche
la morte fìsica: e di questa idea fa la tesi di « De
litto e delitto ».
Nel corso delle sue ricerche — condotte allora
(sono parole sue) per pura curiosità scientifica
con lo scopo di dominare gli altri — egli aveva
scoperto Edgard Allan Poe: era stata la folgora
zione. Profondamente turbato si era chiesto se
fosse possibile che lo spirito di un autore morto
l’anno stesso della sua nascita (1849) avesse po
tuto trasmigrare in lui per insufflargli la fiamma
ancora viva della sua intuizione. Dalla lettura di
Poe e dagli studi approfonditi nel Centro di Oc
cultismo e Magìa di Parigi, si era formata nella
sua mente smaniosa di nuove verità la certezza
che l’uomo conduce una seconda esistenza di cui
le immaginazioni, le fantasie, i sogni costituiscono
la realtà: egli è un sonnambulo spirituale che
durante il sonno commette atti di cui, a seconda
della loro natura, nello stato di veglia sente poi la
soddisfazione o il rimorso.
Dopo le allucinate visioni di Poe. aveva scoperto
anche l’agnosticismo di Péladan, l'irrazionalità
sognante di Maeterlinck : attraverso <Seraphita »
e « Louis Lambert » di Balzac, nella lettura del
quale egli spesso riconfortò la sua solitaria esi
stenza, gli si era rivelato Swedemborg.
27


















