
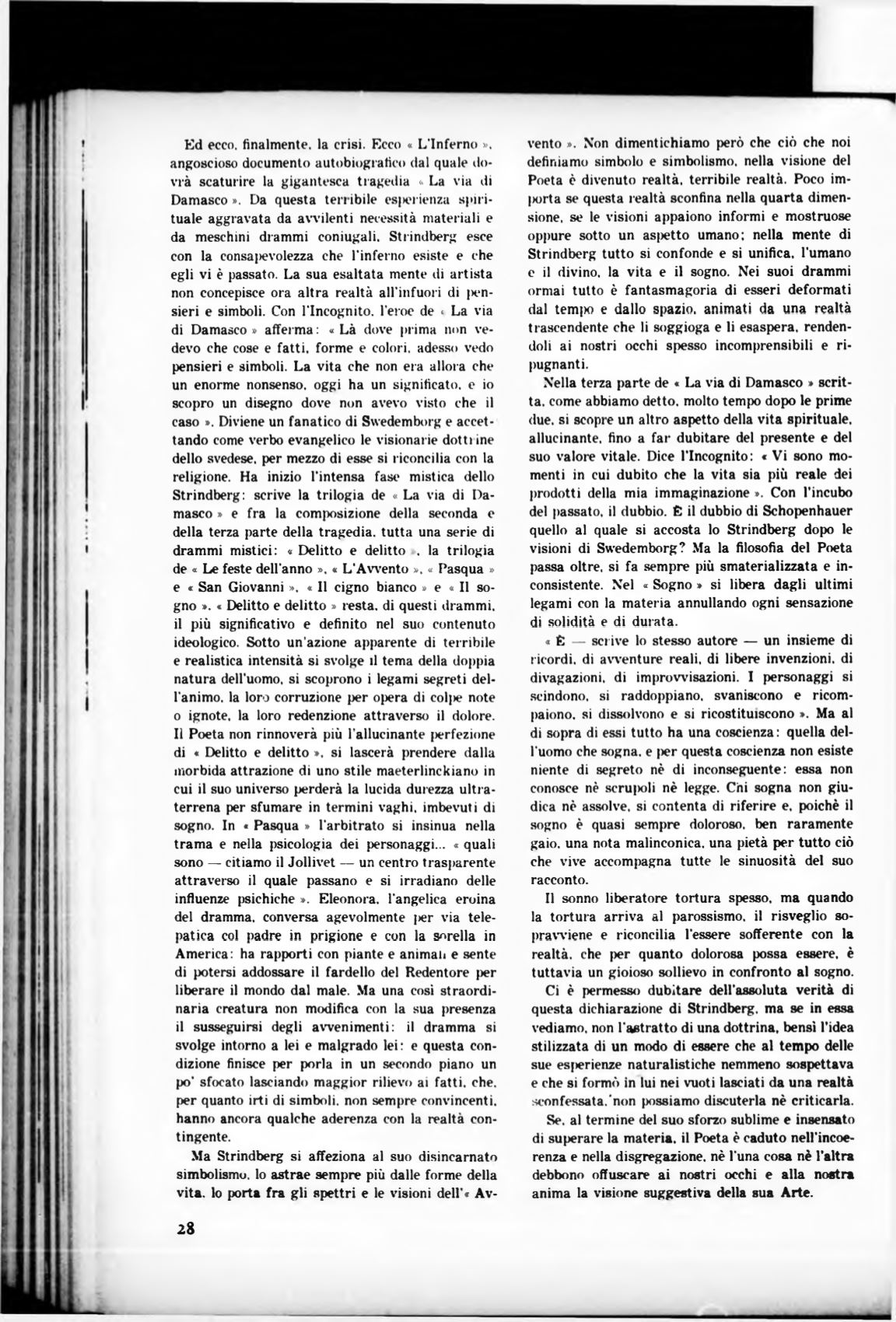
Ed ecco, finalmente, la crisi. Ecco « L'Inferno »,
angoscioso documento autobiografico dal quale do
vrà scaturire la gigantesca tragedia « La via di
Damasco ». Da questa ten ibile esjterienza spiri
tuale aggravata da avvilenti necessità materiali e
da meschini drammi coniugali. Strindberg esce
con la consaj)evolezza che l’inferno esiste e che
egli vi è passato. La sua esaltata mente di artista
non concepisce ora altra realtà all’infuori di |>en-
sieri e simboli. Con l'incognito, l’eroe de <La via
di Damasco» afferma: «Là dove prima non ve
devo che cose e fatti, forme e colori, adesso vedo
pensieri e simboli. La vita che non era allora che
un enorme nonsenso, oggi ha un significato, e io
scopro un disegno dove non avevo visto che il
caso ». Diviene un fanatico di Swedemborg e accet
tando come verbo evangelico le visionarie dotti ine
dello svedese, per mezzo di esse si riconcilia con la
religione. Ha inizio l’intensa fase mistica dello
Strindberg: scrive la trilogia de « La via di Da
masco » e fra la composizione della seconda e
della terza parte della tragedia, tutta una serie di
drammi mistici: « Delitto e delitto , la trilogia
de « Le feste dell'anno ». « L ’Avvento », « Pasqua »
e « San Giovanni », « Il cigno bianco » e « Il so
gno ». « Delitto e delitto » resta, di questi drammi,
il più significativo e definito nel suo contenuto
ideologico. Sotto un'azione apparente di terribile
e realistica intensità si svolge il tema della doppia
natura dell’uomo, si scoprono i legami segreti del
l’animo, la loro corruzione per opera di colj>e note
o ignote, la loro redenzione attraverso il dolore.
Il Poeta non rinnoverà più l'allucinante perfezione
di « Delitto e delitto ». si lascerà prendere dalla
morbida attrazione di uno stile maeterlinckiano in
cui il suo universo perderà la lucida durezza ultra-
terrena per sfumare in termini vaghi, imbevuti di
sogno. In « Pasqua » l'arbitrato si insinua nella
trama e nella psicologia dei personaggi... « quali
sono — citiamo il Jollivet — un centro trasparente
attraverso il quale passano e si irradiano delle
influenze psichiche ». Eleonora, l'angelica eroina
del dramma, conversa agevolmente }>er via tele
patica col padre in prigione e con la sorella in
America: ha rapporti con piante e animali e sente
di potersi addossare il fardello del Redentore per
liberare il mondo dal male. Ma una cosi straordi
naria creatura non modifica con la sua presenza
il susseguirsi degli avvenimenti: il dramma si
svolge intorno a lei e malgrado lei: e questa con
dizione finisce per porla in un secondo piano un
po’ sfocato lasciando maggior rilievo ai fatti, che.
per quanto irti di simboli, non sempre convincenti,
hanno ancora qualche aderenza con la realtà con
tingente.
Ma Strindberg si affeziona al suo disincarnato
simbolismo, lo astrae sempre più dalle forme della
vita, lo porta fra gli spettri e le visioni dell'» Av
vento ». Non dimentichiamo però che ciò che noi
definiamo simbolo e simbolismo, nella visione del
Poeta è divenuto realtà, terribile realtà. Poco im-
|x>rta se questa realtà sconfina nella quarta dimen
sione. se le visioni appaiono informi e mostruose
oppure sotto un as|>etto umano; nella mente di
Strindberg tutto si confonde e si unifica, l’umano
e il divino, la vita e il sogno. Nei suoi drammi
ormai tutto è fantasmagoria di esseri deformati
dal temjK) e dallo spazio, animati da una realtà
trascendente che li soggioga e li esaspera, renden
doli ai nostri occhi spesso incomprensibili e ri
pugnanti.
Nella terza parte de « La via di Damasco » scrit
ta. come abbiamo detto, molto tempo dopo le prime
due. si scopre un altro aspetto della vita spirituale,
allucinante, fino a far dubitare del presente e del
suo valore vitale. Dice l’incognito: « Vi sono mo
menti in cui dubito che la vita sia più reale dei
prodotti della mia immaginazione ». Con l’incubo
del passato, il dubbio. È il dubbio di Schopenhauer
quello al quale si accosta lo Strindberg dopo le
visioni di Swedemborg? Ma la filosofia del Poeta
passa oltre, si fa sempre più smaterializzata e in
consistente. Nel « Sogno » si libera dagli ultimi
legami con la materia annullando ogni sensazione
di solidità e di durata.
« È — scrive lo stesso autore — un insieme di
ricordi, di avventure reali, di libere invenzioni, di
divagazioni, di improvvisazioni. I personaggi si
scindono, si raddoppiano, svaniscono e ricom
paiono. si dissolvono e si ricostituiscono ». Ma al
di sopra di essi tutto ha una coscienza: quella del
l'uomo che sogna, e per questa coscienza non esiste
niente di segreto nè di inconseguente: essa non
conosce nè scrujwli nè legge. Chi sogna non giu
dica nè assolve, si contenta di riferire e, poiché il
sogno è quasi sempre doloroso, ben raramente
gaio, una nota malinconica, una pietà per tutto ciò
che vive accompagna tutte le sinuosità del suo
racconto.
Il sonno liberatore tortura spesso, ma quando
la tortura arriva al parossismo, il risveglio so
pravviene e riconcilia l’essere sofferente con la
realtà, che per quanto dolorosa possa essere, è
tuttavia un gioioso sollievo in confronto al sogno.
Ci è permesso dubitare dell'assoluta verità di
questa dichiarazione di Strindberg, ma se in essa
vediamo, non l'astratto di una dottrina, bensì l’idea
stilizzata di un modo di essere che al tempo delle
sue esjierienze naturalistiche nemmeno sospettava
e che si formò in lui nei vuoti lasciati da una realtà
sconfessata.‘non possiamo discuterla nè criticarla.
Se, al termine del suo sforzo sublime e insensato
di superare la materia, il Poeta è caduto nell’incoe-
renza e nella disgregazione, nè l'una cosa nè l'altra
debbono offuscare ai nostri occhi e alla nostra
anima la visione suggestiva della sua Arte.
28


















