
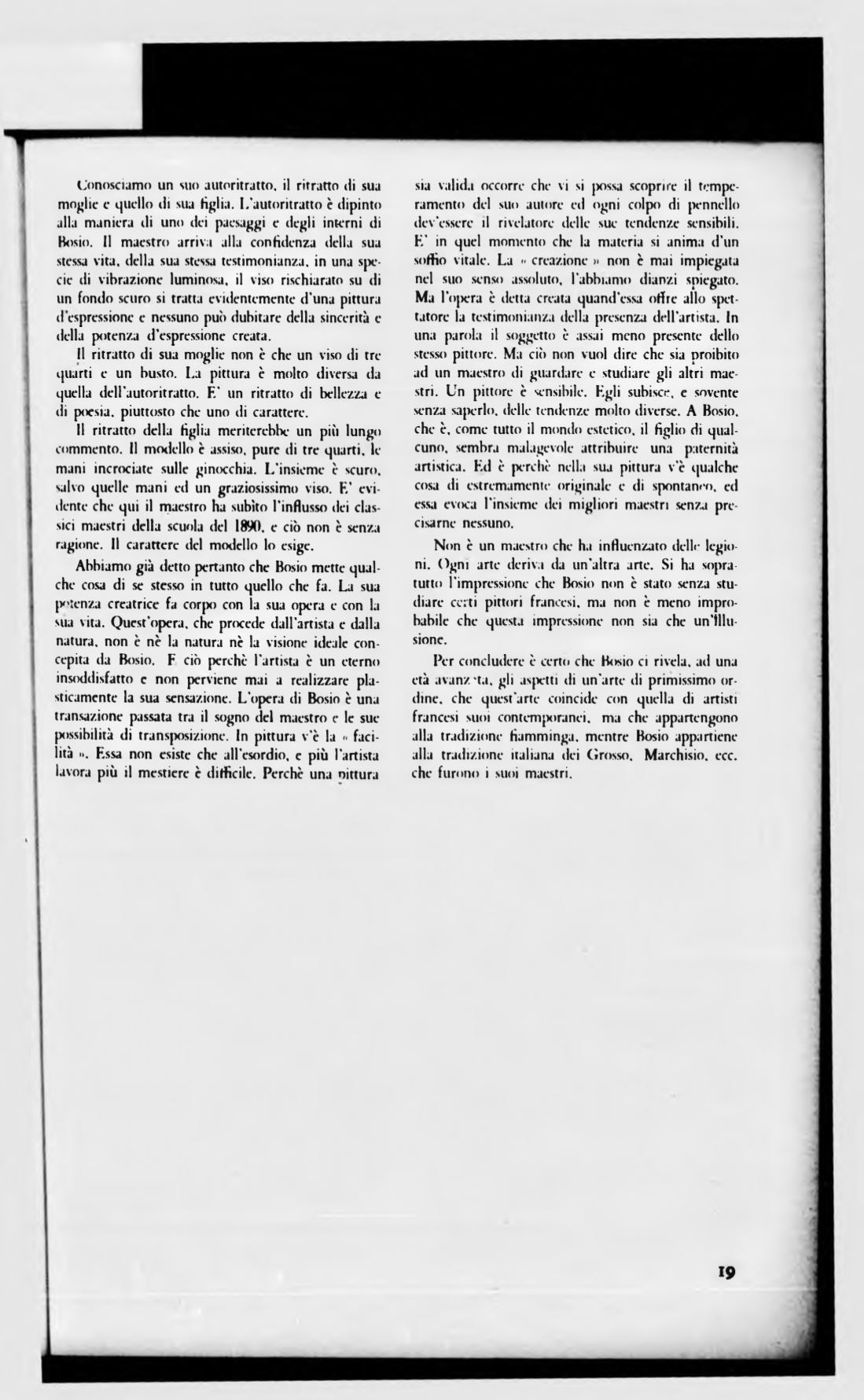
Conosciamo un suo autoritratto, il ritratto ili sua
moglie c quello di sua figlia. I/autoritratto è dipinto
alla maniera ili uno dei paesaggi e degli interni di
Bosio. Il maestro arriva alla confidenza della sua
stessa vita, della sua stessa testimonianza, in una spe
cie di vibrazione luminosa, il viso rischiarato su di
un fondo scuro si tratta evidentemente d’una pittura
d espressione e nessuno può dubitare della sincerità e
della potenza d ’espressione creata.
Il
ritratto di sua moglie non è che un viso di tre
quarti e un busto. La pittura è molto diversa da
quella dell’autoritratto. F.’ un ritratto di bellezza e
di poesia, piuttosto che uno di carattere.
Il
ritratto della figlia meriterebbe un più lungo
commento. Il modello è assiso, pure di tre quarti, le
mani incrociate sulle ginocchia. L ’insieme è scuro,
salvo quelle mani ed un graziosissimo viso. E’ evi
dente che qui il maestro ha subito l’influsso dei clas
sici maestri della scuola del 1890. e ciò non è senza
ragione. Il carattere del modello lo esige.
Abbiamo già detto pertanto che Bosio mette qual
che cosa di se stesso in tutto quello che fa. La sua
potenza creatrice fa corpo con la sua opera e con la
sua vita. Quest’opera, che procede dall’artista e dalla
natura, non è nè la natura nè la visione ideale con
cepita da Bosio. F ciò perchè l’artista è un eterno
insoddisfatto e non perviene mai a realizzare pla
sticamente la sua sensazione. L ’opera di Bosio è una
transazione passata tra il sogno del maestro e le sue
possibilità di transposizione. In pittura v’è la « faci
lità ». Essa non esiste che all’esordio, e più l’artista
lavora più il mestiere è diffìcile. Perchè una oittura
sia valida occorre che vi si possa scoprire il tempe
ramento del suo autore ed ogni colpo di pennello
dev’essere il rivelatore delle sue tendenze sensibili.
E' in quel momento che la materia si anima d’un
soffio vitale. La <« creazione » non è mai impiegata
nel suo senso assoluto, l’abbiamo dianzi spiegato.
Ma l’oj>cra è detta creata quand’essa offre allo spet
tatore la testimonianza della presenza dell’artista. In
una parola il soggetto è assai meno presente dello
stesso pittore. Ma ciò non vuol dire che sia proibito
ad un maestro di guardare e studiare gli altri mae
stri. Un pittore è sensibile. Egli subisce, e sovente
senza saperlo, delle tendenze molto diverse. A Bosio.
che è, come tutto il mondo estetico, il figlio di qual
cuno, sembra malagevole attribuire una paternità
artistica. Ed è perchè nella sua pittura v'è qualche
cosa di estremamente originale e di spontaneo, ed
essa evoca l'insieme dei migliori maestri senza pre
cisarne nessuno.
Non è un maestro che ha influenzato delle legio
ni. Ogni arte deriva da un’altra arte. Si ha sopra
tutto l'impressione che Bosio non è stato senza stu
diare certi pittori francesi, ma non è meno impro
babile che questa impressione non sia che un’illu
sione.
Per concludere è certo che Bosio ci rivela, ad una
età avanz 'ta, gli aspetti di un'arte di primissimo or
dine, che quest'arte coincide con quella di artisti
francesi suoi contemporanei, ma che appartengono
alla tradizione fiamminga, mentre Bosio appartiene
alla tradizione italiana dei Grosso. Marchisio, ecc.
che furono i suoi maestri.
19


















