
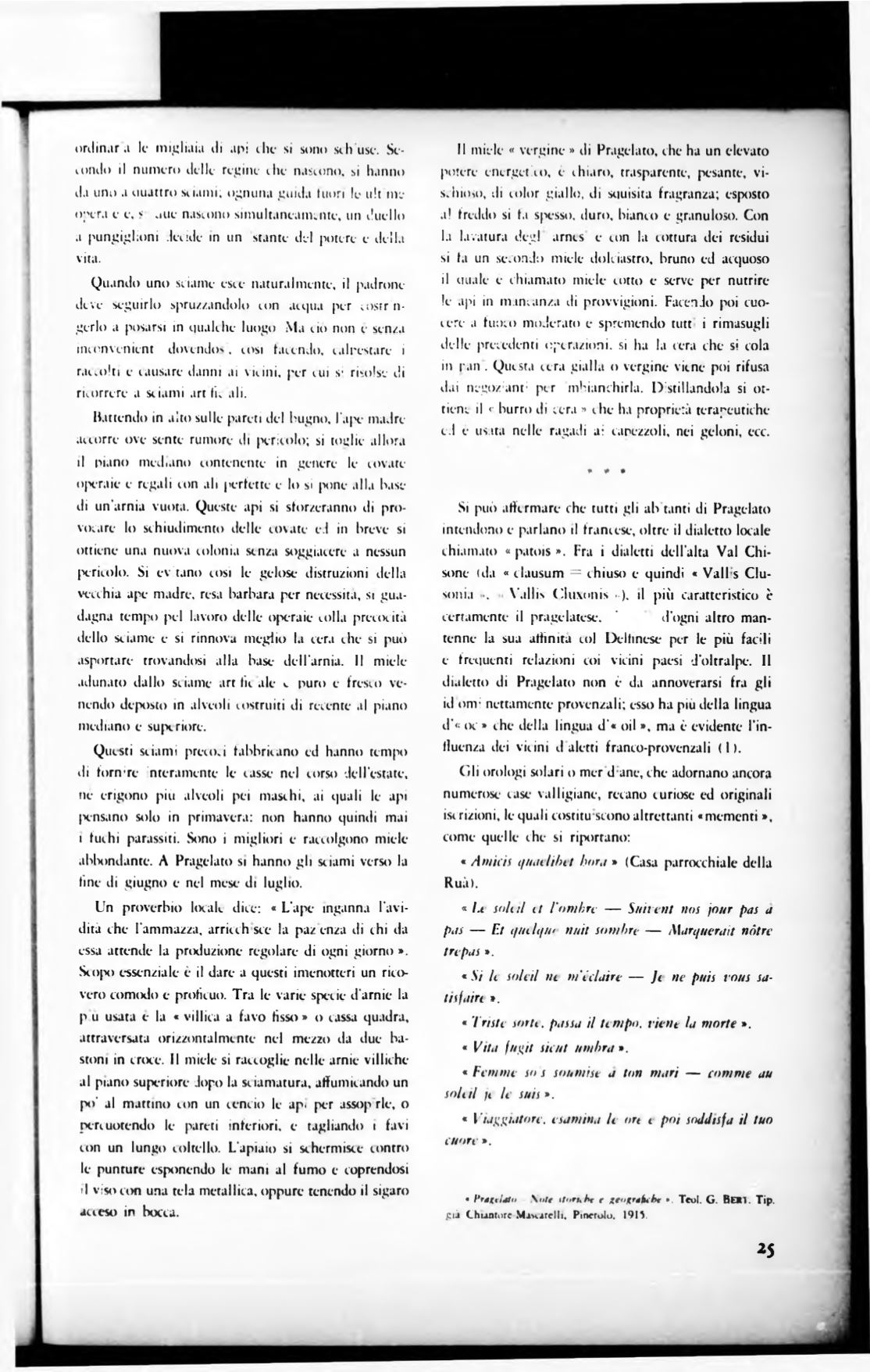
ordinar a le migliaia ili api clic si sono sdì use. Se
condo il numero delle regine die nascono, si hanno
da uno a uuattro sciami; ognuna guida tnon le n!t nu
ocerà e e, « viue nascono simultaneamente, un duello
a pungiglioni decide in un stante del potere e della
vita.
Quando uno sciame esce naturalmente, il padrone
deve seguirlo spruzzandolo lon acqua per lostr n-
gerlo a posarsi in qualche luogo Ma lio non e senza
inennvc-nient dovendo», cosi facendo, calpestare i
raccolti e causare danni ai vicini, per iui s: risolse di
ricorrere a sciami art tic ali.
Battendo in alto sulle pareti del bugno, l'ape madre
accorre ove sente rumore di pericolo; si toulic- allora
il piano mediano contenente in genere le covate
operaie e regali con ali perfette e lo si pone alla basi
di un'arnia vuota. Queste api si sforzeranno di pro
vocare lo schiudimento delle covate ed in breve si
ottiene una nuova colonia senza soggiacere a nessun
pericolo. Si evitano cosi le gelose distruzioni della
vecchia ape madre, resa barbara per necessita, si gua
dagna tempo pel lavoro delle operaie colla precocità
dello sciame e si rinnova meglio la cera clic si può
asportare trovandosi alla base dell'arnia. Il miele-
adunato dallo sciame art fic aie «. puro e fresco ve
nendo deposto in alveoli costruiti di recente al piano
mediano e supcriore.
Questi sciami preco.i fabbricano ed hanno tempo
di forn;re 'meramente le casse nel corso dell'estate,
ne erigono più alveoli pei maschi, ai quali le api
pensano solo in primavera: non hanno quindi mai
i fuchi parassiti. Sono i migliori e raccolgono miele
abbondante. A Pragelato si hanno gli sciami verso la
fine di giugno e nel mese- di luglio.
Un proverbio locale dice: « L’ape inganna l’avi
dità che l'ammazza, arricch scc la paz enza di chi da
essa attende la produzione regolare di ogni giorno ».
Scopo essenziale è il dare a questi imenotteri un rico
vero comodo e proficuo. Tra le varie specie d'arnie la
p u usata e la « villica a favo fisso » o cassa quadra,
attraversata orizzontalmente nel mezzo da due ba
stoni in croce, il miele si raccoglie nelle arnie villiche
al piano supcriore dopo la sciamatura, affumicando un
po’ al mattino con un cencio le ap. per assop rie, o
percuotendo le pareti inferiori, e tagliando i favi
con un lungo coltello. L’apiaio si schermiste contro
le punture esponendo le mani al fumo e coprendosi
il viso con una tela metallica, oppure tenendo il sigaro
acceso in bocca.
Il miele « vergine » ili Pragelato, che ha un elevato
potere energetico, è chiaro, trasparente, pesante, vi-
schioso, di color giallo, di squisita fragranza; esposto
a! freddo si la spesso, duro, bianco e granuloso. Con
la lavatura degl arnes e con la cottura dei residui
si la un secondo miele dolciastro, bruno ed acquoso
il cuiale è chiamato miele cotto e serve per nutrire
le api in mancanza di provvigioni. Facendo poi cuo
cere a fuoco moderato e spremendo tutt i rimasugli
delle precedenti operazioni, si ha la cera che si cola
in rati . Questa cera gialla o vergine viene poi rifusa
dai negoz:ant: per mbianchirla. Distillandola si ot-
tic-nL il <• burro di cera » che ha proprietà terapeutiche
e.l e usata nelle ragadi ai capezzoli, nei geloni, ecc.
# # #
Si può affermare che tutti gli ab tanti di Pragelato
intendono e parlano il francese, oltre il dialetto locale
chiamato « patois ». Fra i dialetti dell'alta Val Chi
sone- (da « dausum = chiuso e quindi « Vall s Clu-
soni.i •. Yallis Cluxonis •■). il più caratteristico è
certamente il pragclatesc. ’
d'ogni altro man
tenne la sua atfinita col Delfinese per le più facili
e frequenti relazioni coi vicini paesi d’oltralpe. Il
dialetto di Pragelato non è da annoverarsi fra gli
id orni nettamente provenzali; esso ha più della lingua
d’« oc » che della lingua d'« oil », ma è evidente l’in
fluenza dei vicini d alerti franco-provenzali (1).
Gli orologi solari o mt-r d ane, che adornano ancora
numerose case valligiani-, recano curiose ed originali
iscrizioni, le quali costitu scono altrettanti «mementi »,
come quelle che si riportano:
«
Amicis (//tiiihhit bora
» (Casa parrocchiale della
Ruà).
«
l.i sfiliti il /'ombre
—
Suivent nos jour pus u
pus
—
Et t///ilt/u< nuit sombre
— Al
uri/uerait nótre
trepus
».
«
Si le soleil iti m'ifluire
—
Ji ne puis vous su
itifairi
».
«
Triste sorte, pussu il tempo, viene lu morte
».
«
Vita
fuy.itsicut umbra
».
«
Femme so s sountise u ton muri
—
camme uu
solai fi le suis
».
«
Vu^t.itore. esuminu le ort
t
poi snddtsfu il tuo
cuore
».
«
PrsgeUlo \ote
iton.hre zeo&réfuht
• . Teul. G.
B E H .
Tip.
pù Chuntorc Misc^rcllt. Ptnerolo. 191V
*5


















