
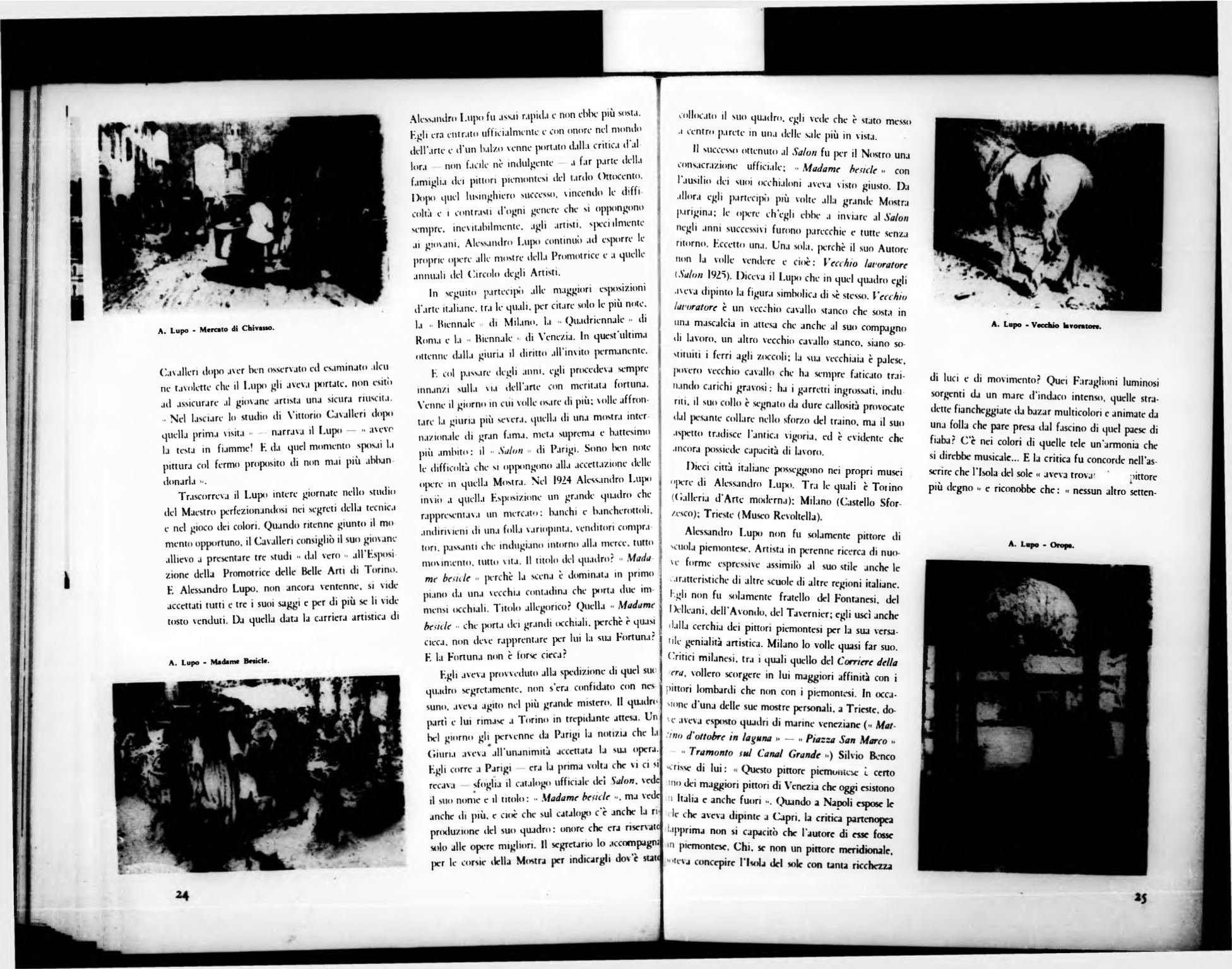
Alessandro Lupo fu assai rapida e non ebbe più sosta.
Egli era entrato ufficialmente e con onore nel mondo
dell'arte e d’un balzo venne portato dalla critica d'al
lora
non facile nè indulgente — a far parte della
famiglia dei pittori piemontesi del tarilo Ottocento.
Dopo quel lusinghiero successo, vincendo le diffi
colta e i contrasti d ’ogni genere che si oppongono
sempre, inevitabilmente, agli artisti, speci ilmente
ai giovani. Alessandro Lupo continuò ad esporre le
proprie opere alle mostre della Promotrice e a quelle
annuali del Circolo degli Artisti.
In seguito partecipò alle maggiori esposizioni
d’arte italiane, tra le quali, per citare solo le più note,
la <• Biennale di Milano, la ■Quadriennale •• di
Roma e la » Biennale > di Venezia. In quest’ultima
ottenne dalla giuria il diritto all’invito permanente.
K col passare degli anni, egli procedeva sempre
innanzi sulla via dell'arte con meritata fortuna.
Venne
il giorno in cui volle osare di più; volle affron
tare la giuria più severa, quella di una mostra inter
nazionale di gran fama, meta suprema e battesimo
più ambito: il »
Salon
di Parigi. Sono ben note
le difficoltà che si oppongono alla accettazione delle
opere in quella Mostra. Nel 1924 Alessandro Lupi
invii) a quella Esposizione un grande quadro che
rappresentava un mercato: banchi e bancherottoli. j
andirivieni di una folla variopinta, venditori compra- j
tori, passanti che indugiano intorno alla merce, tutto j
movimento, tutto vita. Il titolo del quadro? -
Mada
me baule
perchè la scena è dominata in primo ]
piano da una vecchia contadina che porta due ini j
mensi occhiali. Titolo allegorico? Quella ■
Madame
;
besicle •
che porta dei grandi i>cchiali, perchè è quasi
cieca, non deve rapprentare per lui la sua Fortuna?
E la Fortuna non è lorsc cicca?
Egli aveva provveduto alla spedizione di quel suo
quadro segretamente, non s'era confidato con nes
suno. aveva agito nel più grande mistero. Il quadro
partì e lui rimase a Torino in trepidante attesa. Un
bel giorno gli pervenne da Parigi la notizia che la
Giuria aveva all'unanimità accettata la sua opera.
Egli corre a Parigi — era la prima volta chc vi ci si)
recava
sfoglia il catalogo ufficiale dei
Sulon,
vede)
il suo nome e il titolo: »
Madame besicle »,
ma vede]
anche di più. e cioè chc sul catalogo c'è anche la ri-
produzione del suo quadro: onore chc era riservate
solo alle opere migliori. Il segretario lo accompagni
j k t
le corsie della Mostra per indicargli dov’è stat<
collocato il suo quadro, egli vede che è stato messo
a centro parete in una delle sale più in vista.
11 successo ottenuto al
Salon
fu
j k t
il Nostro una
consacrazione ufficiale; •
Madame besicle
» con
l'ausilio dei suoi occhialoni aveva visto giusto. Da
allora egli jxirtccijxò più volte alla grande Mostra
parigina; le
o j k t c
ch’egli ebbe a inviare al
Salon
negli anni successivi furono parecchie c tutte senza
ritorno. Eccetto una. Una sola. jK-rchè il suo Autore
non la volle vendere e cioè:
Vecchio lavoratore
(
Salon
1925). Diceva il Lupo che in quel quadro egli
aveva dipinto la figura simbolica di sè stesso.
Vecchio
lavoratore
è un vecchio cavallo stanco che sosta in
una mascalcìa in attesa che anche al suo compagno
ili lavoro, un altro vecchio cavallo stanco, siano so
stituiti i ferri agli
z ik c o I ì ;
la sua vecchiaia è palese.
jHivcro vecchio cavallo che ha sempre faticato trai
nando carichi gravosi: ha i garretti ingrossati, indu
riti. il suo collo è segnato da dure callosità provocate
dal jK-sante collare nello sforzo del traino, ma il suo
asjKtto tradisce l'antica vigoria, ed è evidente che
ancora possiede capacità di lavoro.
Dieci città italiane jxisseggono nei propri musei
o jk t c
di Alessandro Lup i. Tra le quali è Tot ino
(Galleria d'Arte moderna); Milano (Castello Sfor
/.esco); Trieste (Museo Revoltclla).
Alessandro Lujxj non fu solamente pittore di
scuola piemontese. Artista in perenne ricerca di nuo
ve forme espressive assimilò al suo stile anche le
caratteristiche di altre scuole di altre regioni italiane.
Egli non fu solamente fratello del Fontancsi. del
Dclleani. deH'Avondo, del Tavcrnier; egli uscì anche
dalla cerchia dei pittori piemontesi jxrr la sua versa
tile genialità artistica. Milano lo volle quasi far suo.
Critici milanesi, tra i quali quello del
Corriere della
era.
vollero scorgere in lui maggiori affinità con i
•pittori lombardi che non con i piemontesi. In occa
sione d'una delle sue mostre personali, a Trieste, do
ve aveva espisto quadri di manne veneziane («
Mat
tino d'ottobre in laguna
» — <■
Piazza San Marco »
"
Tramonto sul Canal Grande
>•) Silvio Benco
scrisse di lui : Questo pittore piemontese l certo
ino dei maggiori pittori di Venezia chc oggi esistono
ii Italia e anche fuori ». Quando a Napoli espose le
le che aveva dipinte a Capri, la critica partenopea
lapprima non si capacitò che l'autore di
esse fosse
m piemontese. Chi. se non un pittore meridionale,
•"teva concepire l ’isola del sole con tanta ricchezza
Cavalieri dojio aver ben osservato ed esaminato alcu
ne tavolette che il L up i gli aveva jxjrtate, non esitò
ad assicurare al giovane artista una sicura riuscita.
" Nel lasciare lo studio di Vittorio Cavalieri dopi
quella prima visita • — narrava il Lup i — <• avevo
la testa in fiamme! E da quel momento sjiosai la
pittura col fermo projjosito di non mai più abban
donarla ».
Trascorreva il Lup> intere giornate nello studio
del Maestro perfezionandosi nei segreti della tecnica
e nel gioco dei colori. Quando ritenne giunto il mo
mento opjiortuno. il Cavalieri consigliò il suo giovane
allievo a presentare tre studi <• dal vero » all’Esposi-
zione della Promotrice delle Belle Arti di Torino.
E Alessandro Lupo, non ancora ventenne, si vide
accettati tutti e tre i suoi saggi e
j k t
di più se li vide
tosto venduti. Da quella data la carriera artistica di
A . Lupo - Madame Besicle.
A . Lupo - Mercato di Chivasto.
A. Lupo -Vecchio lavoratore.
di luci e di movimento? Quei Faraglioni luminosi
sorgenti da un mare d'indaco intenso, quelle stra-
dette fiancheggiate da bazar multicolori e animate da
una folla che pare presa dal fascino di quel paese di
fiaba? C ’è nei colori di quelle tele un’armonia che
si direbbe musicale... E la critica fu concorde nell’as-
serirc chc l’isola del sole « aveva trova’
-littore
più degno » c riconobbe che : « nessun altro setten-
A. Lupo - Oropa.


















