
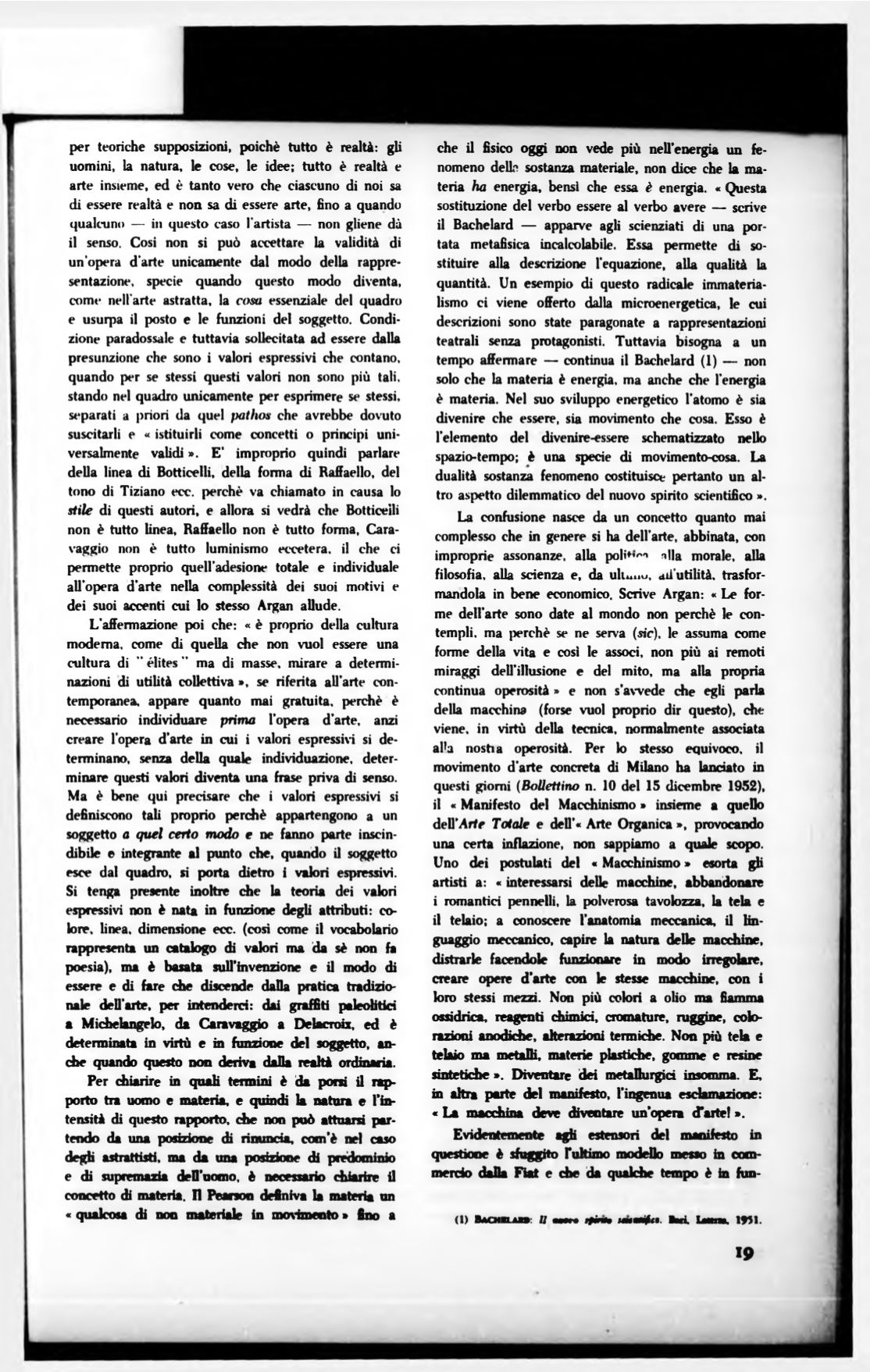
per teoriche supposizioni, poiché tutto è realtà: gli
uomini, la natura, le cose, le idee; tutto è realtà e
arte insieme, ed è tanto vero che ciascuno di noi sa
di essere realtà e non sa di essere arte, fino a quando
qualcuno — in questo caso l'artista — non gliene dà
il senso. Cosi non si può accettare la validità di
un'opera d'arte unicamente dal modo della rappre
sentazione, specie quando questo modo diventa,
come neH'arte astratta, la
cosa
essenziale del quadro
e usurpa il posto e le funzioni del soggetto. Condi
zione paradossale e tuttavia sollecitata ad essere dalla
presunzione che sono i valori espressivi che contano,
quando per se stessi questi valori non sono più tali,
stando nel quadro unicamente per esprimere se stessi,
separati a priori da quel
pathos
che avrebbe dovuto
suscitarli e « istituirli come concetti o principi uni
versalmente validi ». E' improprio quindi parlare
della linea di Botticelli, della forma di Raffaello, del
tono di Tiziano ecc. perchè va chiamato in causa lo
stile
di questi autori, e allora si vedrà che Botticelli
non è tutto linea, Raffaello non è tutto forma, Cara
vaggio non è tutto luminismo eccetera, il che ci
permette proprio quell’adesione totale e individuale
all'opera d’arte nella complessità dei suoi motivi e
dei suoi accenti cui lo stesso Argan allude.
L'affermazione poi che: « è proprio della cultura
moderna, come di quella die non vuol essere una
cultura di ” élites ” ma di masse, mirare a determi
nazioni di utilità collettiva », se riferita all’arte con
temporanea, appare quanto mai gratuita, perchè è
necessario individuare
prima
l’opera d’arte, anzi
creare l’opera d’arte in cui i valori espressivi si de
terminano, senza della quale individuazione, deter
minare questi valori diventa una frase priva di senso.
Ma è bene qui precisare che i valori espressivi si
definiscono tali proprio perchè appartengono a un
soggetto
a quel certo modo e
ne fanno parte inscin
dibile e integrante al punto che, quando il soggetto
esce dal quadro, si porta dietro i valori espressivi.
Si tenga presente inoltre che la teoria dei valori
espressivi non è nata in funzione degli attributi: co
lore, linea, dimensione ecc. (così come il vocabolario
rappresenta un catalogo di valori ma da sè non fa
poesia), ma i basata sull’invenzione e il modo di
essere e di fare die discende dalla pratica tradizio
nale dell'arte, per intenderci: dai graffiti paleolitici
a Michelangelo, da Caravaggio a Delacroix, ed è
determinata in virtù e in funzione del soggetto, an
che quando questo non deriva dalla realtà ordinaria.
Per chiarire in quali termini è da porsi il rap
porto tra uomo e materia, e quindi la natura e l’in
tensità di questo rapporto, die non può attuarsi par
tendo da una posizione di rinuncia, com’è nel caso
degli astrattisti, ma da una posizione di predominio
e di supremazia dell’uomo, è necessario chiarire il
concetto di materia. Il Pearson definiva la materia un
« qualcosa di non materiale in movimento » fino a
che il fisico oggi non vede più nell’energia un fe
nomeno dell? sostanza materiale, non dice che la ma
teria
ha
energia, bensì che essa
è
energia. « Questa
sostituzione del verbo essere al verbo avere — scrive
il Bachelard — apparve agli scienziati di una por
tata metafisica incalcolabile. Essa permette di so
stituire alla descrizione l'equazione, alla qualità la
quantità. Un esempio di questo radicale immateria
lismo ci viene offerto dalla microenergetica, le cui
descrizioni sono state paragonate a rappresentazioni
teatrali senza protagonisti. Tuttavia bisogna a un
tempo affermare — continua il Bachelard (1) — non
solo che la materia è energia, ma anche che l'energia
è materia. Nel suo sviluppo energetico l’atomo è sia
divenire che essere, sia movimento che cosa. Esso è
l’elemento del divenire-essere schematizzato nello
spazio-tempo; è una specie di movimento-cosa. La
dualità sostanza fenomeno costituisce pertanto un al
tro aspetto dilemmatico del nuovo spirito scientifico ».
La confusione nasce da un concetto quanto mai
complesso che in genere si ha dell’arte, abbinata, con
improprie assonanze, alla poli*'''1’ nlla morale, alla
filosofia, alla scienza e, da ulut.u, disutilità, trasfor
mandola in bene economico. Scrive Argan: « Le for
me dell’arte sono date al mondo non perchè le con
templi. ma perchè se ne serva
(sic),
le assuma come
forme della vita e così le associ, non più ai remoti
miraggi dell’illusione e del mito, ma alla propria
continua operosità » e non s’avvede che egli parla
della macchina (forse vuol proprio dir questo), che
viene, in virtù della tecnica, normalmente associata
al’a nostia operosità. Per lo stesso equivoco, il
movimento d’arte concreta di Milano ha lanciato in
questi giorni (
Bollettino
n. 10 del 15 dicembre 1952),
il « Manifesto del Macchinismo » insieme a quello
delTArfe
Totale
e dell’« Arte Organica », provocando
una certa inflazione, non sappiamo a quale scopo.
Uno dei postulati del « Macchinismo » esorta gli
artisti a: « interessarsi delle macchine, abbandonare
i romantici pennelli, la polverosa tavolozza, la tela e
il telaio; a conoscere l’anatomia meccanica, il lin
guaggio meccanico, capire la natura delle macchine,
distrarle facendole funzionare in modo irregolare,
creare opere d’arte con le stesse macchine, con i
loro stessi mezzi. Non più colori a olio ma fiamma
ossidrica, reagenti chimici, cromature, ruggine, colo
razioni anodiche, alterazioni termiche. Non più tela e
telaio ma metalli, materie plastiche, gomme e resine
sintetiche ». Diventare dei metallurgici insomma. E,
in altra parte del manifesto, l’ingenua esclamazione:
« La macchina deve diventare un’opera d’arte! ».
Evidentemente agli estensori del manifesto in
questione è sfuggito l'ultimo modello messo in com
mercio dalla Fiat e che da qualche tempo
è
in fun-
(!) Bachila*©:
Il
«mto
ifinto umwmftti.
lari. Urna. 19)1.
19


















