
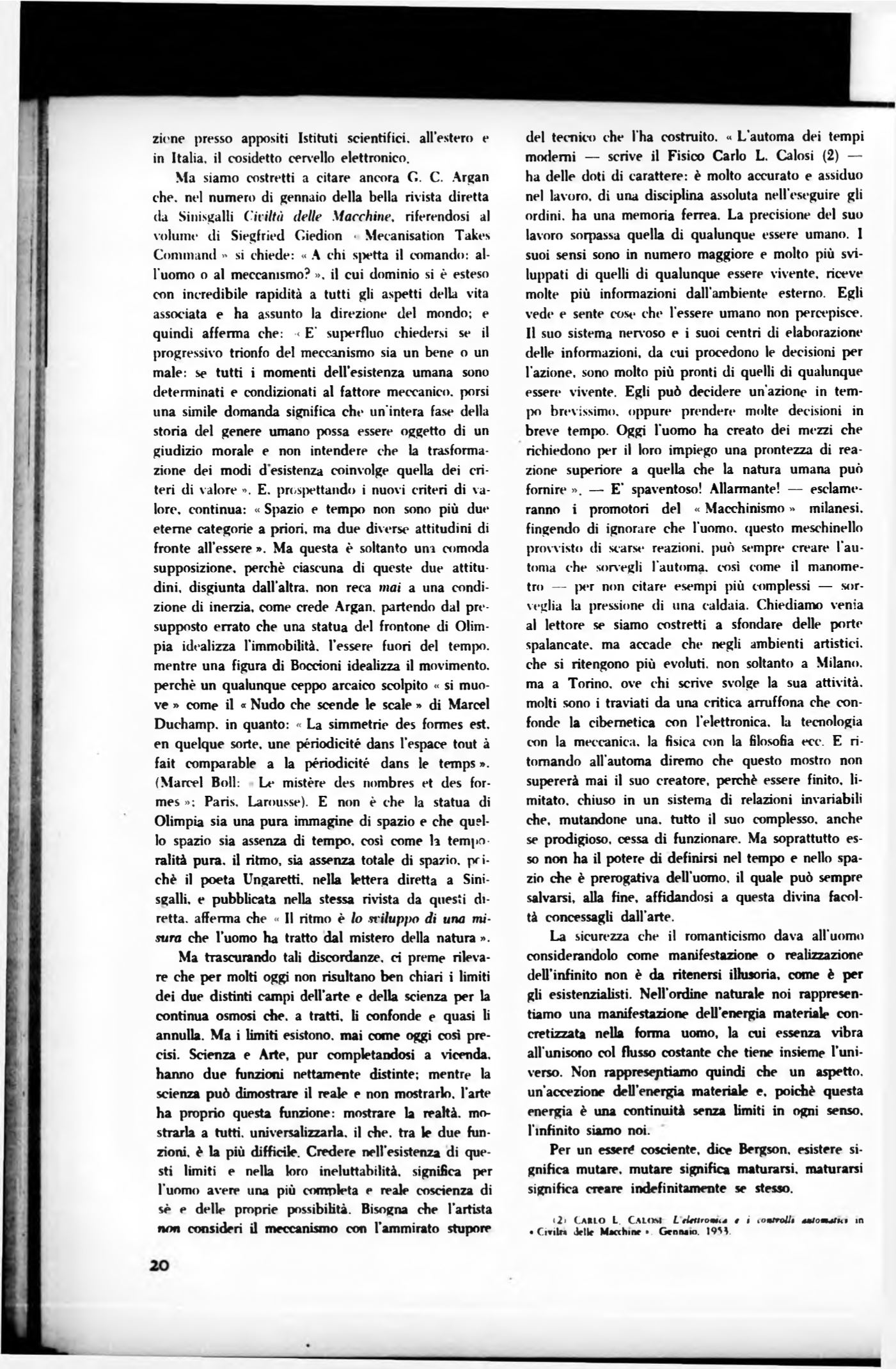
zione presso appositi Istituti scientifici, all’estero e
in Italia, il cosidetto cervello elettronico.
Ma siamo costretti a citare ancora C. C. Argan
che. nel numero di gennaio della bella rivista diretta
da Sinisgalli
Civiltà delle Macchine
, riferendosi al
volume di Siegfried Ciedion • Mecanisation Takes
Gommami » si chiede: « A chi spetta il comando: al
l’uomo o al meccanismo? », il cui dominio si è esteso
con incredibile rapidità a tutti gli aspetti della vita
associata e ha assunto la direzione del mondo; e
quindi afferma che: ■<E’ superfluo chiedersi se il
progressivo trionfo del meccanismo sia un bene o un
male: se tutti i momenti dell*esistenza umana sono
determinati e condizionati al fattore meccanico, porsi
una simile domanda significa che un’intera fase della
storia del genere umano possa essere oggetto di un
giudizio morale e non intendere che la trasforma
zione dei modi d esistenza coinvolge quella dei cri
teri di valore ». E. prospettando i nuovi criteri di va
lore. continua: « Spazio e tempo non sono più due
eterne categorie a priori, ma due diverse attitudini di
fronte all’essere ». Ma questa è soltanto una comoda
supposizione, perchè ciascuna di queste due attitu
dini, disgiunta dall'altra, non reca
mai
a una condi
zione di inerzia, come crede Argan. partendo dal pre
supposto errato che una statua del frontone di Olim
pia idealizza l’immobilità. Tessere fuori del tempo,
mentre una figura di Boccioni idealizza il movimento,
perchè un qualunque ceppo arcaico scolpito « si muo
ve » come il « Nudo che scende le scale » di Marcel
Duchamp. in quanto: « La simmetrie des formes est.
en quelque sorte, une périodicitè dans l’espace tout à
fait comparable a la périodicitè dans le temps ».
(Marcel Boll: Le mistère des nombres et des for
mes »: Paris, Larousse). E non è che la statua di
Olimpia sia una pura immagine di spazio e che quel
lo spazio sia assenza di tempo, così come h tempo
ralità pura, il ritmo, sia assenza totale di spazio, poi
ché il poeta Ungaretti, nella lettera diretta a Sini
sgalli. e pubblicata nella stessa rivista da questi di
retta. afferma che « Il ritmo è
lo sviluppo di una mi
sura
che l’uomo ha tratto dal mistero della natura ».
Ma trascurando tali discordanze, ci preme rileva
re che per molti oggi non risultano ben chiari i limiti
dei due distinti campi dell’arte e della scienza per la
continua osmosi che. a tratti. li confonde e quasi li
annulla. Ma i limiti esistono, mai come oggi così pre
cisi. Scienza e Arte, pur completandosi a vicenda,
hanno due funzioni nettamente distinte; mentre la
scienza può dimostrare il reale e non mostrarlo, l’arte
ha proprio questa funzione: mostrare la realtà, mo
strarla a tutti, universalizzarla, il che. tra le due fun
zioni, è la più difficile. Credere nell’esistenza di que
sti limiti e nella loro ineluttabilità, significa per
l’uomo avere una più completa e reale coscienza di
sè e delle proprie possibilità. Bisogna che l’artista
non
consideri il meccanismo con l’ammirato stupore
del tecnico che l’ha costruito. « L'automa dei tempi
moderni — scrive il Fisico Carlo L. Calosi (2) —
ha delle doti di carattere: è molto accurato e assiduo
nel lavoro, di una disciplina assoluta nell'eseguire gli
ordini, ha una memoria ferrea. La precisione del suo
lavoro sorpassa quella di qualunque essere umano. I
suoi sensi sono in numero maggiore e molto più svi
luppati di quelli di qualunque essere vivente, riceve
molte più informazioni dall’ambiente esterno. Egli
vedi* e sente cose che l’essere umano non percepisce.
Il suo sistema nervoso e i suoi centri di elaborazione
delle informazioni, da cui procedono le decisioni per
l’azione, sono molto più pronti di quelli di qualunque
essere vivente. Egli può decidere un’azione in tem
po brevissimo, oppure prendere molte decisioni in
breve tempo. Oggi l’uomo ha creato dei mezzi che
richiedono per il loro impiego una prontezza di rea
zione superiore a quella che la natura umana può
fornire ». — E’ spaventoso! Allarmante! — esclame
ranno i promotori del « Macchinismo » milanesi,
fingendo di ignorare che l’uomo, questo meschinello
provvisto di scarse reazioni, può sempre creare l’au
toma che sorvegli l'automa, cosi come il manome
tro — per non citare esempi più complessi — sor
veglia la pressione di una caldaia. Chiediamo venia
al lettore se siamo costretti a sfondare delle porte
spalancate, ma accade che negli ambienti artistici,
che si ritengono più evoluti, non soltanto a Milano,
ma a Torino, ove chi scrive svolge la sua attività,
molti sono i traviati da una critica arruffona che con
fonde la cibernetica con l’elettronica, la tecnologia
con la meccanica, la fisica con la filosofia ecc. E ri
tornando all'automa diremo che questo mostro non
supererà mai il suo creatore, perchè essere finito, li
mitato. chiuso in un sistema di relazioni invariabili
che, mutandone una. tutto il suo complesso, anche
se prodigioso, cessa di funzionare. Ma soprattutto es
so non ha il potere di definirsi nel tempo e nello spa
zio die è prerogativa dell’uomo, il quale può sempre
salvarsi, alla fine, affidandosi a questa divina facol
tà concessagli dall'arte.
La sicurezza che il romanticismo dava all'uomo
considerandolo come manifestazione o realizzazione
dell’infinito non è da ritenersi illusoria, come è per
gli esistenzialisti. NeH’ordine naturale noi rappresen
tiamo una manifestazione dell’energia materiale con
cretizzata nella forma uomo, la cui essenza vibra
all’unisono col flusso costante che tiene insieme l’uni
verso. Non rappresepriamo quindi che un aspetto,
un’accezione dell’energia materiale e. poiché questa
energia è una continuità senza limiti in ogni senso,
l’infinito siamo noi.
Per un esseré cosciente, dice Bergson, esistere si
gnifica mutare, mutare significa maturarsi, maturarsi
significa creare indefinitamente se stesso.
i 2 ‘ CARLO L. C a lo s i
L e U tlro m u t i in n tro lli éU tom utnt
in
• Civiltà
ilelle Macchine ». Gennaio.
19SV


















